Terrorismo e iconoclastia
C’è stato un tempo, neanche tanto lontano, in cui si urlava al No Logo. Si consideravano i marchi di fabbrica responsabili – simbolici ma non per questo meno efferati – di tutti i mali del mondo. E li si distruggeva, fisicamente prima ancora che spiritualmente, per ogni dove questi logo si presentavano: nei cartelloni pubblicitari, nelle vetrine, nei capi d’abbigliamento.
C’era chi di nascosto toglieva il coccodrillo alle magliette, ma c’era anche chi apertamente bruciava i pannelli delle pompe di benzina o le insegne dei ristoranti di cibo veloce. Per una strana congiuntura economico-culturale si costruiva entro una unica configurazione un Nemico fatto di multinazionali del petrolio e hamburger nauseabondi, look arciglamour e sneakers d’ordinanza, senza dimenticare la bolla informatica e i suoi mentori industriali. In Italia, nella Genova d’inizio millennio, si sono celebrati gli involontari funerali di tutto ciò. E oggi si ripiega sulle talpe che trivellano le montagne alpine per far accelerare i convogli ferroviari che devono sfrecciare, per volere di chissà chi, lungo le nuove vie commerciali d’Europa.

Ma sul logo è rimasta l’ombra del sospetto, come se quelle griffe che vestono i corpi di tutti noi, volenti o nolenti, e più in generale quei disegnini immancabilmente presenti sulle merci di ogni tipo e natura, natura compresa, fossero i depositari di quel feticismo dietro cui si nasconde l’oppressione capitalistica dell’uomo sull’uomo teorizzata, duecento anni fa, da un genio solitario dalla pessima reputazione.
Ma i logo, poracci, che c’entrano? Perché accanirsi contro questi simboletti che schiere di grafici e designer, strateghi della comunicazione e direttori aziendali mandano in giro, indifesi, per il mondo – pronti a essere esibiti, consumati, riesumati, interpretati, distrutti? La ragione certo c’è, e non sta tanto nel capitalismo, e nemmeno in quel suo avatar mediatico che è il sistema dei brand. Sta in qualcosa di molto diverso, al tempo stesso più profondo e più leggero che è, molto semplicemente, lo statuto semiotico dell’immagine. Come ci hanno da tempo spiegato i grandi teorici del visivo, da Panofsky a Gombrich, da Freedberg a Marin e a Elkins, un’immagine, qualsiasi immagine, sia essa artistica o meno, prima ancora di rappresentare qualcosa del mondo si presenta in esso, è un oggetto fra gli altri, una cosa che non sta lì soltanto a dire o a simboleggiare ma semmai agisce, fa, colpisce, trasforma.

Il famigerato potere delle immagini consiste nel fatto che esse sono, appunto, potenti, talvolta prepotenti, e spesso hanno lo stesso medesimo peso, se non maggiore, delle armi. Uccide più il pennello che la spada. Ragion per cui risorge ciclicamente l’iconoclastia, che alle immagini/armi accanitamente si oppone, ora vincendo ora perdendo, ma in ogni caso innescando una guerra senza quartiere nella quale, alla fine, a rimetterci non sono le immagini ma noi che le facciano, le guardiamo, le subiamo, le sopportiamo con malcelato fastidio.
La forma più recente dell’iconoclastia è stato insomma il movimento No Logo, analogo nei gesti e negli esiti a coloro i quali gettavano via le statue dei santi dalle chiese cristiane in piena rivoluzione francese, quelle di Lenin e Stalin dalle piazze dopo la caduta del muro di Berlino, o quelle di Buddha dagli anfratti afghani in pieno delirio talebano. Cattelan, al confronto, è un improvvisatore.

Tutto questo per dire che è appena uscito un libro che non potrà che mettere di buon umore Naomi Klein, autrice della celebre bibbia mondiale dei no global intitolata appunto No Logo, e con lei gli iconoclasti di risulta che, come rinnovati fantasmi, ancora s’aggirano per l’Europa e oltre. L’hanno messo insieme Artur Beifuss e Francesco Trivini Bellini, s’intitola Branding Terror. Loghi e iconografia di gruppi di rivolta e organizzazioni terroristiche, ed è pubblicato – guarda caso – dalle edizioni del Sole-24ore (pp. 336, € 27,90) con una prefazione di Steven Heller. Si tratta della più completa raccolta di marchi dei gruppi terroristici di tutto il mondo, da al-Quaeda al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, dai Tamil Tigers alle nostrane Brigate rosse e tante altre gradevolezze.

Si ricostruisce brevemente la storia di questa miriade di gruppi e gruppuscoli, e se ne presenta il logo, descrivendone caratteristiche grafiche e valori simbolici. Una vera e propria miniera semiotica, che si riallaccia a un’operazione analoga fatta alcuni anni fa nel blog Ironic sans su cui eravamo caduti – incuriositi – un po’ per caso, dove si proponeva un dibattito ancora oggi di grande richiamo.
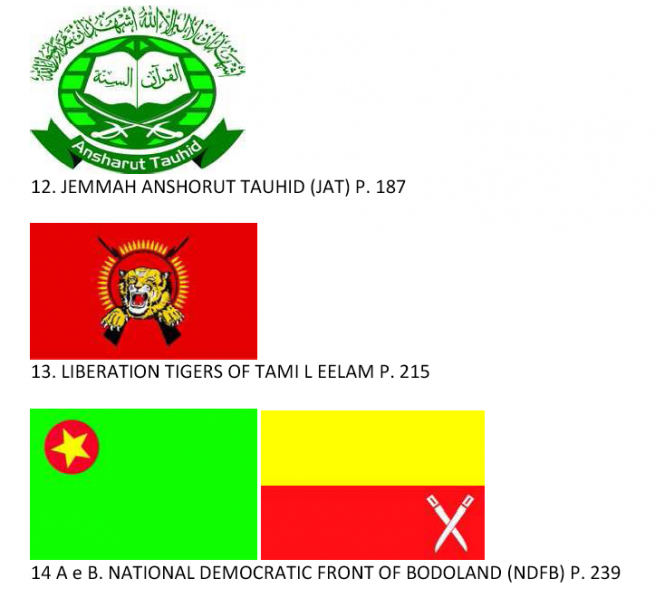
La ragione di questa raccolta e del suo interesse, nella sua lapidaria, sconvolgente chiarezza, è esplicitata nell’introduzione di Beifuss: il terrorismo è un vero e proprio processo di comunicazione, che non solo fa uso dei media ma esiste, in quanto tale, se i media già esistono prima di lui, in qualche modo generandolo. Un attentato è un segno con precisi significati di promozione di una determinata ideologia, non un atto di violenza fine a se stesso. Al punto che, per quanto sia antipatico dirlo, un fattaccio come quello di cui è stato protagonista Anders Breivik potrebbe essere letto come un’eclatante operazione di lancio del suo ‘manifesto politico’ dal giorno dopo scaricabile da Internet.
Così, i gruppi terroristici sono grandi produttori di segni, alla stregua delle aziende commerciali o delle istituzioni pubbliche, e come tali devono saperli maneggiare con cura, ai propri fini specifici, di tipo, appunto, promozionale e comunicativo. Analogamente a qualsiasi brand, la scelta dei logo, per essi, non è accessoria ma consustanziale. Lo dice anche Heller nella prefazione con grande chiarezza: “questi gruppi terroristici sono tutti marchi, e ottengono una certa possibilità di sopravvivenza grazie a metodi legati al branding.

Il branding è uno strumento senza coscienza o moralità; può essere usato a scopi sia positivi sia negativi, a volte in contemporanea”. E così come ogni brand lavora per eliminare ogni possibile divario fra l’identità di sé che tende a veicolare e l’immagine che ne viene percepita dal pubblico, analogamente i terroristi devono saper usare, coi kalashnikov, un po’ di Illustrator e di Photoshop per gestire la comunicazione visiva del proprio gruppuscolo armato. Lo fanno bene, male, un po’ e un po’? Vista l’estrema povertà del repertorio figurativo, cromatico e formale messo in gioco in questi logo (stelle, bandiere, falci e martello, pistole, fucili che s’incrociano, fari, scritte… pochissimo altro) si direbbe abbastanza male. Spiccano, a mo’ di controesempio, i tedeschi della Baader Meinhof, banali nella scelta dei simboli e tuttavia eccellenti nella loro resa grafica.
Ma uno studio più approfondito sugli aspetti visivi di questo materiale, c’è da scommetterci, non sarebbe privo di sorprese. Per esempio: a una prima occhiata, si ha una forte impressione di uniformità; la maggior parte dei logo sembrano proprio assomigliarsi fra loro. Ma un vero logo, oltre a far accoliti, deve sapersi distinguere dai concorrenti, diretti e indiretti. Una delle sue prime qualità è la differenziazione. Sorge così una strana contraddizione fra l’enorme quantità dei gruppi terroristici esistenti, fatemelo dire, sul mercato, e la riproposizione sempre uguale dei loro segni. Che dicano tutti la stessa cosa?
C’era chi di nascosto toglieva il coccodrillo alle magliette, ma c’era anche chi apertamente bruciava i pannelli delle pompe di benzina o le insegne dei ristoranti di cibo veloce. Per una strana congiuntura economico-culturale si costruiva entro una unica configurazione un Nemico fatto di multinazionali del petrolio e hamburger nauseabondi, look arciglamour e sneakers d’ordinanza, senza dimenticare la bolla informatica e i suoi mentori industriali. In Italia, nella Genova d’inizio millennio, si sono celebrati gli involontari funerali di tutto ciò. E oggi si ripiega sulle talpe che trivellano le montagne alpine per far accelerare i convogli ferroviari che devono sfrecciare, per volere di chissà chi, lungo le nuove vie commerciali d’Europa.

Ma sul logo è rimasta l’ombra del sospetto, come se quelle griffe che vestono i corpi di tutti noi, volenti o nolenti, e più in generale quei disegnini immancabilmente presenti sulle merci di ogni tipo e natura, natura compresa, fossero i depositari di quel feticismo dietro cui si nasconde l’oppressione capitalistica dell’uomo sull’uomo teorizzata, duecento anni fa, da un genio solitario dalla pessima reputazione.
Ma i logo, poracci, che c’entrano? Perché accanirsi contro questi simboletti che schiere di grafici e designer, strateghi della comunicazione e direttori aziendali mandano in giro, indifesi, per il mondo – pronti a essere esibiti, consumati, riesumati, interpretati, distrutti? La ragione certo c’è, e non sta tanto nel capitalismo, e nemmeno in quel suo avatar mediatico che è il sistema dei brand. Sta in qualcosa di molto diverso, al tempo stesso più profondo e più leggero che è, molto semplicemente, lo statuto semiotico dell’immagine. Come ci hanno da tempo spiegato i grandi teorici del visivo, da Panofsky a Gombrich, da Freedberg a Marin e a Elkins, un’immagine, qualsiasi immagine, sia essa artistica o meno, prima ancora di rappresentare qualcosa del mondo si presenta in esso, è un oggetto fra gli altri, una cosa che non sta lì soltanto a dire o a simboleggiare ma semmai agisce, fa, colpisce, trasforma.

Il famigerato potere delle immagini consiste nel fatto che esse sono, appunto, potenti, talvolta prepotenti, e spesso hanno lo stesso medesimo peso, se non maggiore, delle armi. Uccide più il pennello che la spada. Ragion per cui risorge ciclicamente l’iconoclastia, che alle immagini/armi accanitamente si oppone, ora vincendo ora perdendo, ma in ogni caso innescando una guerra senza quartiere nella quale, alla fine, a rimetterci non sono le immagini ma noi che le facciano, le guardiamo, le subiamo, le sopportiamo con malcelato fastidio.
La forma più recente dell’iconoclastia è stato insomma il movimento No Logo, analogo nei gesti e negli esiti a coloro i quali gettavano via le statue dei santi dalle chiese cristiane in piena rivoluzione francese, quelle di Lenin e Stalin dalle piazze dopo la caduta del muro di Berlino, o quelle di Buddha dagli anfratti afghani in pieno delirio talebano. Cattelan, al confronto, è un improvvisatore.

Tutto questo per dire che è appena uscito un libro che non potrà che mettere di buon umore Naomi Klein, autrice della celebre bibbia mondiale dei no global intitolata appunto No Logo, e con lei gli iconoclasti di risulta che, come rinnovati fantasmi, ancora s’aggirano per l’Europa e oltre. L’hanno messo insieme Artur Beifuss e Francesco Trivini Bellini, s’intitola Branding Terror. Loghi e iconografia di gruppi di rivolta e organizzazioni terroristiche, ed è pubblicato – guarda caso – dalle edizioni del Sole-24ore (pp. 336, € 27,90) con una prefazione di Steven Heller. Si tratta della più completa raccolta di marchi dei gruppi terroristici di tutto il mondo, da al-Quaeda al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, dai Tamil Tigers alle nostrane Brigate rosse e tante altre gradevolezze.

Si ricostruisce brevemente la storia di questa miriade di gruppi e gruppuscoli, e se ne presenta il logo, descrivendone caratteristiche grafiche e valori simbolici. Una vera e propria miniera semiotica, che si riallaccia a un’operazione analoga fatta alcuni anni fa nel blog Ironic sans su cui eravamo caduti – incuriositi – un po’ per caso, dove si proponeva un dibattito ancora oggi di grande richiamo.
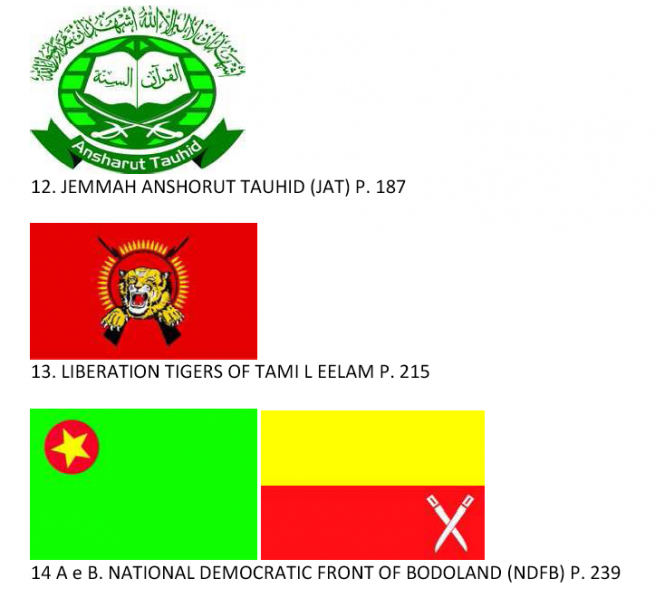
La ragione di questa raccolta e del suo interesse, nella sua lapidaria, sconvolgente chiarezza, è esplicitata nell’introduzione di Beifuss: il terrorismo è un vero e proprio processo di comunicazione, che non solo fa uso dei media ma esiste, in quanto tale, se i media già esistono prima di lui, in qualche modo generandolo. Un attentato è un segno con precisi significati di promozione di una determinata ideologia, non un atto di violenza fine a se stesso. Al punto che, per quanto sia antipatico dirlo, un fattaccio come quello di cui è stato protagonista Anders Breivik potrebbe essere letto come un’eclatante operazione di lancio del suo ‘manifesto politico’ dal giorno dopo scaricabile da Internet.
Così, i gruppi terroristici sono grandi produttori di segni, alla stregua delle aziende commerciali o delle istituzioni pubbliche, e come tali devono saperli maneggiare con cura, ai propri fini specifici, di tipo, appunto, promozionale e comunicativo. Analogamente a qualsiasi brand, la scelta dei logo, per essi, non è accessoria ma consustanziale. Lo dice anche Heller nella prefazione con grande chiarezza: “questi gruppi terroristici sono tutti marchi, e ottengono una certa possibilità di sopravvivenza grazie a metodi legati al branding.

Il branding è uno strumento senza coscienza o moralità; può essere usato a scopi sia positivi sia negativi, a volte in contemporanea”. E così come ogni brand lavora per eliminare ogni possibile divario fra l’identità di sé che tende a veicolare e l’immagine che ne viene percepita dal pubblico, analogamente i terroristi devono saper usare, coi kalashnikov, un po’ di Illustrator e di Photoshop per gestire la comunicazione visiva del proprio gruppuscolo armato. Lo fanno bene, male, un po’ e un po’? Vista l’estrema povertà del repertorio figurativo, cromatico e formale messo in gioco in questi logo (stelle, bandiere, falci e martello, pistole, fucili che s’incrociano, fari, scritte… pochissimo altro) si direbbe abbastanza male. Spiccano, a mo’ di controesempio, i tedeschi della Baader Meinhof, banali nella scelta dei simboli e tuttavia eccellenti nella loro resa grafica.
Ma uno studio più approfondito sugli aspetti visivi di questo materiale, c’è da scommetterci, non sarebbe privo di sorprese. Per esempio: a una prima occhiata, si ha una forte impressione di uniformità; la maggior parte dei logo sembrano proprio assomigliarsi fra loro. Ma un vero logo, oltre a far accoliti, deve sapersi distinguere dai concorrenti, diretti e indiretti. Una delle sue prime qualità è la differenziazione. Sorge così una strana contraddizione fra l’enorme quantità dei gruppi terroristici esistenti, fatemelo dire, sul mercato, e la riproposizione sempre uguale dei loro segni. Che dicano tutti la stessa cosa?
