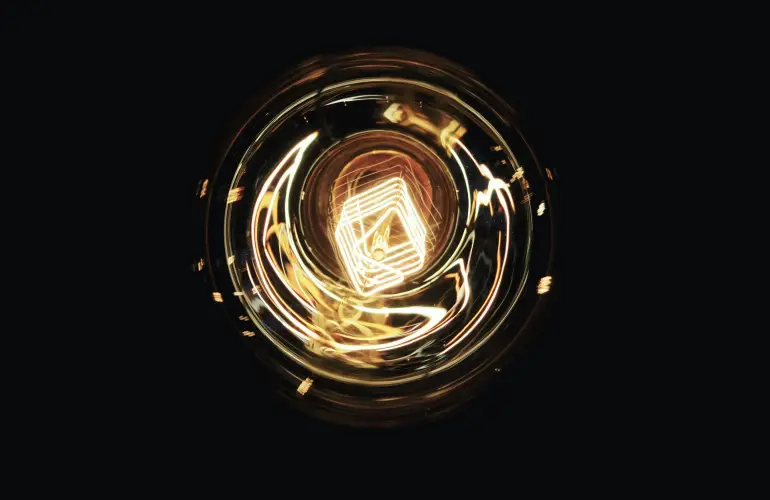I treni persi dell’indipendenza energetica italiana
Petrolio e gas costituiscono oggi il 70% dei consumi in Italia e sono quasi tutti importati, con fatture energetiche di 40 miliardi di euro annui (prima degli aumenti) che alimentano regimi come quello russo e quello saudita. Se ci ritroviamo qui è per via di scelte precise e di colpevoli omissioni. Ecco quali