CONVEGNO NAZIONALE “Continuità aziendale e responsabilità: strumenti, principi e scenari futuri”
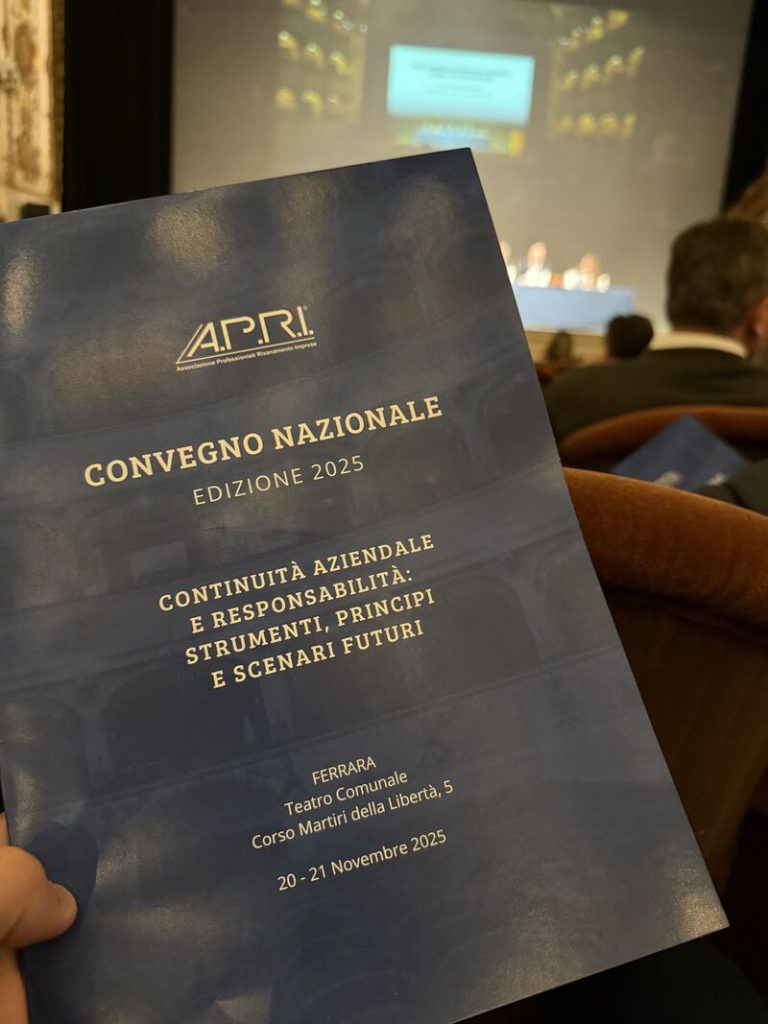
In questo giorno particolare, nel quale il PM di Milano Paolo Storari ha chiesto come inusuale sanzione accessoria a carico del gruppo TOD’S di Della Valle 6 mesi di interdizione alle attività pubblicitarie e promozionali, siamo qui a discutere di reputazione e di responsabilità.
Grazie agli organizzatori dell’APRI, a tutti voi, e ai relatori che mi seguiranno, l’Avvocato Nicola Menardo, specializzato in penale aziendale, a Corrado Ferriani, commercialista specializzato in risanamento aziendale e composizioni negoziate, l’amico e collega Stefano Zambon, non solo ordinario proprio qui a Ferrara, ma anche Segretario Generale della Fondazione OIBR, e grazie egualmente alla moderatrice Avv. Marta Bellini.
Parlando di responsabilità, che è una delle parole chiave di questo bell’evento, non possiamo assumerci piena responsabilità nel difendere la reputazione di persone e organizzazioni se non iniziamo a definire qual è il bene tutelato, cosa significa oggi la parola “reputazione”.
Per definire e comprendere il concetto di reputazione aziendale è doveroso chiarire il significato dei termini identità ed immagine. Questi tre concetti spesso vengono confusi e usati impropriamente: eppure, anche se apparentemente possono apparire simili e dai confini sfocati, identificano aspetti ben diversi.
Il termine identità si riferisce all’essenza, al nucleo, all’insieme degli elementi che caratterizzano l’organizzazione nel profondo, sia materiali che immateriali, la sua personalità, la vision, la mission, i valori guida ed i comportamenti dei membri: nel senso più esteso, il motivo stesso per il quale l’organizzazione esiste.
L’immagine riguarda invece la forma esteriore dell’organizzazione, il riflesso dell’identità dell’organizzazione così come appare agli occhi dei suoi pubblici. Le organizzazioni investono molto sul concetto di immagine per cercare di distinguersi e di essere attraenti, mostrandosi al meglio agli occhi di tutti gli stakeholder.
Ritornando al processo di costruzione dell’immagine aziendale, che è spesso la priorità degli uffici marketing e pubbliche relazioni, quest’attività può rivelarsi assai rischiosa quand’è auto-referenziale: come vedremo in seguito, quando ci si allontana troppo dalla vera identità dell’organizzazione, proiettando un’immagine inautentica ed artefatta, si entra nel tunnel del rischio di crisi reputazionale.
Comunque, è qui, nello spazio tra identità e immagine, che si posiziona il concetto di reputazione, cheidentifica il grado di allineamento tra l’identità dell’organizzazione e la sua immagine.
La reputazione si costruisce nel tempo, insieme ai pubblici dell’organizzazione, che si creano un’opinione valutando tutti i messaggi e soprattutto le azioni – auspicabilmente coerenti con i messaggi – dell’organizzazione stessa.
Ecco allora una definizione maturata attraverso gli anni di studio e di pratica professionale: la reputazione consiste nel grado di allineamento tra immagine e identità, e si costruisce nel tempo attraverso l’interazione con tutti gli stakeholder. Non è una caratteristica propria dell’impresa, ma un attributo di essa, e, in quanto tale, le viene riconosciuta e certificata dall’esterno. Tanto che la grande maggioranza delle crisi di reputazione, quelle che hanno distrutto valore e minato la business continuity, a volte distruggendo i brand, sono state generate proprio da un disallineamento tra identità, ciò che l’azienda era, e l’immagine, come si rappresentava all’esterno, il piccolo impero di Chiara Ferragni, per citare un caso che conosciamo tutti, è stato incenerito esattamente da questa dinamica.
Non abbiamo tempo in questo mio breve intervento di interrogarci a fondo sui pilastri funzionali a costruire, a “reggere” buona reputazione – che sono la qualità del prodotto, che chiama in causa varie domande, come ad esempio: qual’era il sogno dell’impreditore, il giorno in cui ha sottoscritto l’atto fondativo dell’organizzazione? Dove voleva arrivare? Cosa voleva cambiare nella società? Perché – piccolo o grande – c’è sempre un sogno alla base dell’agire di un imprenditore…; e poi, l’autenticità, e già poc’anzi ne abbiamo intuito l’importanza; e, infine, l’ascolto, termine quanto mai abusato a fini di propaganda, ma, nella realtà, “messo concretamente a terra” molto raramente; ma possiamo affermare senza timore di smentita che il grado di autenticità e di coerenza dei comportamenti dell’organizzazione nel tempo e la conseguente risposta alle attese formulate dai suoi stakeholder generano in effetti buona corporate reputation.
Volendo fare una metafora, potremmo immaginare l’identità di un’organizzazione come un palazzo, e l’immagine come un’impalcatura costruita dagli operai per rendere la facciata gradevole alla vista e senza alcuna crepa. Se la distanza tra l’impalcatura e il palazzo fosse eccessiva, naturalmente andrebbe a verificarsi un crollo della prima, così come avverrebbe se un’azienda cercasse di comunicare inautenticamente un’immagine artefatta e intrinsecamente distante dalla propria identità.
Si tratta del primo asset intangibile di qualunque azienda od organizzazione, e lo confermano i bellissimi e stimolanti lavori di un vostro collega, Paolo Vernero, che con un intuito che l’ha portato a precedere molti in Italia, nel suo ruolo di coordinatore della commissione di studio sugli ESG del Consiglio Nazionale degli ordini dei Commercialisti e Revisori Contabili ha agito da vero pioniere su queste tematiche di straordinaria attualità; un asset che incrocia appunto tematiche come i temi dell’ambiente, del sociale della governance, eccezionali driver di buona reputazione ma anche insidiosi generatori di rischio reputazionale, quando, mal governati, producono greenwashing, e su questo ricordo il lavoro di sensibilizzazione semplicemente monumentale svolto, su questi temi e più in generale sui framework internazionali di rendicontazione sulla sostenibilità, dalla Fondazione OIBR, magistralmente coordinata dal qui presente Stefano Zambon.
Se vogliamo prenderci responsabilità per questo prezioso asset, allora dobbiamo innanzitutto sfatare alcuni falsi miti, e vengo alla parte centrale del mio intervento.
Il primo, che la buona reputazione di costruisce a colpi di comunicazione, di marketing, di influencer: quella è l’immagine, la fragile apparenza, e abbiamo già spiegato che son due cose diverse.
Il secondo, che l’inserimento di preoccupazioni di carattere etico nel business obbedisce a necessità di tipo morale, e non è vero, o quanto meno non solo, la dimensione morale la lascerei alla coscienza di ognuno, ma la scienza ci ha dimostrato da tempo che non è così, fin dall’epoca dello straordinario lavoro di Robert Eccles ad Harvard, pubblicato nel 2012 che dopo 18 lunghi anni di analisi dei dati, ha sfatato il mito dell’azienda “buona” per ragioni morali. Le aziende non devono essere “buone”: devono fare utili, per poterli così reinvestire nella propria mission e nella conseguente crescita della comunità. Tuttavia, può esistere un business dal volto umano? È da tempo scientificamente dimostrato che le aziende che macinano migliori utili siano infatti proprio quelle più “buone”, o meglio, per dirla con linguaggio da addetti ai lavori, le imprese che hanno inserito preoccupazioni di carattere etico nel proprio business a livello strategico. Esatto, lo ripeto: queste sono le aziende nettamente più performanti, e sono gli studi scientifici a dimostrarlo. Il paper di Eccles ha confrontato un campione di centottanta aziende, novanta delle quali sono state classificate come imprese “ad alta sostenibilità” – quindi con percorsi e progetti di responsabilità sociale strutturati e attivi, consapevoli dell’importanza di inserire preoccupazioni etiche nel business – e novanta al contrario erano imprese “a bassa sostenibilità”, ovvero senza alcuna particolare sensibilità in tema di etica, e per contro molto marketing-oriented, attente alla massimizzazione del ritorno per gli azionisti nel breve termine. Ebbene, i risultati hanno mostrato un risultato precedentemente intuito da molti addetti ai lavori, ma che fino a quel giorno mancava di conferma e di affidabile supporto scientifico: le imprese etiche e ad alta sostenibilità sovra-performano – sia sotto il profilo dei risultati contabili che di quelli di borsa, per circa il 25% – rispetto a quelle prive di percorsi codificati di questo genere.
Il terzo falso mito da sfatare è che il rischio reputazionale non si può prevedere, non è vero, è una bugia clamorosa. Con il mio team di ricercatori abbiamo messo a punto, ad esempio, un assessment per la previsione e la mitigazione del rischio reputazionale, si chiama Company CheckUp®, all’estero ne troverete sicuramente altri e magari anche di migliori, in Italia attualmente è l’unico, sforna rapporti molto articolati che ci dimostrano appunto che il rischio reputazionale si può prevedere molto prima della deflagrazione di una crisi.
E questo ci aggancia al quarto falso mito, quello che sostiene che il perimetro reputazionale di un’organizzazione non si può misurare, ed anche questo è falso. Certo, non esiste ancora “il” metodo per misurarlo, universalmente riconosciuto per consensus, ma molta strada e molta sperimentazione si sta facendo in questa direzione, esistono vari metodi, io stesso con l’Avv. Nicola Menardo, seduto qui accanto, sto tentando come CTP in una causa ad alta visibilità mediatica di costruire consenso da parte dei giudici su questo, perché contrariamente a quanto sostiene la giurisprudenza in Italia il danno reputazionale è eccome danno patrimoniale, come fa ad essere non patrimoniale un danno in grado di impattare su conti di un azienda fino al punto da decretarne il fallimento…però per affermare e consolidare questo principio in primo luogo di semplice buon senso e in secondo luogo confermato da solida letteratura scientifica e anche dall’analisi di migliaia di case-study pratici, serve nuova giuriprudenza, e allora dobbiamo crearla.
L’ultimo falso mito da smontare, e vado a concludere, è che questi siano temi “da comunicatore”. Nulla di più falso, perché il reputation & crisis management è una scienza sociale, ha le sue regole, e queste regole coinvolgono e chiamano in causa comunicatori, ma specializzati, è una scienza specialistica che si differenzia alla comunicazione sic et simpliciter esattamente come la neurochirurgia di precisione si differenzia dalla medicina generale, non c’è un giusto e uno sbagliato, semplicemente sono due discipline che appartengono allo stesso dominio di conoscenza ma che presentano peculiarità molto differenti; e poi chiamano in causa avvocati penalisti per la gestione puntuale del cosiddetto “processo mediatico” che si sviluppa fuori dalle aule di tribunale, e in questo Nicola Menardo rappresenta una nuova generazione di avvocati capacissimi e sensibili a questi aspetti; i commercialisti, per il computo del peso della reputazione e il calcolo dell’impatto sul conto economico; gli avvocati civilisti, per la determinazione del danno; gli addetti stampa per la gestione delle media-relation, e molte altre figure professionali.
Ho comprendiamo una volta per tutte che la gestione di queste delicate dinamiche non può che passare attraverso un approccio multi-professionale, o non riusciremo mai a farci carico in modo efficiente delle nuove responsabilità generate da questi delicati scenari, di grandissima attualità.
Grazie e buon proseguimento di dibattito.