Benvenuti nell’era dell’attenzione parziale

Troppe informazioni e sempre meno tempo: tra giornalismo, new media e pubblicità Alberto Contri racconta l’era della Costante Attenzione Parziale
In realtà Contri, classe ’44, unisce a un curriculum di tutto rispetto – Direttore Creativo e Amministratore Delegato di DMB&B e McCann Erickson con ruoli anche internazionali, fondatore in Italia di McCann Interactive, Consigliere Rai e a capo di Rainet – una lucida visione sul mondo: oggi è Docente di Comunicazione Sociale allo IULM e Presidente di Pubblicità Progresso.
Contri sa riflettere come pochi su media e pubblicità con uno sguardo al passato e uno al futuro, e con quell’aria da sofisticato gentiluomo d’altri tempi va dritto al punto, e non si vergogna di fare nomi e cognomi. Tutto parte dal suo libro sullo stato della comunicazione McLuhan non abita più qui? I nuovi scenari della comunicazione nell’era della Costante Attenzione Parziale edito dai tipi di Bollati Boringhieri.
Partiamo dal titolo McLuhan non abita più qui?: in realtà come scrive anche Derrick de Kerckhove nell’introduzione, il sociologo canadese aveva previsto l’avvento di una cosa tipo internet
Lo ammetto, mi sono un po’ pentito di quel titolo perché in molti l’hanno preso come un saggio su McLuhan; ne sono usciti così tanti che in realtà non ci sarebbe stato bisogno di pubblicarne un altro. In realtà il libro è una riflessione su come sta evolvendo il mondo della comunicazione, riprendendo alcune sue intuizioni. Il punto di domanda in effetti significa che le sue riflessioni sono ancora valide. Ma il vero argomento del volume è il sottotitolo “La rivoluzione della comunicazione nell’era della Costante Attenzione Parziale”.
Oltre alla famosa frase “Il medium è il messaggio” in realtà McLuhan ha anche scritto “the user is the content” che pare criptica se applicata alla tv e dell’editoria, ma è facilmente interpretabile oggi nel mondo dei media interattivi
È stato di una visionarietà assoluta. Walter J. Ong, il mentore gesuita di McLuhan, addirittura diceva che “noi usiamo i mezzi di comunicazione, ma i mezzi di comunicazione plasmano il nostro cervello”. Basta guardarci attorno e vedere come tutti siamo distratti contemporaneamente da due-tre device in contemporanea e questo ci porta ad acquisire una modalità di pensiero fatta di frammenti che ci porta appunto all’era della Costante Attenzione Parziale.
Non so se ha letto la biografia di McLuhan scritta da Douglas Coupland uscita nel 2011: si racconta di un McLuhan che soffriva di carenza di attenzione, ma sempre pronto a assorbire informazioni da qualsiasi cosa. Forse anche lui aveva una Costante Attenzione Parziale
Non ho letto quel libro, però credo proprio che si trattasse di una Distrazione Creativa, come la chiama De Masi. A volte capita anche a me di essere un po’ dietro al mio sguardo, sembra che io sia lì invece viaggio con il pensiero. Ma è l’ulteriore dimostrazione che noi non ci possiamo scientemente concentrare su una sola cosa. L’inconscio può fare più operazioni, il conscio una sola. Non è come la ragazza che ho ritratto in copertina che cerca di essere multitasking pur essendo dotata di un cervello analogico.
Nel libro lei analizza la situazione attraverso una visione olistica e poi si permette di dare anche una sua opinione soggettiva. L’opposto di quel che vedo in giro: tutti si sentono semiologi e sparano sentenze e analisi affrettate, scrivendo libri sull’abuso degli smartphone…
Sta parlando di Aldo Cazzullo, vero? Lasciamo perdere. Lo trovo orribile. Un ottimo giornalista come quello lì, capace di documentarsi e fare analisi e riflessioni, ti spara un libercolo con quattro chiacchiere di una superficialità disarmante, senza un’analisi di causa e di effetto, ed è pure in testa alla saggistica. È il segno di dove è arrivato il giornalismo oggi.
Invece di provare a comprendere in profondità i nuovi atteggiamenti, i giornalisti inventano tesi partendo dall’interpretazione di una foto con quattro tizi in gondola che guardano gli smartphone
Partendo dai fattori critici, risalgo ai problemi che hanno oggi gli editori della tv e della stampa. Uno dei fattori critici è sicuramente il tempo: il paradosso è che di fronte a una miriade di informazioni a disposizione, abbiamo sempre meno tempo per usufruirne. Una delle vie di fuga è fare sei cose in contemporanea, quindi noi raccogliamo e rielaboriamo frammenti e rispondiamo attraverso gli stessi frammenti senza comunicare più in maniera lineare. Ed è qui che trae origine il linguaggio destrutturato che ha la generazione dei ventenni che vedo tra i miei studenti all’Università.
Per venire incontro a questa deconcentrazione diffusa del lettore, i giornalisti realizzano articoli sempre più brevi, sempre meno carichi di riflessione; ed ecco che si entra un circolo vizioso.
C’è modo di uscire da questo loop?
Tornare indietro è difficile. Quindi oggi gli editori e i media sono costretti a dare un’informazione in pillole, ma se vuoi che sia penetrante la devi curare molto bene.

Online sta funzionando bene il long form: lunghi approfondimenti su un argomento
Le rispondo con la frase del padre dalla pubblicità David Ogilvy, che sosteneva che per i grandi prodotti funziona sempre meglio un copy lungo che uno corto. Le storie interessanti funzionano sempre. Ci sono alcune cose di base che non sono cambiate, anzi, vanno potenziate.
Quindi esiste un modo per correggere questo circolo vizioso
Secondo me tutto passa attraverso l’educazione delle giovanissime generazioni. Esempio: fino a sette anni non si dovrebbe dare in mano a un bambino un tablet o uno smartphone, bensì sviluppare la scrittura a mano. Oggi purtroppo i nativi digitali non sanno più scrivere: lo so che le coercizioni sono sempre sgradevoli, ma forse stavolta sono necessarie.
C’è una cosa di cui sono convinto, è che il nostro cervello non può diventare digitale: ci ha messo 250.000 anni per diventare quel che è, e ora nel giro di pochi anni si sarebbe modificato?
Allora, bisogna fare delle distinzioni. In generale concordo con lei, le aziende di medie dimensioni hanno manager che purtroppo lavorano a breve periodo, senza un pensiero strategico a 3-4 anni. Molti marketing manager lavorano solo per il loro curriculum vitae. Ci sono invece aziende multinazionali come Apple, Unilever e Procter & Gamble che oggi stanno lavorando benissimo con un piano di lungo periodo ma in modo globale e quindi oggi in Italia, ai confini dell’impero, arrivano solo le briciole. Un tempo vigeva il think global act local, perciò alle agenzie locali davano un certo margine d’azione. Adesso non esiste più: tutto è già deciso a New York o a Los Angeles, la campagna viene girata lì e quando arriva qui, più che tradurre non puoi fare. Anche se sui social network e sul retail si può fare qualcosa di interessante.
Anche il mondo delle agenzie pubblicitarie ha subito un forte cambiamento in questi anni
Eh, certo! Io sostengo che questo derivi anche da un fattore tecnico: essendo stati abituati a calcolare i compensi alle agenzie sulla base dell’investimento, in questa fase di cambiamento vale la massima americana per cui “i dollari sulla tv diventano centesimi sul web”. Mi spiego meglio: se io azienda per una campagna tv 3-4 milioni li devo spendere, per fare una bella campagna sul digital e social media mi bastano anche 100mila euro. Però se devo pagare un’agenzia che ha lavorato molto, ci ha messo 10 persone per farti un bel progetto digital articolato, e ti do il 2% di 100mila euro, è poca roba. Allora le agenzie mandano dai clienti gli stagisti e si sentono dire cose che non capiscono. E siccome il mondo è pieno di storyteller che fanno video virali, giovani creativi senza arte né parte che si offrono a cifre ridicole, bene o male tutti i clienti prima o poi ci cascano. Quando vedono che le cose poi non vanno, affermano che i nuovi media non funzionano. Ma non è vero!
Oggi sembra che più che la creatività contino i big data, anche nella pubblicità
Ha visto? Adesso Accenture si è fatta la sua web agency e ora si è comprata anche un centro media. Però di nuovo si sta commettendo un errore, perché pensano che i big data siano il futuro di tutto. Certo, è importante avere il maggior numero di informazioni possibile, ma stanno venendo fuori un sacco di problemi sulla privacy, sulla concentrazione dei dati da parti di Google, Facebook… non è così semplice. E poi c’è stata negli anni scorsi questa fede totale al numero dei like, che non vuol dire niente. Ora finalmente in molti si sono resi conto, anche in UPA (Utenti Pubblicitari Associati, l’associazione delle aziende inserzioniste), che molti dati avevano degli errori o erano addirittura falsi.
E poi ci vuole il contenuto all’interno della storia
Ci vuole sempre un’intelligenza creativa, i numeri non bastano. Tornando al discorso di prima: Procter & Gamble ha preso questo Marc Pritchard come Global Brand Supervisor che lavora su tutti i brand. E lui nel nel suo speech iniziale ha detto “mi sono rotto le scatole di aver mille agenzie, ne voglio solo una a servizio completo, che magari coordina altri fornitori: però io devo parlare con un solo interlocutore e non voglio sapere niente delle vostre complessità, portatemi solo un risultato sulla base di un visione globale complessiva“. E da Procter negli ultimi anni sono nate le campagne più interessanti, che da una parte prendono anche valori sociali (il ringraziamento alle mamme durante Rio 2016) dall’altra sfruttano i fenomeni virali della rete per costruirci sopra delle campagne efficaci, vedi come sono riusciti a far risalire un brand come Old Spice.
C’è una campagna che le è piaciuta particolarmente in questi ultimi anni?
Ce ne sono molte. Mi piacciono soprattutto quelle che riescono a inserire i valori di brand o affrontare un tema per così dire “sociale” all’interno di una gabbia divertente: oggi il virale funziona solo per contenuti fuori di testa e che fanno ridere, e al tempo stesso riescono a parlare del prodotto. Visto che prima si parlava di abuso di smartphone, cito quella di qualche anno fa di CocaCola che si è inventata il Social Media Guard affrontando il tema, facendo sorridere e in più comunicando anche il prodotto. Il tutto con un video di 1’40”. Ma quanto tempo ci avranno pensato? C’è bisogno di tornare a una capacità di approfondimento e di analisi che ormai sono andate perse nella grande corsa di fare tutto in fretta.

Lei è da molti anni presidente di Pubblicità Progresso: da qualche anno mi sembra che la Corporate Social Responsability sia diventata strategica
Sì, concordo. Le grandi aziende hanno capito che la CSR non significa mettere zucchero a velo in un torta non proprio dolce, non è il greenwashing, ovvero buttare il colorante sul Po e poi fare una pagina sui giornali che hai restaurato una chiesetta. Quest’anno Audi nell’ultima campagna superbowl parla di parità di trattamento e salario tra maschi e femmine: che non vuol dire “guarda quanto sono buono”, bensì “ragiono di cose che sono importanti per te: parità di genere e acquisto dell’automobile”. Usano il valore sociale perché la gente ne ha bisogno, proprio perché stanno finendo le grandi “agenzie di senso”, il brand non solo diventa una casa in cui rifugiarsi, ma mi dà cose che non mi aspettavo. Sono bravi quelli che riescono a farlo coerentemente con la loro missione
C’è poi anche il tema della reputation delle aziende
Vero, e la reputazione non te la puoi costruire a botte di campagne. Io sono nato a Ivrea e ci ho vissuto fino ai 10 anni, e quindi so perfettamente che Olivetti è stato il vero grande precursore del CSR. La Olivetti produceva buoni prodotti – non per niente macchine da scrivere e personal computer le hanno inventate loro – aveva un’ottima assistenza ai consumatori e soprattutto ai dipendenti, con bici, campi da tennis, mensa e teatro gratuiti. Un paradiso terrestre. Poi sono arrivati i “maghi della finanza” e hanno trasformato quel gioiello in un’azienda che produce cartucce per stampanti. Insomma era già stato tutto inventato, e quindi ora stiamo tornando a quel concetto: non dobbiamo pensare alla CSR come una sovrastruttura, ma come un elemento che fa parte dell’impresa.
Dal suo punto di vista com’è la situazione odierna della comunicazione in Italia?
Mah, guardi, la comunicazione in Italia è sempre vista come una cosa semplice: tutti credono che siccome sanno leggere e scrivere, allora sono capaci di comunicare. Anche nelle grandi famiglie imprenditoriali, il figlio meno riuscito lo mettevano a capo della comunicazione. È sempre stata considerata la figlia di un Dio Minore, ma dall’altro lato molti comunicatori si sono inventati una carriera sul nulla e una competenza senza averla. Per esempio, guardiamo nella politica, questi consulenti di comunicazione, questi Rondolino, Velardi, che si atteggiano a grandi guru, ma che studi hanno fatto? Vedendo anche le ultime storie di Renzi e il Governatore di Bankitalia, ma anche Maroni e il referendum. Io mi chiedo, chi consiglia a questi come comunicare?
La corsa al tweet e al titolone è una tragedia. Anch’io che sono Ariete ho imparato a respirare 10 volte prima di parlare, e pur nella mia capacità creativa, di cazzate ne ho dette tante anch’io. Ma nella politica italiana non vedo una strategia, che invece aveva addirittura Trump nella sua campagna elettorale.
È stato anche amministratore delegato e direttore editoriale di Rainet dal 2003 al 2008. Mi sembra che oggi RaiPlay sia una bella novità…
Esatto. Ho costruito da zero Rainet, che era una società partecipata indipendente, prendendo le migliori teste interne della Rai e qualche ingegnere esterno. Mi sono ispirato al progetto che stava portando avanti la BBC. È stata una fatica pazzesca, perché eravamo considerati gli ultimi della catena del valore; internet era un’ancella che doveva solo portare ascolti alla tv. Avevamo costruito una bella cosa: 7 canali di web tv con 30 milioni di video caricati , crescita del 500% di utenti unici in 4 anni; quando la cosa è diventata interessante, io che non avevo nessuna protezione politica sono stato cacciato fuori, il progetto è finito in mano a persone che non state capaci di continuare il lavoro, e hanno distrutto tutto ciò che era stato fatto. Alla fine Rainet l’hanno addirittura chiusa, pur avendo un vantaggio fiscale a tenerla in vita e hanno fatto un disastro. Con l’arrivo di Campo Dall’Orto è entrato un nuovo responsabile new media. Io ci sono andato a parlare e gli ho segnalato disinteressatamente il team che aveva lavorato con me e lui se li è andati a ripescare. E ha cominciato da dove avevo finito io dieci anni fa.
Quindi la Rai digitale sta andando avanti. È la tv che è rimasta sempre la stessa.
L’arrivo di Netflix sta travolgendo tutto, e la frase che abbiamo ripetuto da anni “peak time is my time” è oggi una realtà anche da noi. Questi sono drive ormai evidenti a tutti : l’avevo scritto in un articolo su IlSole24Ore nel 1994. Ma questo non lo scriva, è talmente noioso dire “io l’avevo detto”.
Essere creativi è un istinto. L’ozio fa scattare la scintilla
Creatività, tecnologia e tempo libero. Il tempo cambia in base ai periodi, persone e circostanze.
E’ sempre e solo una questione di tempo. Si tratta di un concetto che ho espresso più volte, ma credo che sia alla base di ogni riflessione o ragionamento. E non solo per quanto riguarda la tecnologia. Ma partiamo da questa, che poi è il tema che contraddistingue i nostri scritti.
La concezione del tempo cambia a seconda dei periodi, delle persone e delle circostanze. Nel 1969 per andare da Roma a Milano in treno occorrevano circa sei ore. Il treno veniva definito rapido. Oggi, con il Freccia Rossa, ci si impiega meno della metà. Con l’auto, invece, percorrendo l’autostrada, la durata del viaggio rimane più o meno la stessa di circa 40 anni fa.
La sensazione che il tempo passi velocemente o meno è data anche dall’ambiente. Se facciamo un bel lavoro il tempo passa velocemente. Viceversa, il tempo non passa mai. Se, ad esempio, assistiamo a un bel concerto, il tempo acquista un valore diverso e sarà difficile paragonare quelle ore trascorse ad ascoltare musica rispetto allo stesso periodo di tempo necessario per svolgere un’attività più noiosa.
Ma questo cosa c’entra con la tecnologia? C’entra molto, considerando che oggi, grazie ai mezzi di comunicazione sempre più sofisticati, riusciamo a fare molte più cose in tempi decisamente ridotti rispetto al passato. Ma tutto ciò ci rende più felici? Prendiamo i telefonini. Grazie a WhatsApp, a Facebook e ad altri social, siamo in continuo contatto con altre persone, amici o conoscenti che definiamo amici. Le nostre prospettive sono cambiate. Così come i nostri sentimenti. Il nostro sguardo è sempre rivolto in basso, sul display del cellulare o del tablet. E i nostri rapporti sono sempre più virtuali.

In questo panorama mi ha colpito molto un libro scritto da Paolo Crepet, dal titolo Baciami senza rete, Mondadori. Il volume nasce da una scritta apparsa su un muro di Roma: “Spegnete Facebook e baciatevi”. Parole che sintetizzano nel migliore dei modi l’epoca in cui stiamo vivendo. Nessuna accusa contro la tecnologia, ci mancherebbe. Non lo ha fatto neppure l’autore del libro in questione. La tecnologia è utile, fondamentale, facilita le nostre vite in molti campi. Tuttavia è necessario fermarsi a riflettere su quegli aspetti che stanno modificando così tanto le nostre esistenze per comprendere e affrontare questa fase di cambiamenti e di transizione affinché si utilizzi nel miglior modo possibile il tempo a disposizione. Il tempo, appunto.
Visto che grazie alla tecnologia riusciamo a fare molte più cose nello stesso lasso di tempo, vale la pena dedicare più ore allo svago, alla distrazione. Distrarsi fa bene alla salute e alla creatività. E’ quanto sostiene Michael C. Corballis, un professore di psicologia dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, autore del libroLa mente che vaga, edito da Raffaello Cortina. Senza distrazione non c’è pensiero, sostiene Corballis. In fondo è quello che diceva anche Steve Jobs, ovvero, essere creativi significa vedere qualcosa che fino a quel momento non c’era. E allora, scrive Corballis, la distrazione diventa una speciale forma di concentrazione. Perché la mente non si ferma mai.
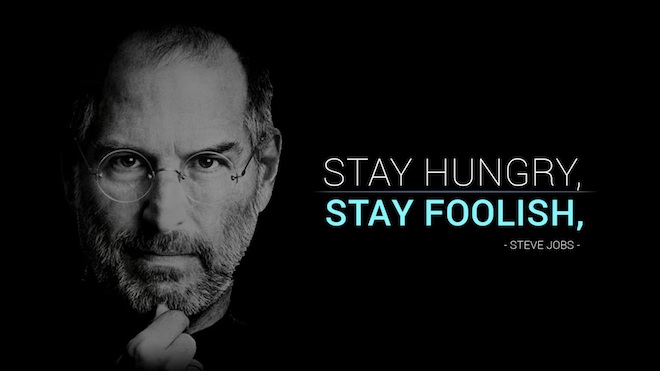
La distrazione, lo svago, l’ozio. Di ozio creativo parla Domenico De Masi, professore di Sociologia del lavoro all’Università La Sapienza di Roma. Esiste una prospettiva diversa, scrive De Masi, che ci può guidare fuori dallo smarrimento dei nostri tempi. Una prospettiva che il professore definisce Una semplice rivoluzione, che è anche il titolo del suo libro. Nel momento in cui la tecnologia è entrata così prepotentemente nelle nostre vite, rendendoci raggiungibili ovunque, dagli amici, dai nemici, localizzati attraverso i cellulari e altri dispositivi a cui affidiamo memoria, senso di orientamento, tempo libero e rapporti con le persone, non sarà il caso di staccarsi ogni tanto per recuperare quella parte di tempo che ci è stata tolta?
Non si tratta di essere avversi al progresso tecnologico. Non siamo come i Greci che nella antica Atene disponevano ciascuno di otto schiavi che in pratica si occupavano di tutto. Del resto, era chiaro che avanti così non si poteva andare e prima o poi quella pacchia doveva finire. Tuttavia è proprio dal tempo libero che nasce la civiltà, come sosteneva il grande filosofo russo Alexandre Koyré. Oggi quasi il 70 per cento della popolazione attiva lavora più con il cervello che con le braccia. La compresenza in molti casi non è più necessaria, e per i lavoratori intellettuali è sempre più difficile scindere il proprio mestiere da quello che viene definito ozio creativo.

Essere creativi è un istinto, e proprio l’ozio fa scattare la scintilla, l’idea, accende la lampadina che illumina la mente. Molte aziende nella Silicon Valley mettono a disposizione dei propri dipendenti sale relax, ambienti destinati al gioco, al divertimento, allo sport, per rendere più attraente il lavoro ma soprattutto per abbattere la barriera tra attività e tempo libero e per sollecitare la mente a nuove e sempre più utili invenzioni. La riconquista del tempo, paradossalmente, valorizza ancora di più le opportunità offerte dalla tecnologia. E organizzare nel migliore dei modi le proprie giornate rappresenta una delle principali sfide del futuro.