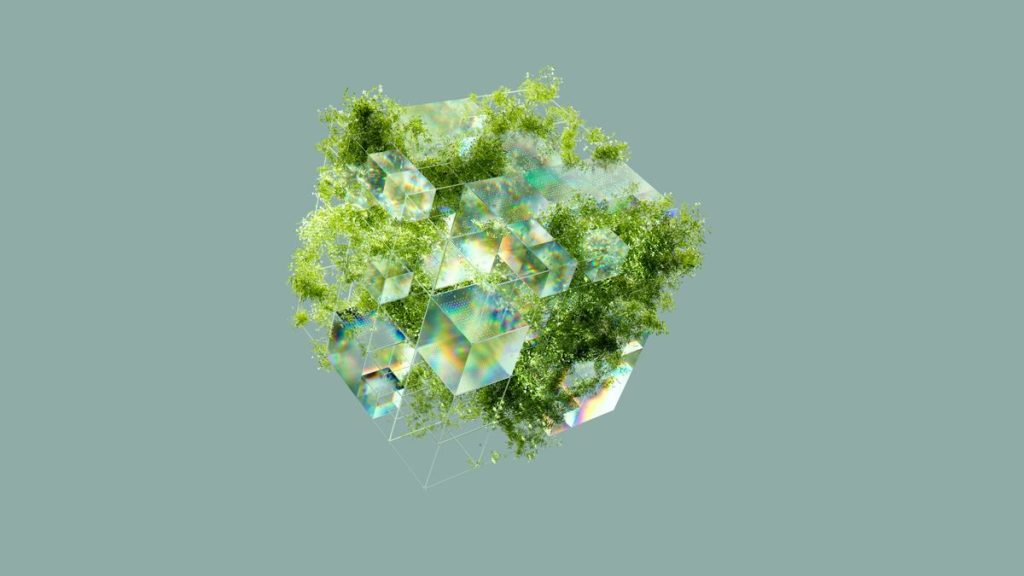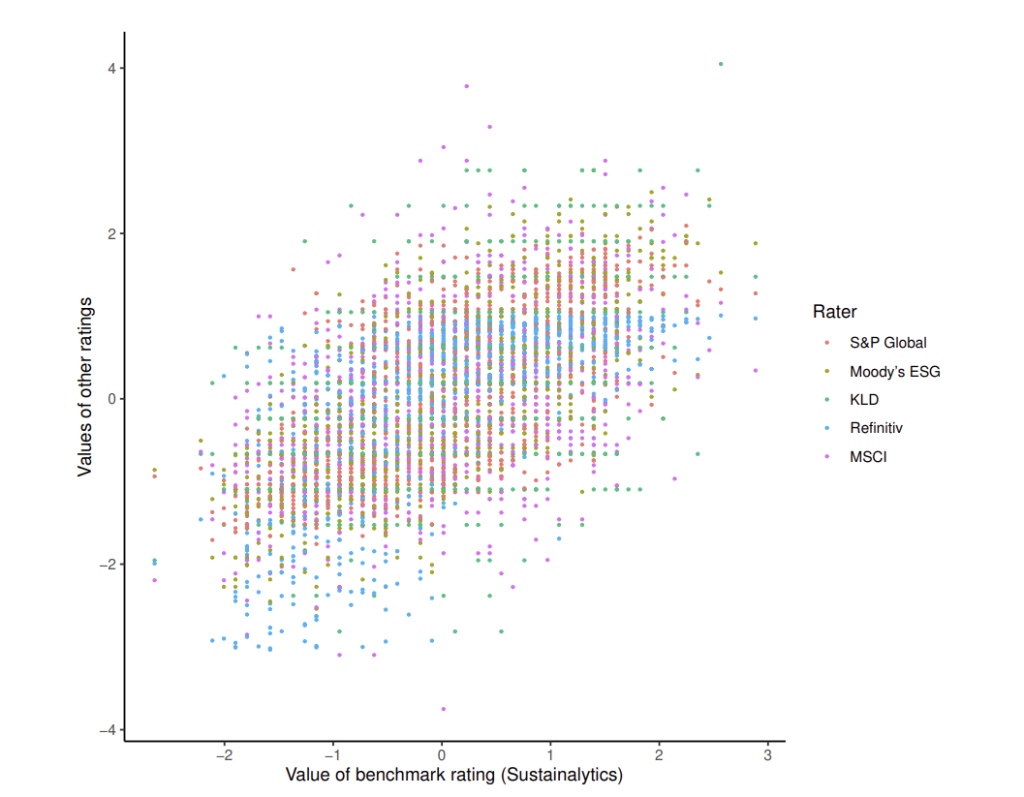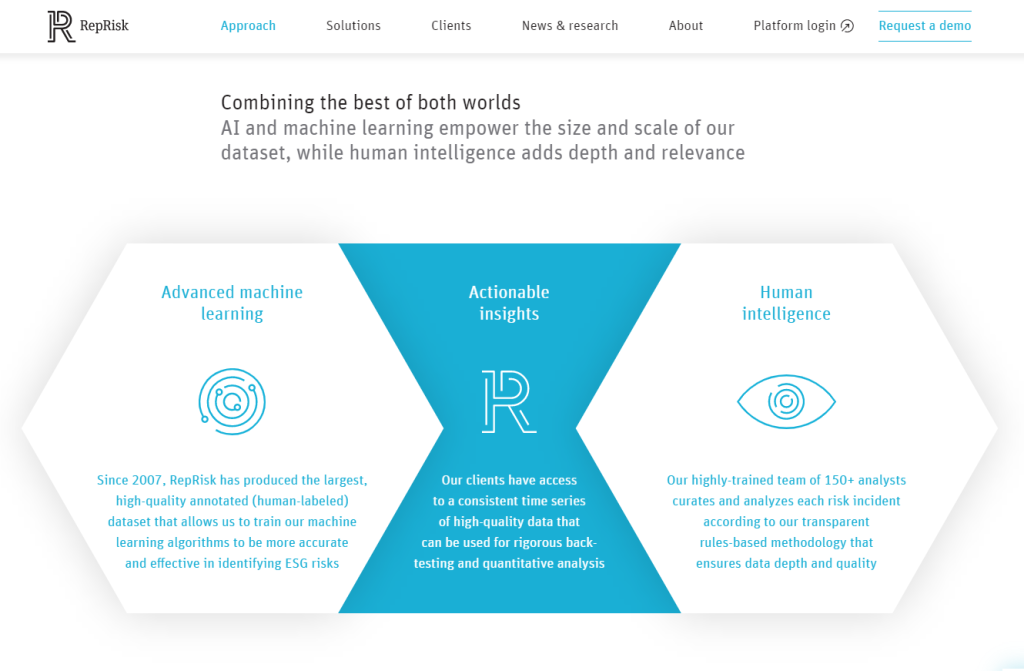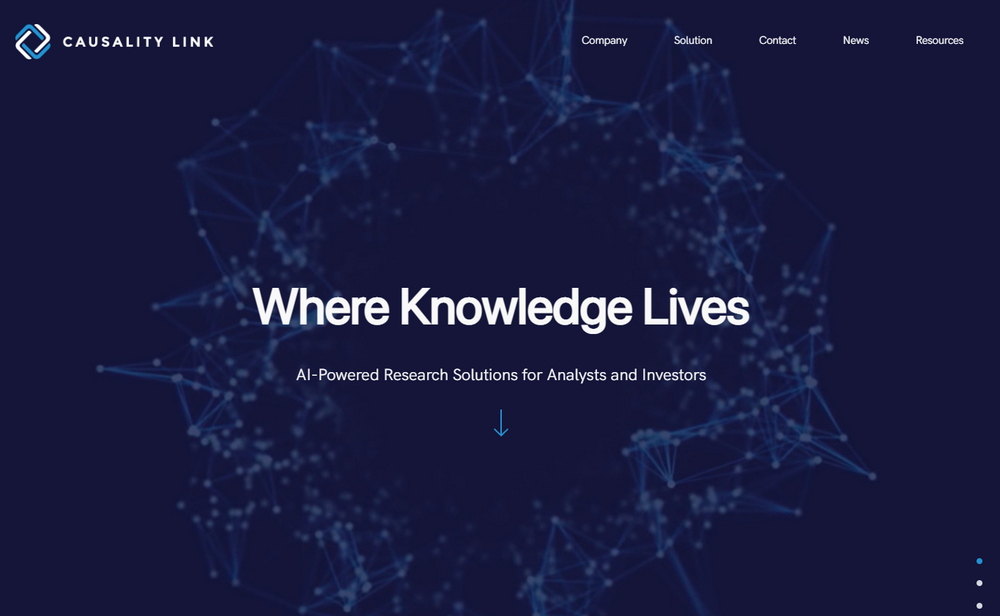Il 2023 è l’anno in cui l’Intelligenza Artificiale entrerà in una nuova Era, sarà alla portata di tutti e trasformerà l’economia, la sicurezza, il lavoro, le aziende e la vita stessa dei singoli uomini. A deciderlo sono state le Big Tech che hanno in mano i sistemi più avanzati e l’accesso ad una enorme mole di Dati. In testa a tutte Microsoft, che ha appena investito grandi capitali in OpenAI, la società più promettente, che ha creato ChatGPT. Brad Smith, sempre più spesso in Italia e in Vaticano, è il Presidente.
Lei è venuto qui per incontrare: un Capo di Stato, il Papa; una leader di Governo, Giorgia Meloni; il capo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni, che prima della guerra era detto il “Cyber-Zar”. Si muove, insomma, come un’istituzione. Come responsabile dei rapporti con l’Europa ha assunto un Ambasciatore, il danese Casper Klynge. Le aziende private fino ad ora hanno avuto come obiettivo il business, il Vaticano i valori e gli Stati le politiche nazionali. Cosa è oggi Microsoft?
È un’azienda privata con un’importante missione pubblica. Fornire al vostro Paese l’infrastruttura digitale di cui ha bisogno per avanzare nell’economia, per raggiungere le persone nel sociale, per implementare l’educazione e per la difesa della Nazione. Un altro ruolo importante che abbiamo è stabilire principi etici critici che sono importanti per tutte le società del mondo.La tecnologia ha impattato negli ultimi decenni ogni settore della società. Ora stiamo aprendo le porte ad altre nuove sfide; è importante dunque fare un passo indietro e ripensare la nostra missione: far si che le persone possano raggiungere obiettivi più alti nelle loro vite. Non è una questione di opportunità ma di responsabilità.
State investendo 10 miliardi in OpenAI, l’azienda di intelligenza artificiale che con la chat GPT, in grado di replicare ad ogni domanda con una risposta che attinge a una mole immensa di dati. Avrà un impatto che probabilmente neanche Microsoft può prevedere. Come pensate di gestire il modo in cui trasformerà il lavoro, la società, la politica, la ricerca, l’economia?
Crediamo fermamente nei benefici che questa nuova generazione di AI può creare. Questi modelli di linguaggio sono l’evoluzione dell’AI. Favoriranno la trasformazione dell’economia, aumenteranno la produttività, aiuteranno intere nazioni a crescere e creare nuovi lavori. Naturalmente questa sarà anche una sfida per la società. La buona notizia è che abbiamo pensato e lavorato su questo per un certo numero di anni. Non sto dicendo che abbiamo tutte le risposte. La prima sfida è creare dei principi etici e implementarli così da poter essere fiduciosi che l’AI lavorerà per servire i valori umani. Abbiamo fatto progressi nel cercare di evitare che abbia pregiudizi, che preservi una governance umana con decisioni umane. Ma c’è un secondo livello: l’impatto sulla società. Quali lavori cambierà? Dove potrà rendere la gente più produttiva nel lavoro e nella vita personale? Come possiamo essere sicuri che l’aumento della produttività si possa tradurre in un aumento di introiti per le persone? Una delle cose da fare è distribuirla più velocemente possibile così che la gente possa avere accesso alle potenzialità che offre e la renda sempre più efficiente. Personalmente ho sperimentato la versione a cui non ha accesso il pubblico e ho imparato come trarne più valore usandola in un modo invece che in un altro; sarà nostra responsabilità come azienda, in partnership con le Università, la Scuola e i governi provvedere affinché tutti possano accedere alle capacità di cui avranno bisogno. Dobbiamo cogliere l’opportunità di imparare insieme.
Per ora ChatGPT è aperta perché è utile addestrarla, ma poi resterà gratuita? Verrà integrata in Bing, il vostro motore di ricerca per sorpassare Google?
Come tutto nella vita, è uno strumento… alcune parti resteranno gratuite, altre verranno integrate nei prodotti; nasceranno nuovi business models ma sarà una buona notizia per l’economia, per i consumatori e se l’approcceremo con il giusto senso di responsabilità come stiamo facendo, possiamo raggiungere l’obiettivo. Non voglio parlare di cosa verrà dopo, o dei possibili competitor: stiamo entrando in una nuova Era dell’AI: sarà molto più ampia e distribuita in più aziende in maniera innovativa.
Nel 2020 la Casa Bianca presentò i suoi principi per l’AI dicendo che non bisognava iper regolarla ma l’Europa è interessata proprio a creare regole per tutto il digitale. Come possiamo dunque costruire un’alleanza transatlantica basata sui dati e sulla condivisione di questi tra Europa e USA, magari includendo anche Giappone, India, Australia, Nuova Zelanda e Corea del sud in quanto paesi con valori comuni?
Prima dobbiamo capire quanto sia importante creare consenso tra le Nazioni. Dobbiamo riconoscere un comune interesse economico e di valori: pensi alle aziende, anche quelle europee e italiane: il loro futuro verrà illuminato dall’accesso all’AI e dal cloud computing. Potranno restare innovative e competitive. Hanno bisogno delle migliori tecnologie che il mondo gli possa fornire. L’altra cosa di cui hanno bisogno è muovere i dati oltre le frontiere. Non si possono più avere clienti fuori dal proprio Stato senza muovere i dati da una Nazione all’altra. Quindi dobbiamo avere un approccio comune al regolatorio. Dobbiamo creare dei guardrails pubblici per la tecnologia: delle leggi che ci rispecchino tutti. Sarà complicato ma avverrà. Quello che è importante è la potenza di calcolo. Costruire e avere a disposizione una massa di supercomputer che addestreranno questi modelli di AI; e Data Center da schierare. Per questo Microsoft sta investendo in un nuovo Data Center a Milano: possiamo servire gli italiani con un Data Center governato dalle leggi italiane. Dati che possono essere usati dai nostri 14000 business partner in modo da poter abilitare e potenziare il lavoro degli italiani.
Come possiamo noi europei costruire un sistema di difesa e di intelligence del nostro continente se tutti i sistemi sono americani? Chi gestirà i dati strategici degli italiani che finiranno nel cloud?
Oggi nessuna nazione al mondo è isolata e se così fosse sarebbe un grande errore perdere i benefici della conoscenza globale. Ugualmente ci deve essere un livello di autosufficienza e protezione.
Come possono queste cose andare insieme?
La prima cosa da fare è assicurare che i dati vadano a beneficio del proprio business e Paese. Il nostro compito è creare un’infrastruttura digitale fatta di cloud e AI che dia al Paese più di quanto prenda indietro. Che crei più profitto per le aziende locali, più crescita economica locale. Poi c’è anche un altro strato: quello della sicurezza. L’Italia è parte dell’Europa e della NATO e la NATO si estende oltre l’oceano. Anche lo sforzo di sicurezza attraversa l’Atlantico. Il nostro dovere non è solo servire l’Italia economicamente ma proteggerla in termini di Sicurezza Nazionale. Queste sono le nostre motivazioni per lavorare sodo nell’incontrare i bisogni del Governo italiano, inclusa l’Agenzia di Sicurezza Nazionale.
È vero che Microsoft ha assunto molti esperti dell’ ICT fuggiti dall’Ucraina in Polonia?
Abbiamo assunto un certo numero di ucraini; anche prima della guerra. Ora per noi conta proteggere le persone che sono in Ucraina, il Governo, i Militari e la Nazione. Abbiamo fornito loro più tecnologia di qualsiasi altra azienda investendo più di 400 milioni di euro. Più di quanto abbiano fatto alcuni governi. Abbiamo offerto l’infrastruttura e la protezione in cybersecurity necessaria a identificare e sconfiggere i cyberattack in tempo reale. Questo è il test definitivo sulla nostra missione: non solo servire una Nazione ma proteggerla.
A Washington si è parlato di un piano Marshall per l’Ucraina ma qualcuno ha lanciato anche l’idea di un piano Marshall per la Russia, se perde. In fondo nel secolo scorso fu fatto per i Paesi che avevano perso, non per quelli che avevano vinto… che ne pensa?
Io penso due cose: la prima è che il mondo ha bisogno di un piano Marshall per l’Ucraina, che è una Nazione straordinaria. Noi Americani abbiamo ricostruito l’Europa Occidentale dopo la seconda guerra mondiale e possiamo aiutare a ricostruire di nuovo ora. Allo stesso tempo dobbiamo tenere ben presente che questa guerra è stata voluta dal governo russo ma non tutte la popolazione russa deve essere considerata nemica. Ci sono scuole, ospedali, individui innocenti che hanno bisogno di medicine che possono arrivare solo dall’Europa dell’Ovest, dall’Inghilterra, dall’America. Dovremmo aiutarli quando la guerra finirà e dovranno ricostruire, se verranno vinti dall’Ucraina.
In Vaticano ha firmato una “Rome Call for AI Ethics”, documento sottoscritto dalle tre religioni abramitiche promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita. L’Intelligenza Artificiale però rende sempre più importanti agenti non Umani che agiscono in tutti i segmenti della della società. Questo non mette in crisi proprio l’Umanesimo, cioè l’idea dell’Uomo al centro di tutto?
Abbiamo l’opportunità di prendere il meglio della filosofia occidentale, dell’antica Roma, della filosofia greca, del Rinascimento, che vede l’uomo al centro, e connetterlo con un’altra prospettiva che ci si presenta oggi. Papa Francesco ha dato un contributo a questa visione, sottolineando il ruolo che abbiamo come esseri umani nel proteggere l’ambiente inteso come Tutto: la nostra casa comune. Possiamo imparare dal confucianesimo e dalle religioni orientali ma non dobbiamo sottovalutare il contributo dello spirito della filosofia occidentale che ci offre una grande opportunità in questa prospettiva.
Come pensa che possiamo strutturare un sistema etico dell’AI che protegga le persone?
C’è un consenso emergente sui principi che devono guidare l’AI: evitare i pregiudizi, essere inclusiva, proteggere la privacy e la sicurezza, essere trasparente così che la gente capisca cosa l’AI stia facendo e resti rispettosa delle decisioni prese dagli esseri umani. Noi abbiamo creato un’azienda fondata su criteri di policy dell’AI responsabili. Testiamo i prodotti, addestriamo gli ingegneri per rispettare questi principi. Allo stesso tempo portare qui persone da tutto il mondo di differenti filosofie e religioni come fa il Vaticano consente di pensare ad una cultura che includa le differenze filosofiche tra Nazioni e che metta comunque l’umano al centro.
Di cosa ha parlato con la presidente Meloni e con Baldoni?
In conclusione dobbiamo pensare a due cose: Volete avere accesso alle migliori tecnologie del mondo che possano servire la Nazione e gli italiani? La risposta dovrebbe essere sì perché così si possono creare i migliori fondamenti digitali non solo per la competizione economica ma anche per la difesa nazionale. E poi: bisogna avere fiducia che questa tecnologia serva i bisogni degli italiani, i valori italiani, i valori occidentali, essendo soggetta alla giusta supervisione e controllo. Nel rispetto delle leggi. Tutto questo può essere utilizzato ed è a disposizione delle vostre aziende, del Governo e delle ONG come fondamento dei bisogni di questa economia e questa società. Questo è l’impegno che ci siamo presi. Non dico che sarà facile. Per questo vengo a Roma così spesso: c’è bisogno di presenza, conoscenza e dialogo. E attraverso questo dialogo possiamo muoverci verso il futuro insieme.
È quello che ha detto alla Meloni?
È quello che ho detto a tutti quelli con cui ho avuto l’opportunità di parlare.