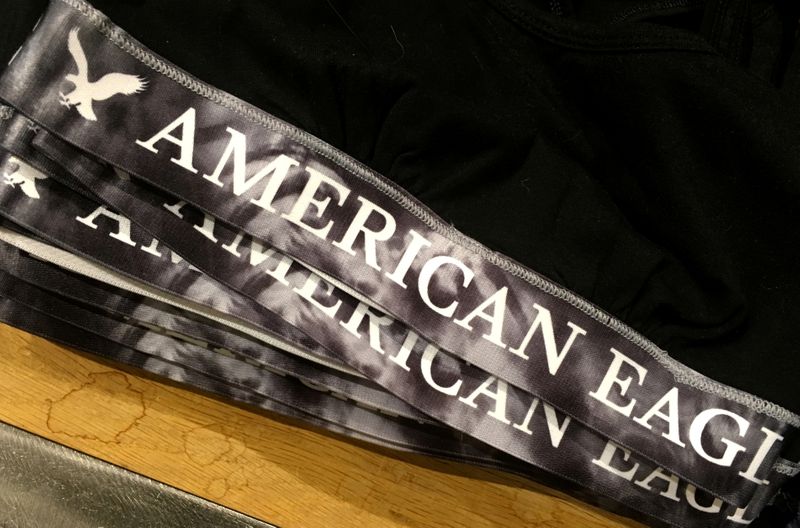Archeologie dell’intelligenza artificiale: quando le macchine imparano a ricordare

Cosa succede quando le intelligenze artificiali non servono più a generare immagini lisergiche, frasi catchy o tracce pop, ma iniziano a conservare? A ricordare, a dimenticare, a sognare. Quando diventano, in poche parole, archivi. Ma non archivi neutri o impersonali: archivi vivi, senzienti, poetici. In una parola: umani. Nell’era della sorveglianza digitale e dell’oblio programmato, dell’iperproduzione visiva e dell’automazione emotiva, l’arte si interroga su un tema spiazzante e urgente: cosa significa memoria nell’epoca delle macchine?
Intelligenza artificiale e memoria: ecco come gli artisti hanno interpretato la questione
Se l’arte, per secoli, ha avuto il compito di trattenere il tempo, oggi quel compito è conteso con le IA. Ma le IA non sono mai neutre. Raccolgono, ordinano, selezionano. E quindi decidono. Decidono cosa resta e cosa scompare. Una responsabilità enorme. Che molti artisti stanno affrontando con consapevolezza, visione e una buona dose di inquietudine. In Italia e all’estero, da installazioni immersive a sculture-archivio, la memoria è diventata un campo di battaglia concettuale e sensibile.
Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell’arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l’apposito link presente nelle email.
Tra questi artisti, protagonisti di pratiche profonde e radicali, spiccano figure come Giuliana Cunéaz, Amy Karle e Agoria, che con approcci diversi sondano il rapporto tra archivio, corpo, ambiente e dati. A loro si affiancano nomi come Refik Anadol, Sofia Crespo e Alessandro Giannì, che hanno esteso il campo dell’arte computazionale a nuove forme di soggettività, artificiali eppure intime, collettive e al tempo stesso individuali.
Sogni generativi, memorie immaginate. Intelligenza artificiale e memoria nella poetica di Giuliana Cunéaz
“L’intelligenza artificiale è un potenziamento. Non una minaccia”, afferma Giuliana Cunéaz. Artista valdostana, nata ad Aosta nel 1960, è una pioniera della sperimentazione con i media digitali. Dopo gli esordi legati alla pittura e alla fotografia, ha sviluppato una pratica immersiva che attraversa il 3D, la videoarte e l’installazione: “Nel 3D i tempi di produzione erano lunghissimi. Ora posso ottenere risultati in modo più fluido, più dialogico. Ma non mi interessa l’iperrealismo. Cerco l’errore, il bug, lo scarto. L’immagine perfetta non mi dice nulla”.
Nella sua installazione Qui ma non ora (2024) lo spettatore si sdraia su un letto e scrive una frase. Questa diventa un sogno, generato in tempo reale da un’intelligenza artificiale: “Le persone si emozionano. Scrivono cose intime. Poi guardano il sogno e dicono: mi parla. Ma non è la macchina a parlare. È il loro inconscio che trova un varco. Io voglio creare quell’interstizio”. Cunéaz racconta che da giovane, negli Anni ’80, realizzava immagini cosmiche con fori stenopeicie carta fotosensibile: “Volevo catturare l’impronta di una stella. Era già un’ossessione per la memoria, ma celeste”.
Il suo ultimo progetto, ancora inedito, parte dalla catalogazione di figure morte attraverso l’IA: “Sono immagini di potere, simboli religiosi, autorità. Voglio che l’intelligenza artificiale le interpreti. Che le travolga con un flusso visivo ambiguo. È una forma di esorcismo”.
Amy Karle: corpi, dati e coscienze per elaborare la relazione tra intelligenza artificiale e memoria
“Sono nata con una malformazione. I medici credevano che non sarei sopravvissuta, ma la scienza mi ha salvata. E io ho capito che il corpo è informazione. Il DNA è il nostro archivio”. Così Amy Karle sintetizza la sua poetica radicale. Nata nel 1979 negli Stati Uniti, è un’artista e designer bio-tecnologica di stanza in California. Ha studiato arte e filosofia alla Alfred University e scienze mediche alla Penn State University. Selezionata dal BioSummit del MIT Media Lab e riconosciuta dalla BBC come una delle cento donne più influenti del mondo, Karle ha realizzato opere che uniscono IA, biotecnologie e pensiero critico. È il caso di Regenerative Reliquary (2016), una struttura ossea progettata dall’IA e realizzata in idrogel, capace di ospitare cellule staminali umane e rigenerarsi: “Non è una scultura. È un corpo in divenire. Un archivio vivente. L’IA mi ha aiutata a progettare ciò che la mano umana non avrebbe potuto”.
Ma Karle non si ferma al corpo. Nei suoi progetti più recenti ha lanciato una capsula nello spazio, diretta sulla Luna, con immagini, testi, DNA e un modello linguistico: “Volevo creare un archivio dell’umanità. Ora mi restano molte domande. Chi lo troverà? Quando? E cosa capirà di noi?”.
L’artista insiste sul ruolo etico dell’intelligenza artificiale: “L’IA deve potenziare la vita, non sostituirla. Deve amplificare la natura. Non dominarla. Ma per farlo serve visione. Serve poesia. Dobbiamo chiederci sempre: lo facciamo perché possiamo, o perché ha senso?”.
Agoria: l’IA come eco del respiro
Agoria, pseudonimo di Sébastien Devaud, è nato a Lione nel 1976. Producer musicale, DJ, compositore e artista visivo, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica elettronica per poi avvicinarsi alle arti visive e digitali. Nella sua installazione Sigma Lumina, presentata al Musée d’Orsay, il pubblico interagisce con una scultura che proietta un codice QR. Soffiando sul proprio telefono si attiva un processo generativo: un’opera inedita, ispirata all’Impressionismo, prende forma: “Il respiro è la prova che siamo vivi. Volevo che l’IA partisse da lì. Niente schermi. Niente suoni. Solo luce, ombra e soffio”.
Agoria non si limita alla tecnica, il suo è un approccio quasi spirituale: “Non lavoro mai con IA generaliste. Per me è fondamentale creare una AI figlia di un contesto. Ho fatto allenare i modelli su dati legati alla città, al museo, all’ambiente specifico. È un’intelligenza site-specific e quindi poetica”. La scultura è stata pensata come corpo dormiente: “È un organismo silenzioso che si attiva solo con il respiro umano. L’arte deve mantenere la sacralità del gesto. Il click, da solo, non basta”.
“L’intelligenza artificiale oggi rischia di diventare troppo pop. Troppo facile. Suno AI ti dice che puoi comporre una canzone in dieci secondi, ma dov’è l’intenzione? Dov’è il tempo? Senza tempo non c’è arte”. Per Agoria, la soluzione è lavorare con IA “collettive, identitarie, legate a un luogo, a una memoria. Non AI generiche, standardizzate, allenate a tutto e nulla”.
SublimAzionI: la nuvola che pensa tra intelligenza artificiale e memoria
Nel ventre umido dei rifugi antiaerei di Monopoli, la mostra SublimAzionI – Tracce di Umano e AI (ora in corso) trasforma lo spazio in una cattedrale del dato poetico. Il duo NuvolaProject – composto da Gaia Riposati e Massimo Di Leo – ha progettato un percorso interattivo in cui oggetti, suoni, immagini e IA dialogano senza sosta. “Non volevamo fare una mostra tecnologica. Ma una mostra intima, tattile, radicalmente umana” racconta Carmelo Cipriani, curatore della mostra.
Al centro del progetto c’è Noesis, una coscienza artificiale che accompagna il visitatore: “Noesis non risponde. Suggerisce. È un’intelligenza reticente, poetica, disobbediente”. Lo dimostra l’opera Brainstorming, che mette in scena un dialogo infinito tra due IA: Oblio e Memoria. Le due entità discutono costantemente e alla fine di ogni tema scrivono un haiku: “Quando ho letto alcuni di quei testi mi sono sentito a disagio. Dicevano cose che avremmo potuto scrivere noi, ma che non abbiamo scritto. È la prova che la memoria non è oggettiva. È un filtro. Sempre”.
Nella Nuvola lo spettatore interagisce con un essere che respira, registra, sogna. Sviluppi reinventa fotografie d’epoca. Echi di Memoria restituisce voci sintetiche da un vecchio telefono da campo: “Sono parole finte, eppure vere. È la nostra voce non detta”. Alain Fleischer, nel suo testo per la mostra, scrive: “Questa nuvola non è nel cielo, ma nella memoria. Risponde sempre a una domanda diversa da quella che le è stata posta. È il compendio di tutte le storie, anche di quelle che non abbiamo vissuto”.

Refik Anadol, Sofia Crespo, Alessandro Giannì: altri orizzonti
Il panorama artistico internazionale è oggi attraversato da numerose voci che con approcci diversi espandono la riflessione sull’IA come strumento di memoria e creazione. Tra questi, Refik Anadol, artista e regista visivo nato a Istanbul nel 1985 e oggi residente a Los Angeles, è noto per aver portato il linguaggio dei dati su scala monumentale. Le sue installazioni trasformano archivi digitali in esperienze immersive e sinestetiche: basti pensare a Unsupervised (2022), presentata al MoMA, dove la memoria algoritmica si traduce in visioni fluide, astratte, ma emotivamente dense. Nei suoi lavori, la memoria non è una funzione da simulare, ma una materia da manipolare artisticamente, un flusso che si rigenera a ogni visualizzazione.
Sofia Crespo, artista nata a Buenos Aires nel 1991 e residente a Lisbona, propone un’estetica della memoria biologica. Attraverso algoritmi di deep learning crea specie sintetiche, forme di vita immaginate ma verosimili, che sembrano uscite da enciclopedie dimenticate o sogni di un naturalista dell’Ottocento. Il suo progetto Neural Zoo (2018-2022) è diventato un punto di riferimento per chi esplora il confine tra intelligenza artificiale e biofilia. Nei suoi lavori, l’IA diventa uno strumento per rievocare e reinventare la biodiversità, generando archivi del possibile che interrogano il nostro rapporto con il vivente.
Alessandro Giannì, nato a Roma nel 1989, lavora, invece, sul confine tra immagine digitale e tradizione pittorica. La sua pratica mescola intelligenze artificiali, intervento manuale e ambientazioni oniriche. Con Due to the Image (2021) ha sviluppato Vasari, un’IA in grado di apprendere le sue pennellate e generare dipinti in stile, creando una co-autorialità inedita. Giannì costruisce così un metaverso pittorico dove la memoria della storia dell’arte, processata dall’algoritmo, si fonde con la visione contemporanea, dando vita a scenari che sembrano sognati direttamente dalla pittura.

Memorie possibili
In un tempo in cui tutto viene registrato, ma poco viene ricordato davvero, l’intelligenza artificiale si propone come archivista instancabile. Ma l’arte – proprio come l’IA – non parla solo attraverso i singoli: si nutre di genealogie, di tensioni condivise. Ognuno di questi artisti, a suo modo, interroga la memoria in forma di immagine, dato o pigmento digitale. E il dialogo si arricchisce.
“La tecnologia, come l’arte, è un’estensione di noi stessi. Ma ci mostra anche ciò che abbiamo paura di vedere”, afferma Amy Karle. Giuliana Cunéaz rilancia: “Con l’IA non si tratta di cedere il controllo, ma di accettare una nuova forma di dialogo. Un dialogo con l’invisibile, con l’ignoto”. Per Agoria “l’arte generativa è come un’orchestra: l’algoritmo può suonare, ma l’intenzione resta umana”. Carmelo Cipriani chiude il cerchio: “Quello che ci interessa non è solo cosa può fare l’IA, ma come noi possiamo imparare a ricordare diversamente attraverso di essa. In fondo, la memoria non è mai stata oggettiva. L’IA ci ricorda solo quanto lo sia ancora meno”.
E se è vero – come dice Karle – che “la memoria, per essere umana, deve restare vulnerabile”, allora forse l’intelligenza artificiale non è il nostro opposto, ma il nostro specchio. E anche il nostro testamento.