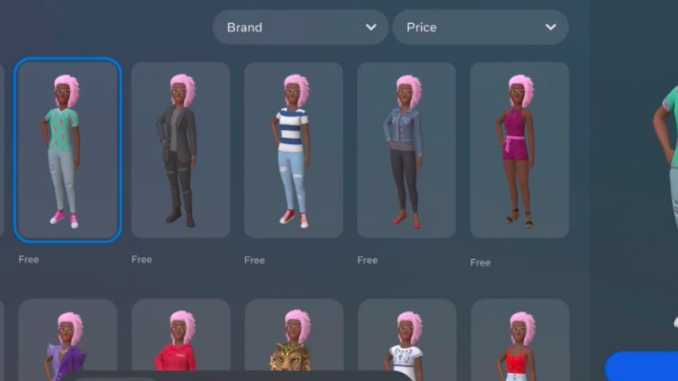Grazie a Twitter, Elon Musk potrebbe accelerare lo sviluppo dei suoi impianti cerebrali
Elon Musk, il magnate statunitense a capo di numerose aziende innovative, tra cui Tesla e SpaceX, continua a far parlare di sé. L’acquisizione di Twitter portata a termine a fine ottobre aggiunge un nuovo tassello al dominio digitale dell’imprenditore, che proprio su Twitter conta più di 110 milioni di followers.
Il suo personaggio visionario e controverso fa sorridere alcuni/e, ma preoccupa altri/e. Oltre ad ambire a elettrificare il mondo e a colonizzare Marte, Musk crede di poter arrivare un giorno a connettere il cervello umano all’intelligenza artificiale. Per questo, nel 2016 ha fondato l’azienda Neuralink, che produce interfacce neurali da impiantare nel cervello. Si tratta di dispositivi ancora lontani da questo obiettivo, sperimentati perlopiù su scimmie e maiali.
Ma grazie ai dati sensibili dei circa 330 milioni di utenti attivi di Twitter, Neuralink potrebbe arrivare a sviluppare neurotecnologie invasive, ovvero impianti cerebrali in grado di leggere e persino manipolare il cervello delle persone, influenzandone il comportamento, i ricordi, i pensieri e le emozioni. È ciò che teme Marcello Ienca, esperto di etica delle neurotecnologie del Politecnico federale di Losanna (EPFL).
La Svizzera è molto impegnata sia nello sviluppo che nella regolamentazione delle tecnologie che si interfacciano con il sistema nervoso umano. Secondo Ienca, però, il piccolo Paese tra le Alpi potrà fare poco da solo per contrastare l’avanzata di sistemi e piattaforme in grado di condizionare l’opinione pubblica.
SWI swissinfo.ch: Marcello Ienca, perché secondo lei Elon Musk è “moralmente inadatto”, come ha affermato in un post a essere sia il presidente di Twitter sia il CEO di Neuralink?
Marcello Ienca: Il fatto che la stessa persona che possiede una delle principali aziende al mondo che produce neurotecnologie impiantabili nel cervello sia anche il proprietario di una piattaforma social che raccoglie i dati sensibili di milioni di utenti è alquanto preoccupante.
hiunque si occupi di neurotecnologie che leggono e influenzano il cervello umano dovrebbe attenersi a degli standard morali molto elevati. Questo non è il caso di Elon Musk. Stiamo parlando di un personaggio eccentrico che sfrutta già la sua pagina Twitter per comportarsi da capo troll del web, condizionare l’andamento sul mercato delle sue aziende e influenzare politicamente milioni di elettori ed elettrici, come abbiamo visto durante la campagna per le ultime elezioni di medio termine statunitensi [Musk ha invitato l’elettorato a votare per il partito repubblicano, ndr].
Nulla nel suo comportamento fa pensare che sia disposto a rinunciare alla manipolazione dell’opinione pubblica per motivi etici e questo lo rende inadatto a sviluppare tecnologie che si interfacciano con il cervello, il dominio di massima salienza morale di cui disponiamo.
Sulla carta, però, tra Neuralink e Twitter non c’è alcun collegamento. Come possono dei tweet aiutare le aziende di neurotecnologie a sviluppare dispositivi in grado di influenzare la mente umana?
Un tweet può dire molto su una persona. Può dare indicazioni non solo sul credo politico e religioso, ma anche su pensieri, emozioni e stati psicologici. Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile analizzare i sentimenti di una persona sulla base del linguaggio verbale. Questo processo, chiamato Natural language processing for sentiment analysis, permette di estrarre da un tweet informazioni psicografiche [che classificano cioè l’utenza sulla base di caratteristiche personali e psicologiche, ndr] su una persona con un buon grado di attendibilità statistica.
Ciò consente di capire, per esempio, se un individuo è più tendente alla positività o alla negatività, al rischio o alla paura, per poi bombardarlo con campagne pubblicitarie o informazioni mirate, vere o false che siano. Un caso emblematico è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, che ha fatto profiling psicografico accedendo abusivamente ai dati degli e delle utenti di Facebook per influenzarli politicamente.
Attualmente è difficile estrarre queste informazioni altamente sensibili dai dati cerebrali di chi usa le neurotecnologie, anche perché il numero di utenti è limitato. Ma se a questi dati cerebrali si combinano a quelli psicografici di milioni di utilizzatori e utilizzatrici di Twitter è possibile potenziare notevolmente le capacità non solo di questo social, ma anche delle neurotecnologie e di comprendere e classificare le persone sulla base di caratteristiche psicologiche, per influenzarle e manipolarle maggiormente.
Anche Facebook ci aveva provato nel 2018, lanciando un’interfaccia cervello-computer, un progetto che Zuckerberg ha successivamente lasciato cadere, probabilmente per motivi di costi.
Dobbiamo quindi aspettarci che le neurotecnologie di Musk siano presto in grado di leggere e condizionare la mente umana?
È probabile. Le neurotecnologie oggi non consentono di leggere il pensiero in maniera estesa, ma sono già in grado di stabilire correlazioni statistiche tra dati cerebrali e informazioni psicologiche, suscitando preoccupazione per la privacy. Quando il numero di utenti (e quindi di dati) aumenterà, anche i rischi di avere dispositivi più invasivi della privacy mentale sarà maggiore.
Qui non si tratterebbe più solo di curare pazienti affetti da problemi psichici e neurologici, che potrebbero beneficiare enormemente di queste tecnologie, ma di commercializzare dispositivi utilizzabili da un numero crescente di persone per registrare le attività del cranio e ottimizzare i processi mentali, la concentrazione e la memoria. Sul mercato esistono già dei dispositivi tipo fitbit del cervello per monitorare il sonno, l’attenzione e l’ansia. Alcune app permettono persino di controllare oggetti fisici con la mente.
La Svizzera è attrezzata per contrastare i rischi delle neurotecnologie e proteggere la privacy della sua utenza?
La Svizzera è forse uno dei Paesi meglio posizionati a livello mondiale per quanto riguardo lo studio delle implicazioni etiche e sociali delle neurotecnologie e lo sviluppo di strumenti normativi innovativi per affrontare queste sfide.
La Confederazione ha partecipato attivamente alla stesura delle raccomandazioni sull’innovazione responsabile delle neurotecnologieLink esterno dell’OCSE, che oggi è il primo standard internazionali in materia. E organizzazioni come GESDALink esterno [il Summit di anticipazione della diplomazia scientifica e tecnologica di Ginevra, ndr], hanno messo le neurotecnologie al centro della loro agenda.
Tuttavia, la Svizzera da sola sarebbe impotente contro Musk o qualsiasi altra azienda globale. Il suo margine di azione per proteggere la privacy e l’integrità mentale di un’utenza relativamente piccola è limitato. L’Unione europea, con più di 400 milioni di abitanti, avrebbe invece un potenziale negoziale maggiore perché sarebbe sconveniente per Musk rinunciare a questo bacino di utenti.