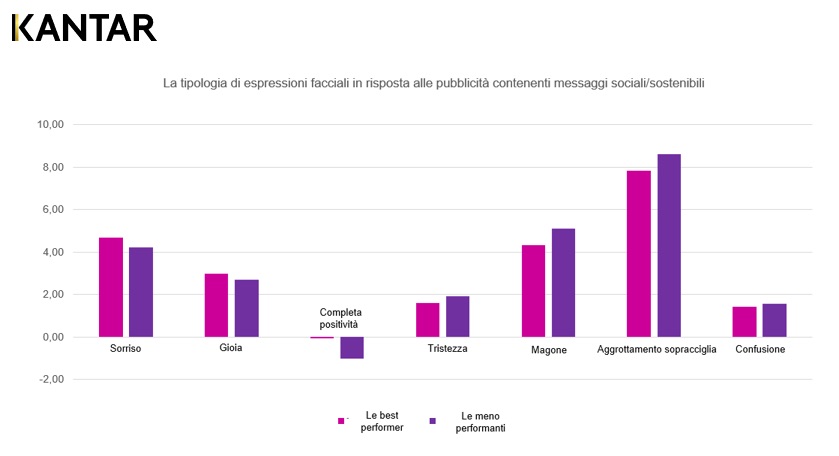La sostenibilità si deve misurare. Un solo standard contro il falso green
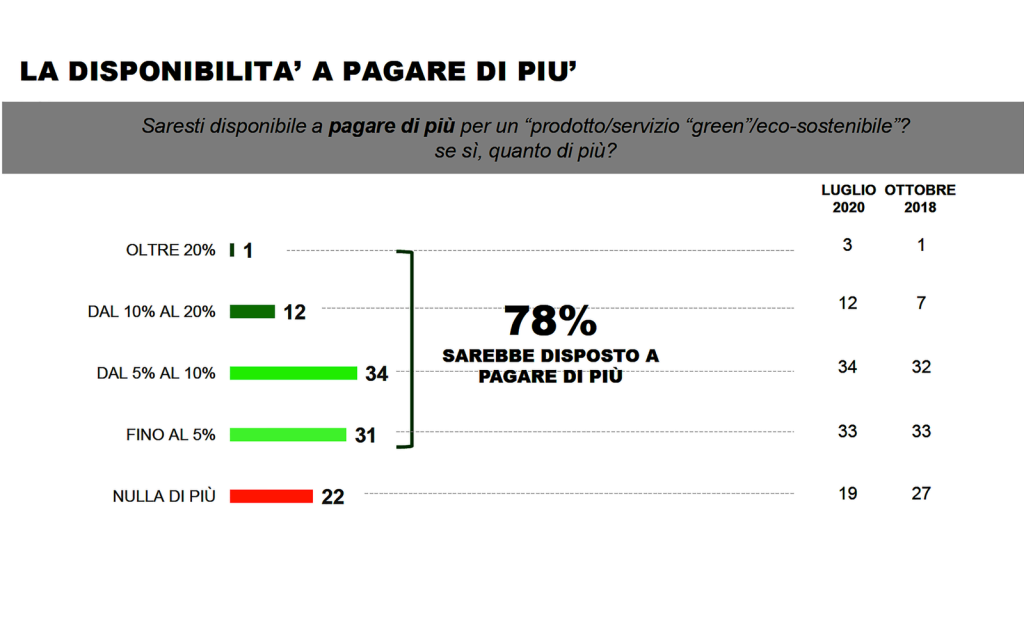
La transizione green chiede più finanza Esg
Grande è la confusione sotto il cielo della sostenibilità. Misurare, valutare e confrontare un’impresa per il suo valore di coerenza con i criteri Esg (Environmental, Social, Governance) è impossibile, ognuna ha un metro diverso.
Per dare solo un’idea della giungla metrica fra il 2007 e il 2021 a livello globale sono stati 1.047 gli autori che hanno prodotto sistemi diversi per misurare la sostenibilità nelle imprese, 490 i modelli definiti con una media di 35 all’anno e picchi fino a 65 paradigmi differenti. Intanto si sono moltiplicate le agenzie di rating Esg, ciascuna con un proprio modello di valutazione (rating) e il quadro si è complicato ancora: l’ultimo studio dell’Esg European Institute dice che nel 2018 erano più di 600 i rating Esg a livello globale. Il paradosso è evidente: leggere la responsabilità sociale, l’impatto ambientale i criteri di governance e integrare l’analisi in relazione oggettiva a costi e benefici in base alle informazioni dei report di sostenibilità (quando ci sono) porta quasi sempre «di fronte a visioni totalmente differenti» fra imprese: ciò che è attività sostenibile da una parte, può essere un rischio in un’altra azienda. Manca una «chiara identificazione delle informazioni minime da riportare». E per il mondo finanziario e industriale, «che deve valutare e valutarsi secondo metriche Esg chiare e condivise è un grande problema, crea potenziali rischi di essere coinvolti in attività di greenwashing o in imprese non sufficientemente green».

Il monito non è da trascurare visto che arriva da chi per venti anni ha governato le società in Borsa italiana di cui dodici come Ceo e capo globale dei mercati del London Stock Exchange Group. Ma Raffaele Jerusalmi, va oltre e chiama in causa imprenditori, consumatori e autorità proprio perché questa confusione, soprattutto per le piccole e medie imprese, rischia di compromettere l’attenzione della finanza Esg (oggi vale già 500 miliardi di cui 31 in Italia) e far perdere l’occasione di aprire il capitale e intercettare risorse per crescere di dimensione, di sviluppo e decidere proprio destino.
«Gli investitori sarebbero quindi facilitati nella valutazione delle performance Esg e nel confronto fra le imprese. Per le autorità di controllo rendere oggettive le misurazioni Esg agevolerebbe le verifiche» spiega Jerusalmi, riducendo le false dichiarazione. Tema su cui è scesa in campo anche l’Europa, con suoi dati alla mano: nel 42% dei casi le affermazioni delle aziende non erano vere e quindi valutate «pratiche commerciali sleali», greenwashing, tanto da proporre modifiche alla direttiva sulla tutela dei consumatori ampliando le caratteristiche del prodotto su cui le imprese non possono più ingannare i cittadini solo per includere l’impatto ambientale o sociale con dichiarazioni di prestazioni future senza includere impegni, obiettivi verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente. Che è l’altro problema. Solo in Europa la Commissione ha rilevato che oggi esistono oltre 40 rating diversi, 150 sistemi di misurazione e 450 indici Esg. La confusione sotto il cielo della sostenibilità quindi aumenta a un buon ritmo.
La proposta di un modello unico

Anche perché «oggi per valutare un’impresa o la sostenibilità di un investimento nel medio-lungo periodo non basta più guardare ai soli dati finanziari. Le decisioni sui piani aziendali tengono conto anche di dati extra-finanziari come i fattori Esg», spiega il presidente di ESG European Institute, Luca Dal Fabbro, oggi impegnato nel costruire un indice che sappia fare sintesi nella vasta giungla dei rating. La proposta l’ha raccolta nel libro “ESG: La misurazione della Sostenibilità” (Rubbettino Editore). Con un obiettivo dichiarato, non solo quello di analizzare le metriche di misurazione Esg esistenti, ma di avanzare un’analisi che contribuisca al processo di semplificazione e standardizzazione delle metriche di sostenibilità Esg attualmente esistenti, e giungere ad una rendicontazione e una disclosure di sostenibilità integrata, oggettiva e misurabile.

Dal Fabbro è un manager dell’energia e dell’economia circolare, è stato presidente di Snam, Ceo di Enel Energia e E.ON Italia e membro del Cda di Terna, e da questi osservatori propone un nuovo strumento, incrociando le numerose variabili esistenti e più diffuse per uniformità e universalità, semplificando le metriche e rendere più attendibili. Dal Fabbro lo ribadisce chiaramente: «La crescente importanza di questo concetto non è stata accompagnata da una chiara definizione di standard e metriche condivise e uniformi per la misurazione e la rendicontazione della sostenibilità. Nonostante la presenza di numerosi standard internazionali – spiega Dal Fabbro – ancora oggi si evidenziano sostanziali lacune nel processo di misurazione e disclosure di queste informazioni».
Il rating per la sostenibilità d’impresa

Ma di che cosa si tratta esattamente quando si parla di parametri Esg?
l testo di Dal Fabbro ripercorre l’evoluzione storica dell’Esg investing e il ruolo cruciale che i rating Esg hanno svolto nel processo investor-driven di affermazione di aspetti non finanziari nella valutazione aziendale. Al contempo, l’analisi della letteratura ha mostrato la disomogeneità esistente a livello di framework di rating Esg. Questa disomogeneità può esser definita una caratteristica strutturale del sistema dei rating Esg. In un contesto competitivo di mercato, ogni agenzia di rating Esg ha interesse a proporre un framework proprietario di analisi e di valutazione e di promuovere gli aspetti caratteristici della propria metodologia. Questa situazione ha portato al proliferare di un gran numero di framework di rating Esg, al punto che nel 2018 potevano contarsi piu di 600 framework di rating Esg a livello globale. Seguendo una tradizione ormai consolidata, i tre criteri di riferimento per la rendicontazione sono:
- – Environment (E):
include tutti gli standard su come rendicontare gli impatti da e su tutti i fattori ambientali come cambiamento climatico, risorse idriche, biodiversita ed ecosistemi, economia circolare, inquinamento; - – Social (S):
include tutti gli standard su come rendicontare gli impatti da e su tutti i fattori sociali come forza lavoro, lavoratori nella value chain, comunita, consumatori finali; - – Governance (G)
include tutti gli standard su come rendicontare gli impatti da e su tutti i fattori relativi alla governance e all’emittente, come etica del business, management, relazioni con azionisti e stakeholders, organizzazione e innovazione, reputazione e gestione del brand.
C’è un dato in più di cui tenere conto. La pandemia legata al Covid ha evidenziato in modo ancora più accelerato la necessità di modelli di business sostenibili e resilienti: ogni nuova elaborazione – avverte Del Fabbro – non può però prescindere «dall’approccio che le imprese devono seguire, impegnate nell’integrazione dei propri piani di sostenibilità con il piano strategico». Il tema diventa cosi rilevante che non e più percepito come una sola questione etica, ma «va a indirizzare il purpose delle società e si pone come elemento competitivo di mercato. Che alla fine si traduce in una gestione efficiente e strategica delle risorse a disposizione, siano esse naturali, finanziarie, umane o relazionali».

Non solo. Gli ultimi due anni hanno anche mostrato con evidenza «la natura globale e pervasiva» delle sfide che aziende e persone possono trovarsi ad affrontare. La pandemia oltre a rimodulare i modelli di business, ha rivoluzionato anche il modo e l’organizzazione di lavorare, «promuovendo organizzazioni ibride e flessibili e accelerando la transizione digitale. In seguito, l’aumento dei prezzi dell’energia e dei costi CO2 in Europa ha mostrato l’urgenza e le difficoltà che la transizione ecologica pone. «Difficoltà che non sono solo economiche e tecnologiche – spiega Dal Fabbro nel suo lavoro -, ma anche e soprattutto sociali. Infine, il recente scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ha evidenziato ulteriormente l’importanza di temi geopolitici e di sicurezza energetica».

Il contesto geopolitico, l’emergenza energetica e il post emergenza sanitaria, guardando avanti, è evidente che hanno ridefinito anche le maggiori sfide per le aziende. In particolare queste riguarderanno:
• Le minacce associate al cambiamento climatico e alla necessità di dover ridurre i propri consumi, sia nelle scelte produttive che in quelle distributive della propria azienda;
• La gestione delle risorse. Una buona gestione delle risorse, unita a una riduzione degli sprechi, oltre ad essere un elemento importante per la sostenibilità ambientale della propria azienda, comporta anche dei benefici economici considerevoli nel breve periodo. Una scelta strategica, quindi, di duplice rilevanza, su cui il modello dell’economia circolare rivestirà un ruolo di primo piano.
Tutto questo significa che nei prossimi anni «una strategia aziendale non potrà essere di successo nonostante queste sfide – spiega Dal Fabbro -, ma solo attraverso le stesse. Solo prendendo in attenta considerazione i rischi e le opportunità della transizione ecologica le aziende avranno gli strumenti per eccellere nel proprio settore».
Le tensione e le nuove sfide delle imprese
Esiste anche altro aspetto che mette in ulteriore primo piano l’importanza di coltivare una relazione tra un’impresa, i suoi dipendenti e la propria comunità. È in questo contesto che i criteri Esg avranno un peso nuovo e rilevante. «Anche la guerra in Ucraina sta cambiando la percezione di sicurezza e sta determinando una serie di cambiamenti nei principi e nelle assunzioni con cui aziende e gli Stati operavano. Tutto questo – spiega Dal Fabbro – genera forti cambiamenti nelle dinamiche europee e mondiali sull’energia, sulle materie prime, sulla finanza e sugli aspetti sociali. È diventato così essenziale soprattutto per le aziende (oltre che per gli stati) che si mettano al centro i criteri e gli obiettivi Esg.
Ed qui , a questo punto che scatta il tema della sostenibilità misurabile con la massima attendibilità e forza di comparazione, perché attraverso il monitoraggio dei criteri e obiettivi Esg «sarà sempre più importante per una gestione ottimale delle aziende».

Intanto, e proprio per questa nuova spinta, «la misurazione dei fattori Esg è ancora in grande evoluzione». Gli standard internazionali sono la base del lavoro di Dal Fabbro, il secondo passo è stato la selezione e l’allineamento di 21 fattori Esg più ricorrenti e più condivisi dai sistemi di rating, e dai 17 Goals Onu «vista la loro importanza universale».
La tecnica della content analys ha poi collegato i 21 fattori Esg con 137 criteri di misurazione di ogni dimensione Esg, a loro volta suddivisi per indicatore specifico sui tre Esg: ne è nata una matrice di allineamento (alto, medio, basso) che valuta, per esempio e in estrema sintesi, fattori come l’uso e tipologia di materie prime, il tipo di energia, da fonti rinnovabili o fossile, l’utilizzo dell’acqua e le risorse idriche, la localizzazione degli impianti o il numero di progetti per la tutela ambientale (biodiversità), livello e natura di ogni emissione per ogni tipo di gas liberato, la compliance ambientale fino alle misure di impatto sociale sia sulla comunità sia sui dipendenti (formazione, welfare, retribuzioni, pari opportunità, ambiente di lavoro).
Non sono informazioni scontate: un test sulle 15 maggiori società quotate, sul tema dell’energia solo il 40% sa distinguere fra energia diretta e indiretta, fra fonti green e non. È certo una questione di metrica, ma spesso anche di capacità di assegnare valore ai propri progetti di sostenibilità.
I tre fattori della sostenibilità
Ma, indicatore per indicatore, ecco che cosa è emerso dalla verifica del livello di standardizzazione dei parametri Esg. Cominciando dal primo, il criterio ambientale, Environmental, (E), in base a quanto riportato dal testo.
Tra i tre criteri Esg quello ambientale rileva il maggior grado di standardizzazione a livello globale, sia relativamente ai fattori ambientali considerati, sia per gli indicatori scelti per misurare. Così il 60% dei fattori Esg applicati risulta altamente “allineato”. Più complesso invece il fattore Social (S), anche perché più di difficile misurazione. L’ostacolo maggiore, secondo il 46% degli investitori interrogati è legato alla «difficoltà di analizzare e integrare questo fattore all’interno delle strategie di investimento».
Per esempio, per effetto della globalizzazione molte grandi imprese si trovano a «delocalizzare le attività produttive in aree che non soddisfano i requisiti minimi per esempio in materia di diritti civili, diritti minimi dei lavoratori, lotta al lavoro minorile o alla discriminazione».
Sull’ultimo criterio, di Governance (G) lo studio di Dal Fabbro ha rilevato invece una «discreta convergenza dei fattori applicati dalle agenzie di rating. Il 50% dei fattori applicati infatti risulta come ricorrente e con simili metriche di misurazione.
C’è poi un’ultimo fattore Esg che il libro di Dal Fabbro introduce: il Social Return on Investment (Sroi). Si tratta di un approccio nuovo per la misurazione e la rendicontazione di un più ampio concetto di valore, «con ll’obiettivo di integrare nelle analisi di progetti, programmi e politiche i costi ed i benefici sociali, economici e ambientali. Il dato nuovo sono i parametri monetari che vengono utilizzati per rappresentare il contributo contro i cambiamenti climatici. Un informazione nuova che gli «investitori che operano seguendo criteri d’investimento responsabile possono usare lo Sroi per assicurare che le attività in cui investono stiano effettivamente gestendo i rischi sociali, ambientali ed economici».
La nuova responsabilità dei consumatori

Il primo passo dell’Europa verso i cittadini: attenti al greenwashing
Aggiornate le norme a tutela dei consumatori per responsabilizzarli di più nelle scelte d’acquisto consapevoli e il diritto di conoscere la durata prevista di un prodotto e come può essere riparato. L’Europa ha anche rafforzato la tutela da dichiarazioni ambientali inattendibili o false.
Attenzione alla durabilità e al consumo di un prodotto
I consumatori devono essere informati della durabilità garantita dei prodotti. Se la garanzia commerciale di durabilità è superiore a due anni, il venditore deve informarne il consumatore. Per i beni che consumano energia il venditore deve informare i consumatori.
Basta buttare, tutti i prodotti si possono riparare
Le imprese e i venditori devono informare sulle riparazioni, come l’indice di riparabilità, o altre informazioni come la disponibilità di pezzi di ricambio. Per i dispositivi intelligenti e servizi digitali il consumatore va informato sugli aggiornamenti del software forniti.

Uno stop agli inganni sui falsi impatti ambientali
È vietato dare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe quando l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabili. Dichiarazioni generiche o errate sono: «rispettoso dell’ambiente», «eco» o «verde».
Il marchio di sostenibilità deve essere verificabile
È vietato esibire un marchio di sostenibilità che non è verificabile da parte di terzi o stabilito dalle autorità pubbliche. Lo stesso vale nel formulare una dichiarazione ambientale di un prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un suo aspetto.
La riparazione diventa una priorità, ma va sempre informata
Ogni prodotto di deve poter riparare. Ma è vietato omettere di informare che prodotto dispone di una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale.