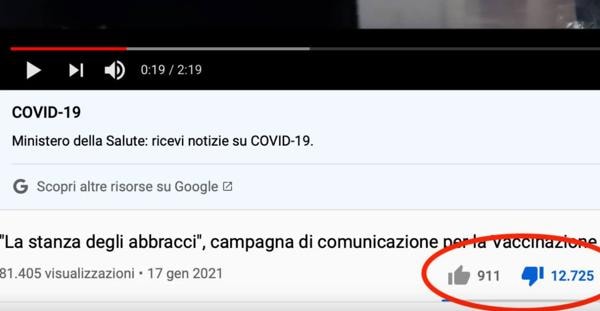La filiera italiana della fusione nucleare punta sull’innovazione per dare al Paese energia ‘green’
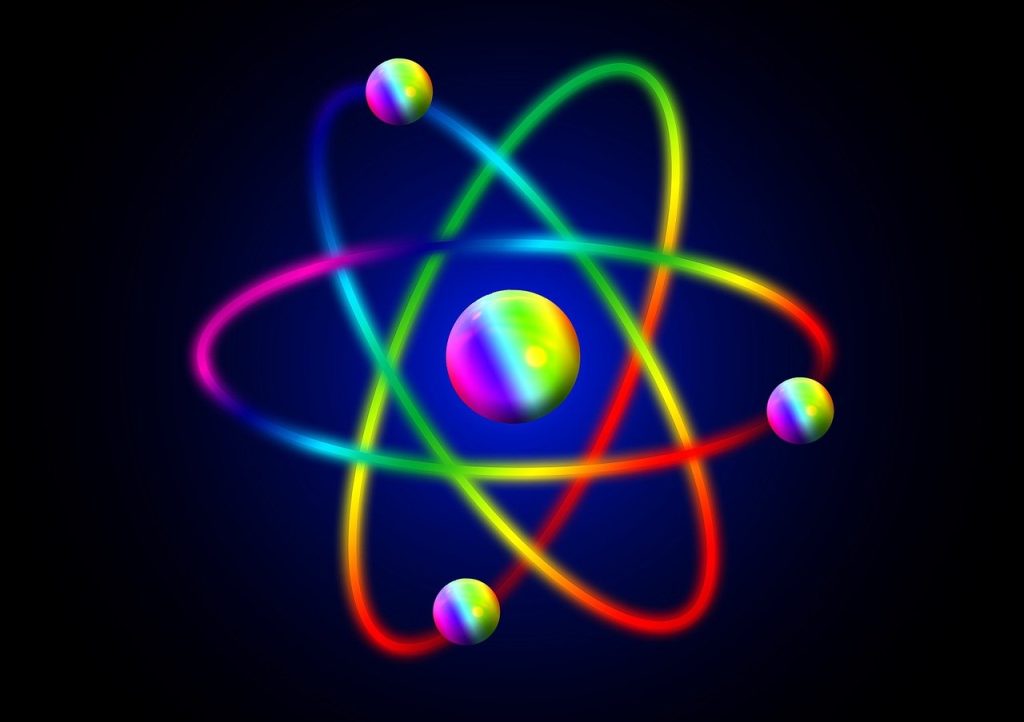
Nella transizione energetica verso le fonti rinnovabili e green ci sono molte incertezze e incognite da sbrogliare. Per esempio, le cosiddette fonti ‘alternative’ a quelle fossili e più inquinanti non possono colmare tutta la domanda di energia necessaria.
Ma c’è anche qualche punto fermo: serve una fonte energetica stabile e programmabile, perché solare ed eolico non lo sono, in grado di soddisfare un bisogno di energia, innanzitutto elettrica, che continua a crescere.
“Questa fonte energetica stabile e programmabile, e che non produce anidride carbonica, può essere il ‘nuovo’ nucleare, tecnologicamente avanzato, innovativo, ad esempio quello generato attraverso i mini-reattori di quarta generazione”, rimarca Umberto Minopoli, presidente Ain, Associazione italiana nucleare, in occasione dell’evento organizzato da Confindustria, presso la sede di via dell’Astronomia a Roma – ma disponibile anche online – sul tema ‘Verso una transizione energetica sostenibile. La filiera italiana della fusione: una filiera industriale strategica per la competitività dell’Europa’.
Un appuntamento che ha messo la filiera italiana della fusione nucleare al centro degli scenari energetici del Paese. Non a caso, il nucleare (più datato e tradizionale) e il ‘nuovo’ nucleare (quello più moderno e innovativo) contribuiscono già oggi a circa un quarto (circa il 25%) del fabbisogno energetico complessivo dell’Unione europea, e di questi tempi “il governo Draghi ha il merito di avere di nuovo legittimato la discussione sull’energia nucleare in Italia, dopo i referendum di trent’anni fa che ne hanno bloccato lo sviluppo”, fa notare Minopoli.
Come ha sottolineato pochi giorni fa in Tv anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, “più in là potremmo avere bisogno del nucleare, perché potrebbe non essere sufficiente l’accelerazione data dalle rinnovabili”. Cingolani fa notare: “che in Italia e in altri Paesi si sia deciso di non utilizzare le centrali nucleari di prima e seconda generazione con i vecchi referendum ha un suo senso. Quello che non ha senso è pensare che dietro l’aggettivo nucleare si celino solo ed esclusivamente tecnologie pericolose, poco efficaci e costose”. Il progetto di lungo termine, ha prospettato il ministro, è quello di “avere la fusione nucleare, diversa dalla fissione, dove si rompe un atomo grosso per avere energia, mentre nella fusione si prendono due atomi leggeri e si fanno fondere come succede nelle stelle”.
In questo scenario, operare nella filiera della fusione nucleare costituisce uno stimolo all’innovazione delle imprese, degli impianti e per le attività di ricerca e sviluppo: per il 70% delle aziende censite dall’Associazione italiana nucleare, “la partecipazione alla filiera della fusione ha un impatto molto alto sulla propensione a innovare. La maggior parte delle aziende ha fatto degli investimenti per entrare nella fusione, innanzitutto per l’acquisizione di competenze innovative, per realizzare innovazioni di processo e innovazioni organizzative”.
Il raggiungimento della neutralità carbonica – previsto dall’Unione europea entro il 2050 – “impone investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e ha bisogno di politiche industriali e fiscali adeguate”, osserva Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie imprese. Che mette in evidenza: “per filiere forti servono capacità di innovare, e poi credito e finanza per gli investimenti”.
Partnership, competenze e trasferimento tecnologico
Considerando le innovazioni introdotte negli ultimi cinque anni, “si conferma l’importanza di quelle organizzative e di processo, alle quali si aggiungono anche le innovazioni tecnologiche”, rileva Marco Ricotti, presidente del Cirten. Insomma, l’Industria 4.0 e la Transizione digitale dei sistemi interconnessi stanno espandendosi e rinnovando anche il mondo del nucleare. In questo scenario, “alla luce delle opportunità e della posizione di eccellenza raggiunta dall’Italia, la fusione merita senz’altro grande attenzione”, fa notare Ricotti.
Partnership, competenze specializzate e trasferimento tecnologico sono anche i principali fattori emersi da una ricerca dell’Università di Genova, e dalle case histories presentate nel corso dell’incontro, quelle di: Ansaldo Nucleare, Asg Superconductors, Fincantieri SI, Simic, Enea e Consorzio Rfx.
Le imprese italiane dotate di competenze, problem solving e creative thinking hanno un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti di altre nazionalità, e “Ansaldo Nucleare è pronta ad affrontare le sfide della transizione energetica”, sottolinea l’amministratore delegato, Luca Manuelli, “attraverso la visione New Clear, che caratterizza lo sviluppo industriale delle nuove tecnologie nucleari”.
Un settore innovativo per molte Pmi italiane
L’Italia è coinvolta nel più grande progetto internazionale di ricerca e sviluppo nel campo della fusione termonucleare controllata, il programma Iter (International thermonuclear experimental reactor), avviato nel 2006, e sviluppato su scala mondiale, in cui la Ue ha un ruolo di propulsione e leadership.
Il progetto Iter mette sul piatto 21 miliardi di euro, coinvolge imprese e centri di ricerca tra i più grandi al mondo, e “prevede la costruzione di prototipo, con l’obiettivo di creare sulla Terra le condizioni necessarie alla produzione di reazioni di fusione come quelle generate dal Sole”, spiega il presidente Ain: per la costruzione del prototipo sono previsti 15 miliardi di euro, ne sono stati già assegnati circa 7, di cui 1,6 miliardi alla filiera italiana, “che ha imprese d’eccellenza sul piano della ricerca scientifica e produzione industriale”.
L’Italia ha sempre avuto grandi eccellenze anche in questo settore – e nonostante il nucleare nel Paese sia stato accantonato da trent’anni –, “oggi Iter dimostra come attraverso la filiera molte Pmi siano riuscite ad affermarsi in un ambito altamente innovativo”, rileva Marchesini, “nella filiera della fusione le imprese lavorano massimizzando l’efficienza della ricerca scientifica”. E le attività di ricerca e sviluppo svolte in questo campo alimentano l’innovazione tecnologica anche in altri settori, come quello aerospaziale.
I reattori nucleari di quarta generazione
A differenza dei reattori nucleari di seconda generazione (la stragrande maggioranza di quelli attualmente in funzione), e terza generazione (un po’ più moderni), quelli di quarta generazione dovrebbero introdurre spiccate differenze soprattutto nei materiali impiegati, pur continuando a usare come ‘combustibile’ principalmente uranio e plutonio.
I reattori nucleari di quarta generazione sono un gruppo di sei famiglie di progetti per nuove tipologie di reattore nucleare a fissione, che, pur essendo da decenni allo studio, non si sono ancora concretizzati in impianti utilizzabili diffusamente in sicurezza. Alcuni osservatori e tecnici del settore ritengono che saranno disponibili commercialmente non prima di qualche decennio. Il compito delle attività di ricerca e sviluppo è anche quello di migliorarne le caratteristiche e funzionalità, e cercare di accorciare i tempi, che nel mondo dell’energia nucleare sono sempre molto lunghi e dilatati.