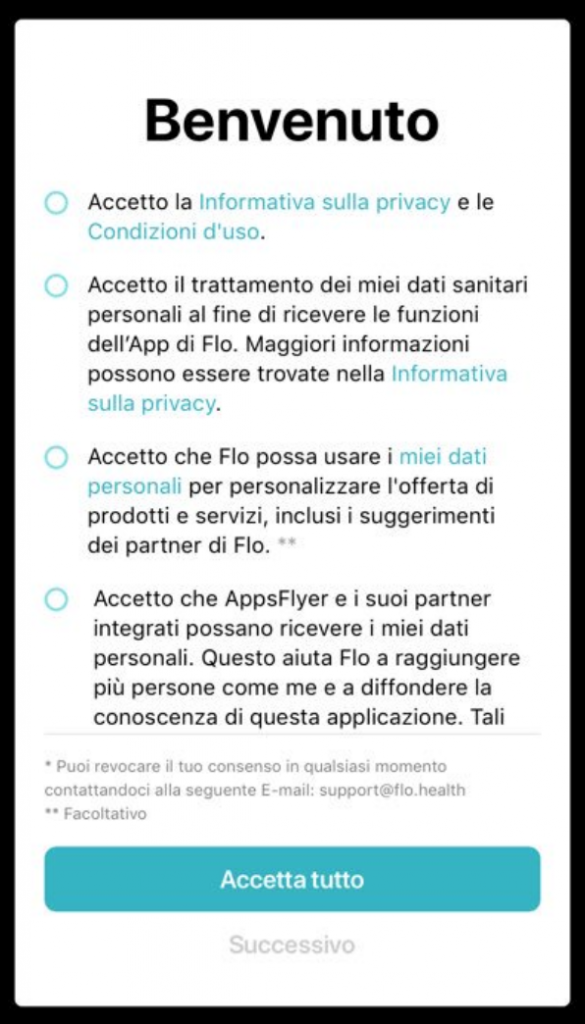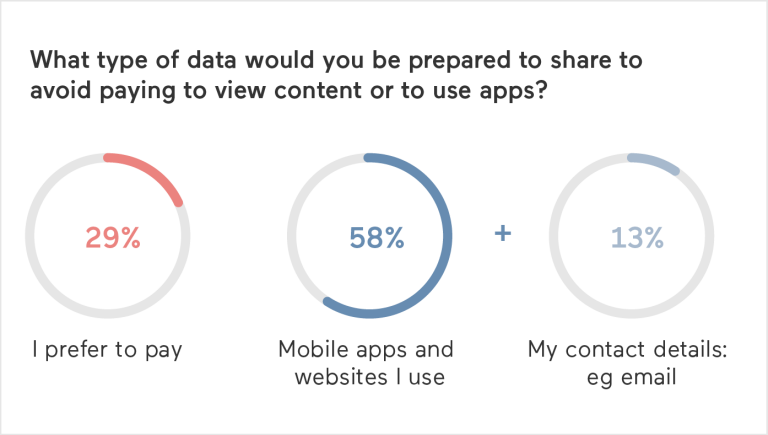C’è qualcosa di essenziale e di intangibile nelle start-up – un’energia, un’anima. I fondatori delle aziende ne avvertono la presenza. L’avvertono anche i dipendenti e i clienti. Quel qualcosa induce le persone a metterci il loro talento, i loro soldi e il loro entusiasmo, e promuove un senso di profonda connessione e di finalità comune. Finché questo spirito permane, il coinvolgimento è elevato e le start-up rimangono agili e innovative, a tutto beneficio della crescita. Ma quando scompare, le iniziative imprenditoriali possono perdere slancio, e tutti percepiscono la perdita – nel senso che è venuto meno qualcosa di speciale. La prima persona che ho sentito parlare dello “spirito di una start-up” era il CEO di un’azienda della classifica Fortune 500, che stava cercando di ricostruirlo nella sua organizzazione. Molte grandi aziende intraprendono iniziative di “ricerca e recupero” come questa, che riflettono una verità spiacevole: man mano che un’azienda matura, è difficile che tenga vivo il suo spirito originario. Fondatori e dipendenti confondono spesso l’anima con la cultura, e in particolare con l’etica libertaria di gente che lavora tutta la notte, job description flessibili, magliette, pizza, bibite gratis e un ambiente familiare. Notano quello spirito particolare e ne parlano in tono nostalgico solo quando non c’è più. A volte gli investitori calpestano la base psicologica di un’azienda, spingendola a “professionalizzarsi” e a snaturarsi per rispondere alle esigenze del mercato. E le organizzazioni che tentano di ricostruire una “mentalità imprenditoriale” tendono ad adottare un approccio superficiale, che affronta le norme comportamentali ma non va a incidere su ciò che conta veramente.
Nel decennio scorso ho studiato più di una dozzina di aziende in rapida crescita, effettuando più di 200 interviste con i loro fondatori e con i loro dirigenti, nel tentativo di capire meglio questo problema e come si può superare. Ho scoperto che mentre molte aziende faticano a mantenere lo spirito originario, la creatività, l’innovatività e lo slancio iniziale, alcune sono riuscite a farlo molto efficacemente, mantenendo così solide relazioni con gli stakeholder e assicurando la continuità e il successo delle loro iniziative imprenditoriali. Di conseguenza imprenditori, consulenti e studiosi come me enfatizzano spesso l’esigenza di implementare strutture e sistemi man mano che cresce l’azienda, relegando in secondo piano la necessità di conservarne lo spirito. Possiamo e dobbiamo concentrarci su entrambi gli aspetti. Con impegno e determinazione, i leader possono sostentare e proteggere la vera essenza delle loro organizzazioni.
Alla ricerca dello spirito organizzativo
Come si poteva immaginare, investitori e fondatori sembrano avere idee diverse sull’anima delle start-up. Nella mia ricerca ho scoperto che alcuni executive di società di VC e di private equity tendevano a considerarla un concetto illusorio o irrilevante. Si concentravano invece sull’applicazione del management professionale e della disciplina di processo alle aziende che avevano in portafoglio.
Quasi tutti i fondatori, per contro, erano convinti che le loro start-up andassero un po’ al di là delle missioni, dei modelli di business e del talento, anche se non erano in grado di dire esattamente in cosa consistesse quel “di più”. Per esempio, nel suo libro Onward, Howard Schultz descriveva lo spirito di Starbucks in questi termini: “I nostri punti vendita e i nostri partner [i dipendenti] danno il meglio di sé quando mettono a disposizione un’oasi, ossia creano un senso edificante di benessere e di connessione, e mostrano un profondo rispetto per il caffè e per le comunità che serviamo”. Ho intervistato un altro fondatore che identificava nella “lealtà verso i clienti e verso l’azienda l’essenza principale” di ciò che rendeva eccellente la sua azienda. Un terzo neoimprenditore definiva quell’essenza “una finalità condivisa, costruita intorno a un obiettivo audace e a una serie di valori comuni”. I primi dipendenti mi hanno detto di identificarsi profondamente nelle imprese per cui lavoravano: provavano ciò che Sebastian Junger, nel suo libro Tribe, chiama “lealtà, senso di appartenenza e l’eterna ricerca di significato che caratterizza gli esseri umani”.
Mi sono convinto perciò che queste persone, che conoscevano le proprie aziende meglio di chiunque altro, avessero scoperto davvero qualcosa. In tutte le tradizioni spirituali, l’anima umana viene definita spesso “il vero sé”. Per gli indù è l’atman. Per gli ebrei è la neshama. Mentre i teologi cristiani e i filosofi occidentali hanno dibattuto a lungo sull’esistenza e sulla natura dell’anima, molti credono che esista veramente e che sia eterna. Le decine di fondatori e dipendenti di start-up che ho intervistato la pensavano nello stesso modo, certi com’erano che le loro organizzazioni avessero un “vero” sé in cui si intrecciavano tutti gli stakeholder.
Dimensioni dell’anima
Ho iniziato a domandarmi se non si potessero catalogare gli elementi specifici di quest’anima che coinvolgevano gli stakeholder e favorivano il successo di un’iniziativa imprenditoriale. Mi chiedevo, in altre parole, quali aspetti di una start-up devono veramente preservare i leader man mano che cresce l’azienda.
Le mie indagini si sono appuntate su tre elementi che si combinano per creare un contesto lavorativo unico e stimolante: business intent, connessione con i clienti ed esperienza offerta ai dipendenti. Non sono semplicemente norme culturali finalizzate a influenzare il comportamento. I loro effetti scendono più in profondità, e innescano un tipo diverso, più intenso, di impegno e di performance. Danno significato al lavoro, rendendolo relazionale anziché meramente transazionale. I dipendenti si appassionano a un’idea galvanizzante, al concetto di servizio agli utilizzatori finali e alle gratificazioni distintive e intrinseche della vita lavorativa. Le persone sviluppano legami emotivi con l’azienda, e quei legami infondono energia nell’organizzazione.
Business intent. Tutte le aziende imprenditoriali che ho studiato avevano una finalità che le animava. Questo business intent nasceva di solito dall’imprenditore, che lo comunicava ai dipendenti per convincerli ad accettare posti sicuri in cambio di orari prolungati e di una paga relativamente bassa. Anche se tanti fattori – inclusa la prospettiva di un lauto guadagno con la rivalutazione delle azioni – avevano indotto le persone che ho intervistato ad andare a lavorare in quelle aziende, manifestavano tutte un desiderio più nobile di “fare la storia” in qualche modo, di partecipare a qualcosa di più grande. Volevano costruire imprese che migliorassero la vita della gente cambiando il modo in cui prodotti o servizi venivano creati, distribuiti o consumati. Molte aziende definiscono la propria missione o il loro perimetro di attività, ma l’intento che ho scoperto andava oltre, e veniva ad assumere un significato quasi esistenziale – una vera e propria ragion d’essere.
Considerate Study Sapuri, un’impresa giapponese nata nel 2011 all’interno del colosso multimiliardario di servizi integrati per la gestione delle risorse umane Recruit Holdings. Nel tentativo di rilanciare il business declinante della formazione, Fumihiro Yamaguchi, all’epoca un dipendente assunto da poco, ha ideato un sito web che avrebbe dovuto aiutare gli studenti dando loro libero accesso allo studio di guide per gli esami universitari. Quando ha presentato il progetto a un gruppo interno incaricato di lanciare nuove iniziative, ha spiegato che il sito avrebbe affrontato il problema dell’ineguaglianza educativa in Giappone consentendo a un maggior numero di persone di accedere a materiali di apprendimento – un intento che si armonizzava bene con la missione storica di Recruit Holdings: creare nuovo valore per la società.
Da quando è nata, Study Sapuri ha continuato a evolversi, ma sempre nel rispetto del suo intento originario. Ha commercializzato i suoi servizi, tra l’altro, come corsi di preparazione al college e come strumento per i corsi di recupero dei licei, e ne ha ampliato i contenuti fino a includere materiali didattici per le scuole elementari e medie. Nell’aprile 2015, tramite la casa madre, ha acquisito Quipper, che offriva servizi analoghi principalmente nei mercati del sudest asiatico. Il fondatore di Quipper, Masayuki Watanabe, ha detto di apprezzare l’operazione anche per l’intento di Study Sapuri: «Noi eravamo convinti che l’apprendimento sia un diritto e non un privilegio. Condividevamo la stessa visione». I migliori talenti la pensavano allo stesso modo. «Mi attirava l’idea di risolvere questi problemi», mi ha detto un dipendente. «Volevo venire a lavorare qui per offrire del valore effettivo ai clienti; gli utenti e i loro genitori possono rendersi veramente conto che la loro preparazione accademica sta migliorando». All’inizio del 2019, Study Sapuri era ormai un brand primario del business educativo di Recruit, con 598.000 abbonati.
Connessione con i clienti. Anche uno stretto legame con i clienti aveva un ruolo di primo piano nelle aziende di successo che ho studiato. Fondatori e dipendenti capivano perfettamente i punti di vista e i bisogni delle persone a cui si rivolgevano i loro prodotti e i loro servizi, e si sentivano personalmente connessi a loro, in un modo che ne liberava l’energia e la creatività. All’inizio, Nike mandava i suoi venditori – soprannominati Ekin perché dovevano conoscere i prodotti dell’azienda dall’A alla Z – in giro per gli Stati Uniti, non solo per presentare i modelli agli acquirenti, ma anche per raccogliere indicazioni da essi e riportare quelle informazioni al quartier generale. Molti Ekin, incluso il fondatore e allora CEO Phil Knight, erano così attaccati al brand da farsi tatuare sui piedi o sulle gambe il suo ormai iconico swoosh.
Nel colosso globale dell’asset management BlackRock, la missione è sempre stata migliorare la vita finanziaria dei clienti prevedendo flessibilmente i trend di mercato e minimizzando il rischio per mezzo di una piattaforma operativa computerizzata. E il cofondatore e CEO Larry Fink sottolinea ripetutamente la relazione insolitamente stretta che l’azienda intrattiene con i suoi clienti. Una tipica espressione di questo impegno è la decisione che prese fin da subito impegnando BlackRock a non fare trading in proprio. Altri fondi fanno questo tipo di trading, che è spesso estremamente redditizio, ma può determinare un conflitto di interessi. «La tentazione è fortissima», ha spiegato Fink. «Ma poi non possiamo più dire di essere fiduciari dei clienti».
La focalizzazione di Black Rock sui clienti ha conferito all’azienda un vantaggio competitivo, permettendole di attrarre più asset, oltre a diventare un urlo di guerra per il personale. «Non possiamo avere una conversazione senza parlare di clienti, perché sono l’unica cosa che conta», ha detto un dipendente. Un altro collaboratore di BlackRock ne ha messo in luce l’empatia: «Nel momento in cui capiamo veramente cosa vogliono e di cosa hanno bisogno i clienti, allora possiamo applicare la nostra expertise». Un terzo ha accennato all’idea «veramente semplice e chiara» di «aiutare persone reali … a costruire un futuro finanziario migliore». E un’indagine recente sul clima interno, più dell’80% dei dipendenti di BlackRock hanno detto di voler andare al di là dei requisiti-base delle proprie mansioni.
Esperienza offerta ai dipendenti. La mia ricerca ha fatto emergere una terza dimensione dell’essenza intangibile della start-up, una dimensione che concerne l’esperienza lavorativa in quanto tale. Ciò che distingueva le giovani imprese di successo non era una cultura “divertente” o “stravagante”, come vorrebbe lo stereotipo, ma piuttosto la creatività e l’autonomia inusuali che i dipendenti incontravano nel lavoro, che promuovevano un maggior coinvolgimento e risultati migliori. Dopo aver esplicitato il proprio business intent ed enfatizzato la connessione con i clienti, i leader lasciavano alle persone quella che ho chiamato “libertà all’interno di uno schema di riferimento” – la libertà di operare entro confini ben delimitati – e la possibilità di influenzare decisioni critiche, come quelle sulle strategie da perseguire o sui prodotti da sviluppare. Avendo sia “voce in capitolo” sia “libertà di scelta”, i dipendenti apprezzavano maggiormente il proprio lavoro e si sentivano più legati ai colleghi e all’azienda.
La catena di negozi di occhiali Warby Parker enfatizza l’esperienza offerta al personale fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2011. I collaboratori dovrebbero pensare con la propria testa, e l’azienda cerca persone capaci di autogestirsi. Nessuno ha bisogno di «incontrare ogni giorno un capo» per fare il suo lavoro, mi ha detto un dirigente. Autoespressione e input creativo sono apprezzati; i lavoratori non sentono il bisogno di autocensurarsi. Il cofondatore Neil Blumenthal ha creato anche un sistema di “iniziative” in cui i dipendenti presentano le loro idee tecnologiche su base trimestrale, e un premio assegnato trimestralmente – il Blue-Footed Booby Award – celebra quelli che esemplificano con il proprio comportamento i valori a cui si ispira l’azienda.
Ho scoperto che molte altre aziende hanno programmi strutturati per dare ai dipendenti voce in capitolo e libertà di scelta. I fondatori di un’azienda imprenditoriale, che aveva oltre 500 addetti e cresceva rapidamente, assegnavano tutti i nuovi assunti a team di cinque persone e chiedevano a ogni team di dedicare tre mesi a costruire un business potenzialmente in grado di distruggere uno dei business preesistenti. Poi i partecipanti potevano decidere se continuare a lavorare su quell’idea o assumere un’altra posizione all’interno dell’organizzazione. Molti dei nuovi business lanciati dall’azienda erano frutto di questo programma.
Come muore l’anima dell’organizzazione
In alcune imprese che ho studiato, lo spirito della start-up si è eroso nel tempo per gli interventi degli investitori e/o per le azioni dei leader – che o non capivano bene di cosa si trattava, o non ne apprezzavano l’utilità man mano che perseguivano la crescita. Li mettevano su questa strada pericolosa prima l’esigenza di sopravvivere e poi le pressioni per far crescere il business.
Le aziende giovani entrano spesso in una fase di espansione incontrollata. I loro leader possono diventare estremamente tattici e cambiare rapidamente e ripetutamente direzione, il che va benissimo se il business intent sottostante rimane invariato e continua a essere comunicato. Ma al di fuori di questa ipotesi, la continua rifocalizzazione dei leader potrebbe essere problematica. Possono innamorarsi talmente dei loro prodotti e dei loro servizi, e lasciarsi ossessionare così tanto dall’obiettivo di generare liquidità, da smettere di ascoltare clienti e dipendenti, e di restare in sintonia con loro.
Le start-up tendono effettivamente a fallire se non instillano disciplina e ordine nel proprio modo di operare man mano che crescono. Come hanno dimostrato la mia ricerca e quelle di altri, devono introdurre sistemi e processi formali, e assumere manager professionali. Questi cambiamenti possono essere enormemente produttivi se vengono messi in atti ponderatamente, con l’input di tutti gli stakeholder iniziali, la piena esplicitazione del business intent, e ferme restando la connessione con i clienti e l’esperienza offerta ai dipendenti. Ma c’è il pericolo che la maggior burocrazia e il “sangue nuovo” creino nei dipendenti un senso di soffocamento, indispongano i clienti e facciano venir meno lo spirito imprenditoriale. Ho intervistato parecchi CEO di lungo corso, “esperti nella gestione della fase di crescita”, che erano stati chiamati a sostituire i fondatori di aziende, e pur con le migliori intenzioni, avevano soppresso rapidamente lo spirito originario di quelle imprese.
Nell’azienda indiana di telefonia mobile Micromax, per esempio, nel 2011 i quattro fondatori hanno ceduto il controllo a un gruppo di dirigenti più esperti che hanno professionalizzato la pianificazione strategica, la gestione della supply chain, il management delle risorse umane e altre funzioni. A parere di quasi tutti, quei cambiamenti erano necessari ed efficaci al tempo stesso, visto che hanno prodotto numerosi miglioramenti a livello di performance. Ma c’era uno prezzo da pagare. Molti dipendenti pensavano di aver perso l’accesso ai leader, oltre al contatto diretto con i clienti e a una finalità chiara e ispiratrice – pensavano, in altre parole, che Micromax avesse perso la sua anima. Anche i fondatori si sentivano sempre più a disagio per quei cambiamenti, e nel 2013, quando le tensioni sono esplose, hanno deciso di riprendere in mano le redini dell’azienda. Successivamente hanno trasferito il controllo a un nuovo team di manager esterni – solo per ritrovarsi nella stessa situazione.
Ci vuole spesso una crisi per far notare alla gente che l’anima di un’azienda sta sparendo o è già sparita. Recentemente, sia Facebook sia Uber si sono scusate pubblicamente con i clienti per aver smarrito il proprio spirito iniziale. Nel 2018 centinaia di dipendenti di Google hanno chiesto all’azienda di accantonare il progetto per un motore di ricerca che avrebbe facilitato la repressione dei dissidenti in Cina. “Molti di noi hanno accettato il posto in Google pensando ai suoi valori”, scrivevano in una lettera inviata alla direzione, “incluso l’impegno a mettere i valori al di sopra dei profitti”.
Preservare l’anima
Si può trovare un punto di equilibrio in cui aziende dinamiche ad alta crescita aggiungono al proprio mix di fattori struttura e disciplina pur conservando i tre elementi critici che forniscono significato.
Mentre progettava il passaggio dalla spedizione per posta di DVD al modello di business successivo, Netflix è passata dalla distribuzione di video alla produzione di film e di serie televisive, esportando il nuovo modello dagli Stati Uniti ai recessi più remoti del mondo. È difficile immaginare che un’organizzazione possa mantenere la propria essenza originaria attraversando dei cambiamenti così profondi. Ma Netflix l’ha fatto, anche perché quelle mosse erano in linea con il suo intento strategico di diventare il miglior distributore globale di intrattenimento e aiutare i creatori di contenuti di tutto il mondo a trovare un pubblico. Ha mantenuto anche la sua promessa di marca – fornire ai clienti un servizio di qualità eccellente, ai fornitori un partner prezioso, agli investitori una crescita profittevole protratta nel tempo, e ai dipendenti la possibilità di avere un grandissimo impatto.
L’azienda ha creato nuove offerte innovative, inclusi contenuti originali di grandissimo successo, pensando costantemente alla sua audience. E ha continuato a offrire ai dipendenti un’esperienza in cui i manager disegnano un contesto organizzativo e operativo molto preciso, e poi lasciano i dipendenti liberi di prendere decisioni informate. Il messaggio è “Noi pensiamo che sappiate fare veramente bene il vostro lavoro”, spiega la chief talent officer Jessica Neal. “Non staremo a dirvi come svolgerlo, ma ci fideremo di voi e vi metteremo in condizione di farlo al meglio”. I selezionatori interni cercano dipendenti adatti a questa cultura e li addestrano a muoversi agilmente al suo interno. E il CEO Reed Hastings e altri leader hanno implementato tutta una serie di politiche, intese a dare ai collaboratori dell’azienda più voce in capitolo e più libertà di scelta. Hanno abolito i limiti alle ferie, sostituito regole formali di gestione del personale con direttive di normale buon senso, incoraggiato il feedback sincero e democratizzato il processo decisionale. «Le idee vengono presentate in conversazioni con tutti», mi ha detto la Neal.
Come altre start-up di successo in rapida crescita, anche Netflix è rimasta ostinata e flessibile al tempo stesso nella fase di crescita. In alcune aree ha praticato un agnosticismo radicale, abbandonando o modificando i suoi piani se necessario. Ma quanto a business intent, connessione con i clienti ed esperienza offerta ai dipendenti, ha adottato una linea senza compromessi, rafforzando e proteggendo questi elementi fondamentali nel corso del tempo. Ha cercato di proteggere preventivamente la propria anima.
Anche se uno dei tre elementi-chiave dell’anima di una start-up si è sgretolato, le aziende possono risolvere ugualmente il problema. Vediamo più in dettaglio il programma delle iniziative di Warby Parker. Mentre la catena incrementava gli organici e aggiungeva nuovi livelli di management, i suoi leader parlavano di “mantenere uno spirito da piccola impresa”. Ma gli ingegneri informatici dell’azienda, che a suo tempo avevano contribuito alla scelta dei programmi a cui dare la priorità, adesso si limitavano a eseguire i compiti loro assegnati. Per risolvere il problema e ricreare la vecchia esperienza offerta ai dipendenti, l’azienda ha messo a punto il programma “Warbles”, che permette agli ingegneri di suggerire e sostenere nuove iniziative tecnologiche, come modificare pagine web e migliorare l’iter di processazione degli ordini, che vengono poi esaminate e votate dal senior management. Il programma enfatizza anche l’intento strategico. «Per ogni iniziativa che viene proposta, chiediamo alle persone di stabilire dei parametri di misurazione coerenti con i nostri obiettivi strategici», mi ha detto il cofondatore Dave Gilboa. E benché i progetti vengano classificati in base al numero di voti ricevuti, gli ingegneri possono decidere di perseguirne uno qualunque tra quelli in elenco se pensano che sia in linea con le loro priorità e pensano che possa generare il massimo valore. «Se è un nuovo lavoro che vogliono imparare o una nuova tecnologia, noi gli lasciamo quella libertà», ha chiarito Gilboa. Adam Szatrowski, principal software engineer, ha aggiunto: «È qui che rifulge l’autonomia».
Quando il danno all’anima dell’azienda è particolarmente grave, a volte i fondatori tornano in scena per ricostituirla. Nel 2008, Howard Schulz è tornato a ricoprire il ruolo di CEO in Starbucks perché, come ha spiegato nel suo libro, “aveva la sensazione che mancasse qualcosa di intrinseco al brand Starbucks”. Nei mesi successivi, ha adottato diverse misure per rilanciare lo spirito originario dell’azienda. In particolare, ha organizzato una sessione residenziale in cui i leader hanno riflettuto a tutto campo sul brand e si sono concentrati specificamente sulle relazioni con i clienti. Come ha detto ai suoi più stretti collaboratori, «Gli unici filtri al nostro pensiero dovrebbero essere i seguenti: [l’iniziativa] renderà orgogliosi i nostri dipendenti? Migliorerà l’esperienza dei clienti? Rafforzerà l’immagine di Starbucks nella mente e nel cuore dei nostri clienti?» Settimane dopo, quando ha presentato un piano di trasformazione agli investitori, Schulz ha invocato un ritorno al business intent originario dell’azienda, dicendo: «Ci sono persone tra voi … che hanno creduto nel sogno di un giovane imprenditore – creare un brand nazionale intorno al caffè, e costruire un tipo di azienda con una coscienza sociale … È ora di convincere voi e tante altre persone … a tornare a credere in Starbucks».
SALVAGUARDARE L’ANIMA di un’organizzazione è una parte critica, ancorché poco apprezzata, del lavoro dei fondatori, al pari di aree decisionali non meno critiche come il modello di governance e i frazionamenti azionari. Netflix, Nike, BlackRock, Warby Parker, Study Sapuri e Starbucks hanno prosperato tutte come start-up di successo grazie agli sforzi messi in atto deliberatamente dai loro fondatori per preservare l’alchimia che ne aveva fatto delle grandi aziende imprenditoriali fin dall’inizio. A lungo andare, un’anima forte e ben caratterizzata conquisterà e appassionerà vari stakeholder. Anche quando creano processi formalizzati, disciplina e professionalizzazione, le imprese dovrebbero cercare di preservare la trinità spirituale del business intent, della connessione con i clienti e dell’esperienza offerta ai dipendenti. È il segreto non solo della crescita, ma anche della grandezza.