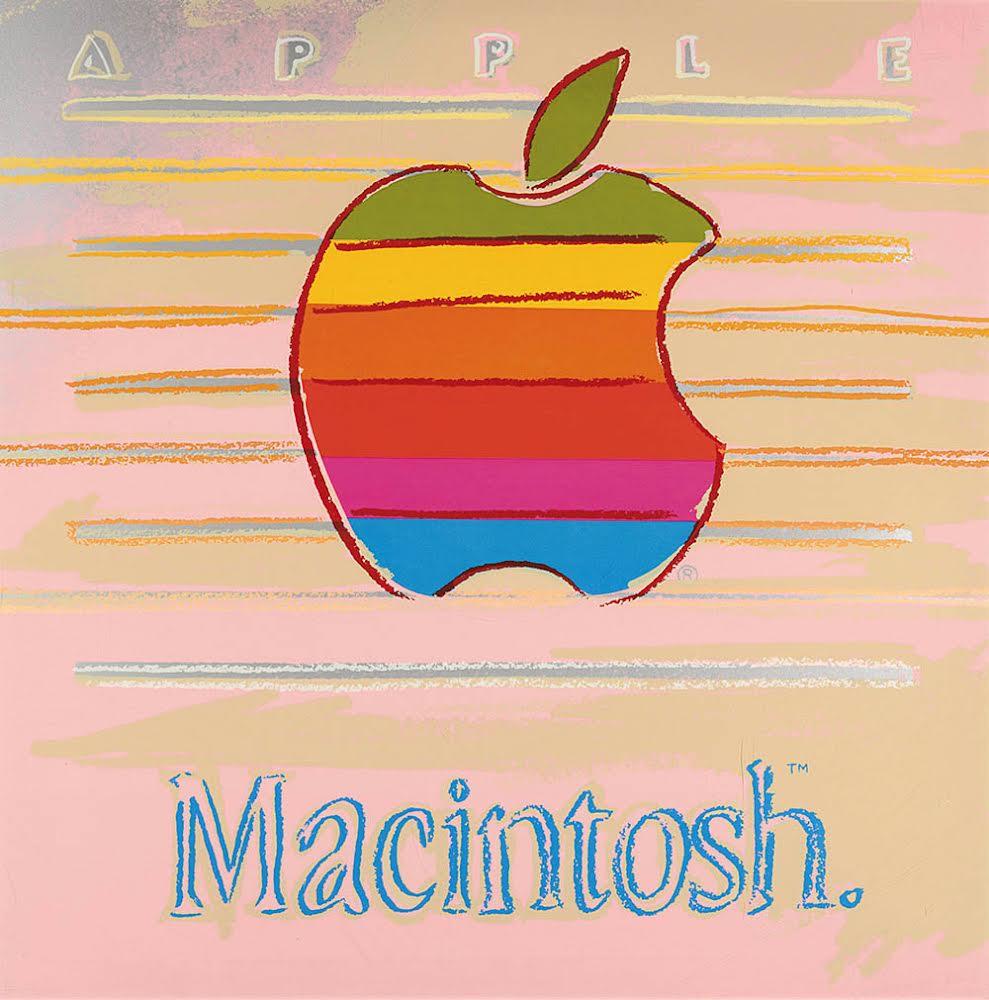Un piano nazionale per la formazione all’AI: USA, Cina, UK e Germania hanno avviato programmi per la formazione all’AI. E l’Italia?
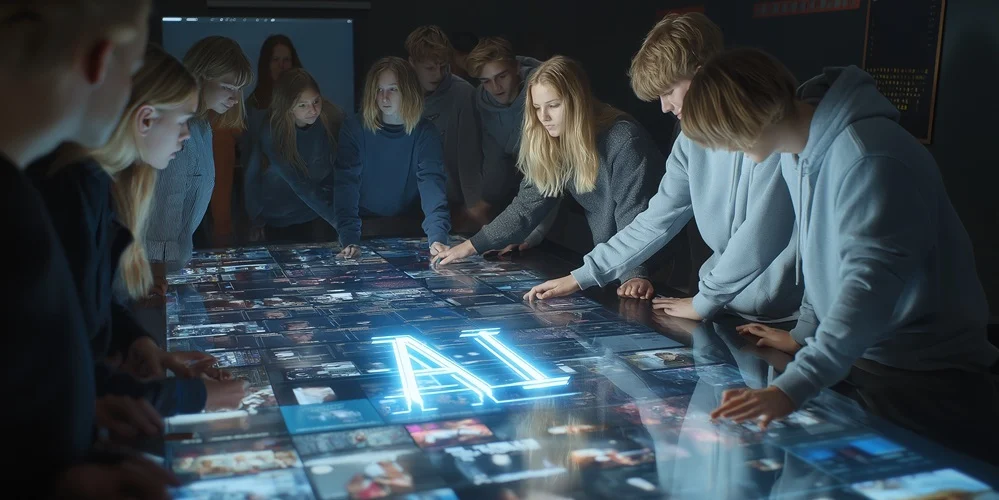
L’Intelligenza Artificiale sta provocando nei Paesi avanzati lo sviluppo di piani nazionali per la formazione in ambito scolastico e per la riqualificazione professionale. Una esigenza che nasce dalla consapevolezza dei governi dell’impatto potenziale dell’AI sull’occupazione, sulle competenze e sulla produttività. Parliamo quindi di progetti strategici per il sistema Paese. Proviamo allora ad analizzare alcuni casi internazionali per trarre delle valutazioni utili soprattutto nell’ottica di avviare una riflessione sullo sviluppo di un piano nazionale in Italia.
UK: il piano Starmer
Il premier Keir Starmer ha annunciato la partnership con undici Big Tech globali per formare 7,5 milioni di lavoratori all’Intelligenza Artificiale entro il 2030. Il focus viene posto sugli strumenti tecnologici, forniti dalle stesse aziende produttrici. Verrà sviluppata una piattaforma per la formazione permanente dei lavoratori all’AI. Nella scuola viene annunciato il programma TechFirst da 187 milioni di sterline, focalizzato su nuovi laboratori tecnologici, competenze digitali richieste dalle aziende, formazione dei docenti.
Cina: l’AI nelle scuole
Pechino ha lanciato il suo primo piano nazionale per trasformarsi in una “potenza educativa” entro il 2035. Il programma del Ministero dell’Istruzione Cinese, rivolto sia agli studenti che al corpo docente, prevede l’inclusione dell’IA nei materiali didattici, nei programmi di studio e nelle attività di insegnamento. L’introduzione sistematica dell’AI nella scuola punta a generare capitale umano ad alta specializzazione, elemento fondamentale per lo sviluppo di settori strategici quali robotica, biotecnologie, semiconduttori, difesa e cybersicurezza. Questa visione posiziona l’educazione come uno degli assi centrali della nuova sovranità tecnologica cinese. Il Ministero ha inoltre sottolineato che le tecnologie AI renderanno le lezioni più dinamiche e coinvolgenti, incentivando un approccio più creativo all’apprendimento. Nelle università cinesi sono stati aperti numerosi corsi sulla Intelligenza Artificiale. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei programmi scolastici cinesi rappresenta molto più di una riforma educativa: è una scelta di politica industriale, tecnologica e geopolitica.
USA: investimenti, task force, concorsi
Il presidente Trump ha avviato una Task Force per l’Educazione all’Intelligenza Artificiale, e firmato un ordine esecutivo ad aprile, invitando le scuole a integrare l’AI nelle classi di tutti i livelli scolastici “per garantire che gli Stati Uniti rimangano leader globali in questa rivoluzione tecnologica”.
Viene lanciato anche il Presidential Artificial Intelligence Challenge, un concorso che metterà in risalto i risultati ottenuti da studenti e insegnanti in tutto il Paese.
Vengono potenziati anche i programmi di apprendistato e formazione permanente.
Negli USA anche i privati si muovono: è stato siglato un accordo tra Microsoft, OpenAI e Anthropic, per finanziare la formazione dei docenti all’uso dell’Intelligenza artificiale, con un investimento di 23 milioni di dollari a favore dell’American Federation of Teachers.
Germania: focus sui settori economici e sulla tecnologia nazionale
Il piano da 20 miliardi annunciato dal Cancelliere Mertz ha come obiettivo una Germania leader dell’AI, in particolare nei settori chiave dell’economia. L’aumento della concorrenza da parte di nazioni come Cina e Stati Uniti richiede una strategia chiara che non solo investa in ricerca e sviluppo, ma che favorisca anche l’educazione e la formazione di talenti nel campo dell’AI.
La Germania si sta rendendo conto che la competitività futura non dipenderà solo dal suo patrimonio industriale, ma anche dalle nuove tecnologie e metodologie emergenti, sulle quali il paese ha accumulato un ritardo.
Il piano si basa anche sulla collaborazione tra start-up, fondamentali per creare un tessuto industriale innovativo, e istituti di ricerca, e intende implementare programmi di formazione per riqualificare la forza lavoro.
Alcune osservazioni sui piani internazionali
Occorre ora analizzare queste strategie internazionali per poter sviluppare una progettualità alternativa, adatta al contesto italiano e possibilmente migliorativa. Nel caso inglese il coinvolgimento delle Big Tech USA configura un potenziale conflitto di interesse, oltre che una minaccia per la sovranità tecnologica di quel Paese. Farsi raccontare dall’oste (le Big Tech) quanto è buono il vino (l’AI) è una scelta discutibile, specie per un governo europeo. Si prospetta, sempre per lo stesso motivo, una potenziale sottovalutazione dei rischi connessi all’AI (atrofia mentale, dipendenza, Bias, allucinazioni e molto altro). Si prospettano addirittura alcune situazioni paradossali, come nel caso delle “politiche di supporto psicologico per chi vive il cambiamento come una minaccia”, che potrebbero trasformarsi in campagne di persuasione occulta di massa a favore di prodotti di aziende private. Peraltro, anche voler porre gli strumenti AI al centro del contenuto della formazione è per certo riduttivo: questi, infatti, evolveranno rapidamente rendendo obsolete le competenze acquisite, diventeranno inoltre sempre più facili e semplici da utilizzare, in certi casi vanificando l’utilità della formazione stessa. Il modello cinese risulta più solido essendo finalizzato alla costruzione di asset e competenze nazionali, anche se rischia di avere un approccio fortemente tecno-centrico. Analogamente, la Germania punta a recuperare il ritardo sulle tecnologie digitali, inserendo la formazione all’AI nel quadro di un colossale investimento per l’innovazione della economia tedesca, in tutti i settori. Negli USA, infine, il piano istituzionale presenta alcune idee innovative (concorso, task force) e risulta separato da quello dei privati, che peraltro investono direttamente anche nell’ottica di aprirsi futuri mercati pensando alle nuove generazioni.
Per un piano nazionale italiano
Il contesto italiano presenta alcuni aspetti problematici: la debolezza dei player tecnologici nazionali, l’elevata età dei docenti e il ritardo annoso nella alfabetizzazione digitale: fattori che rendono la nostra strategia più complessa. Tuttavia, i recenti investimenti del PNRR hanno introdotto – almeno nella scuola – molti dispositivi tecnologici, che possono essere valorizzati in un piano di formazione all’AI purché si agisca tempestivamente. Da qui una serie di spunti di riflessione indirizzati al disegno di un possibile piano nazionale italiano di formazione all’AI.
AI Act e tavolo europeo
Un piano nazionale italiano non può prescindere dal contesto europeo. In particolare, occorre tenere conto, così come già avviene in Germania, delle linee guida dell’AI Act di Bruxelles, che pone alcuni vincoli – in termini di rispetto della privacy, conservazione dei dati presso data center in Europa, rispetto del copyright – piuttosto difficili da accettare per le Big Tech americane o cinesi. Ci sono anche indicazioni di natura etica che pongono il settore educativo tra quelli ad alto rischio, e ciò va considerato. Alcune strategie, soprattutto anche di politica industriale e occupazionale, dovrebbero quindi essere condivise a livello europeo. In conclusione, l’idea di un tavolo europeo potrebbe consentire all’Europa di promuovere sia una risposta competitiva, capace di ridurne l’artificial divide, sia una cornice di norme e valori a presidio di una cultura dei diritti che appare sempre più minacciata.
Monopoli e facoltà discrezionale
Un ulteriore aspetto, sempre in coerenza con le indicazioni europee, riguarda i monopoli digitali. Deve essere combattuta quella dipendenza da singoli player, specie se extraeuropei, che si è conosciuta in passato con i motori di ricerca (Google), il software e i sistemi operativi (Microsoft), i social (Meta), l’e-commerce (Amazon). Pur non escludendo il ricorso a strumenti offerti dalle Big Tech, va abilitata e presidiata la facoltà discrezionale tra tools diversi, anche attraverso sistemi tecnologici che permettano ad esempio di passare agevolmente da un modello AI all’altro, anche semplicemente per cogliere le opportunità che si affacciano con una continua evoluzione tecnologica e la specializzazione funzionale (es: traduzione automatica, sintesi vocale, AI multimodale, operativa, creativa, organizzativa…).
Le intelligenze artificiali – al plurale
Come indicato dal Rapporto Draghi per la competitività europea, nel vecchio continente è fondamentale collegare l’AI ai diversi settori economici e della ricerca. Anche in tema di formazione occorre quindi superare la metafora dell’unica Intelligenza Artificiale, magari antropomorfica, per analizzare e trattare, invece, le diverse tecnologie AI applicate nei settori del sapere e dell’industria. La visione artificiale per la diagnostica medica non va, ad esempio, confusa con l’AI conversazionale dei servizi, e neppure con quella predittiva applicata alla meccatronica. Una corretta alfabetizzazione all’AI quindi non si basa banalmente sull’uso popolare di ChatGPT; al contrario, passa attraverso una analisi funzionale delle diverse tecnologie e dei relativi obiettivi e contesti.
Open Source e AI come commodity
Ogni 18 ore, nel mondo, viene rilasciato un nuovo modello AI Open Source, utilizzabile gratuitamente da sviluppatori – per creare nuove applicazioni di alto livello -, e da utenti. Questa risorsa si unisce alle tecnologie di distillazione, che già hanno permesso, ad esempio, al modello cinese Deepseek di riprodurre, in tempi e costi limitati, le prestazioni dei grandi modelli USA. Si può cominciare a intravedere uno scenario in cui l’AI potrebbe diventare una commodity, una merce disponibile a basso costo da diversi fornitori, capace quindi anche di un’ampia gamma di soluzioni per la formazione e lo sviluppo di nuovi strumenti.
Il ruolo dei docenti
Come indicato dal Ministro Valditara, il ruolo dei docenti dovrà comunque essere cruciale. Nel saggio “Conoscenza o barbarie, storia e futuro dell’Educazione”, Jacques Attali disegna un quadro e una prospettiva difficili per il mondo dei docenti, che stanno vivendo una contrastata fase identitaria, motivazionale e anche di autorevolezza, rispetto alle informazioni e funzioni offerte dalle piattaforme digitali. Il docente va pertanto riposizionato nel contesto di un nuovo ecosistema dove l’AI entra in classe e nei dispositivi dei docenti, i quali, ora, interpretano nuovi ruoli: quelli, ad esempio, del controllo critico o della mediazione culturale digitale.
Una nuova mediazione culturale digitale
La comunità educativa ha quindi di fronte a sé un nuovo ruolo strategico: trasformare il web e l’AI da rischio in risorsa.
Attualmente gli smartphone e i social sono considerati vere e proprie armi di “distrazione di massa” che hanno ridotto il Quoziente Intellettivo delle nuove generazioni. L’AI può fare ancora peggio, soprattutto se abbandonata all’attuale fai-da-te degli studenti che genera forme di atrofia mentale. Ecco che allora ai docenti spetta il compito di una nuova rilevante sfida: quella di farsi mediatori tra la sfera digitale e gli studenti. In quest’ottica sarà importante adottare piattaforme di aggregazione e content curation, in grado di valorizzare e potenziare i contenuti positivi presenti in rete, e occorrerà rispettare nell’AI il principio di trasparenza delle fonti, per distinguere quelle autorevoli dall’universo fake.
Controllo critico e autorale
Gli strumenti di formazione con AI devono alimentare e mantenere attivo il controllo critico di docenti e studenti. Occorre andare quindi oltre le “scatole nere” che contraddistinguono l’AI odierna, per rendere disponibili sistemi in grado di trattare documentazioni specifiche, compresi video o altri contenuti multimediali, ma anche di impostare facilmente il ruolo e il comportamento degli agenti AI, e di progettare interfacce creative per raggiungere determinati obiettivi. In sostanza, strumenti che sviluppano il senso critico e la creatività autorale nell’AI.
Personalizzazione
La personalizzazione dell’apprendimento, auspicata anche dal Ministro Valditara, è sicuramente una opportunità offerta dall’AI che ci aiuta a superare l’approccio omologante dei sistemi educativi tradizionali, specie se si realizza sotto il controllo della funzione docente e della comunità educativa che allontanano il rischio di un rapporto uno-a-uno tra studente e piattaforma.
Ciò comporta strumenti didattici diversi dalle piattaforme di massa come Google, Meta o ChatGPT, basate sulla disintermediazione verso gli utenti finali: bisogna invece sviluppare soluzioni che introducano il docente nel processo di personalizzazione dell’apprendimento.
Tecno-metodologie
La pedagogia tradizionale non è più sufficiente nel contesto dell’apprendimento con l’AI: occorre pensare a nuove tecno-metodologie. Quali ad esempio:
- l’Innovation Design, che consiste in una metodologia di ricerca applicata che adotta le tecnologie emergenti per realizzare sperimentazioni e prototipi di nuovi servizi e prodotti nella scuola, anticipandone la successiva diffusione nella società e nelle aziende;
- la workplace simulation, che è invece la riproduzione di ambienti e processi lavorativi, realizzata con realtà virtuale e Intelligenza Artificiale;
- la didattica incrementale, infine, che prevede fasi crescenti di interazione: dalla fruizione di contenuti esistenti alla rielaborazione e creazione di nuovi contenuti.
Scuola e lavoro: laboratori con AI
La didattica della formazione all’AI può prendere la forma di attività laboratoriali realizzate anche con l’AI. Vanno progettati laboratori per le discipline umanistiche e per gli indirizzi tecnici e professionali. Ad esempio, è importante abilitare la competenza nelle microlingue specializzate dei diversi settori, simulare attività professionali, arrivare a progettare il futuro di aziende e comparti, sviluppare competenze manageriali già pensate per essere “estese” dall’Intelligenza Artificiale.
Umanesimo e Homo Extensus
L’umanesimo nasce in Italia e contraddistingue la nostra cultura e sensibilità. Un tratto italiano dell’Intelligenza Artificiale può e deve nascere da questa nuova visione umanistica, nella quale la persona è posta al centro, ma in una forma evoluta: la visione dell’Homo Extensus. Una prospettiva che parte dal presupposto che già in passato l’intelligenza umana ha compiuto dei salti evolutivi interagendo con tecnologie cognitive. Ciò è avvenuto infatti con la scrittura alfabetica, con gli strumenti di osservazione scientifica, con la stampa, con nuovi media, e oggi con l’Intelligenza Artificiale. La sfida progettuale che dobbiamo affrontare è quindi quella di immaginare le future forme di quella che chiamiamo “intelligenza estesa”. Homo Extensus allude, pertanto. ad un modello antropologico emergente, necessario per orientare anche la formazione. Se rinunciamo a immaginare che tipo di persona dobbiamo formare per il futuro, se non ne abbiamo idea, la triste conseguenza è che non disponiamo della base pedagogica per impostare un piano di formazione su vasta scala.
Per una formazione alla “intelligenza umana estesa”
Per tutto quanto si è fin qui detto la formazione dovrebbe essere più centrata sul lato umano e professionale: sul ruolo delle persone e dei professionisti nel contesto dell’AI, e su come questa può potenziare la loro competenza ed efficienza.
Oltre a focalizzare gli strumenti AI, che – si badi – invecchiano dopo soli 6 mesi, dobbiamo evidenziare le competenze umane “estese”. In ogni campo va quindi immaginata la forma futura dell’intelligenza umana estesa dall’interazione con l’AI: dal docente al giornalista, dal manager all’artista.
Non è scontato né facile saper progettare le nuove forme dell’intelligenza estesa, ma è questa la prossima sfida entusiasmante che attende la comunità educativa. E noi siamo pronti ad affiancarla.
Per approfondimenti: AI-Book “Homo Extensus” di Gualtiero e Roberto Carraro – https://homo-extensus.ai-book.it/category/leducazione-estesa/