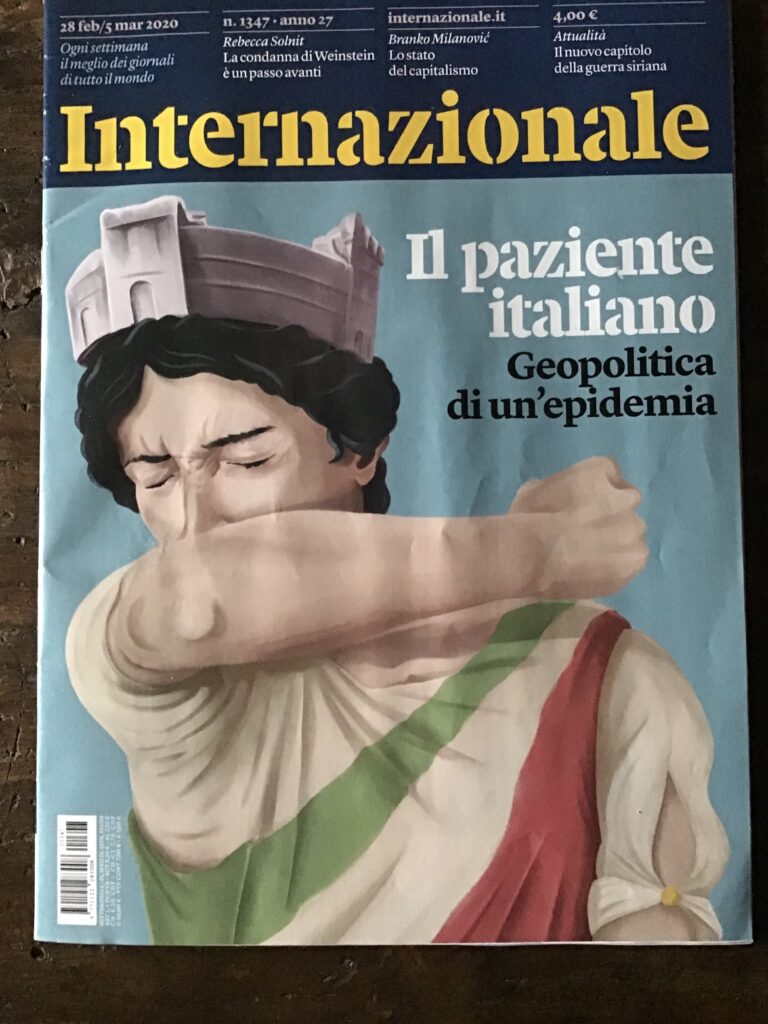Dalla crisi del coronavirus si esce in tre modi: digitale, digitale, digitale

Siamo giustamente concentrati sull’immediato, perché sconfiggere il virus oggi è fondamentale. Ma potrebbe tornare, e quindi bisogna attrezzarsi fin da ora. Con una serie di modelli da copiare, che hanno puntato tutto sulla tecnologia: Corea, Singapore e Taiwan
Per quanto durerà il tempo del contenimento contro il Coronavirus? Inutile girarci intorno: durerà a lungo. Secondo le previsioni, la curva dei contagiati non potrà decrescere seriamente prima della fine di aprile. Ovviamente, ciò non esclude che molti positivi al virus saranno ancora presenti sul territorio nazionale, con il rischio di riattivare focolai di contagio. Senza contare il passaggio possibile, salvo chiusura delle frontiere, di nuovi infetti provenienti da altri paesi europei, dove il virus comincia a circolare con qualche settimana di ritardo rispetto all’Italia. Non sappiamo se il caldo della bella stagione sarà in grado di sospendere la circolazione del virus. Che, in ogni caso, tornerà con l’arrivo del freddo, riprendendo vigore in autunno e in inverno. Anche i tempi per l’individuazione e uso del vaccino – studio, sperimentazione, produzione, distribuzione – saranno lunghi (si parla di almeno un anno, più probabilmente 18 mesi). Se è vero tutto ciò che abbiamo qui elencato, significa che le misure di contenimento e di isolamento, non si sa con quale grado di intensità, non potranno essere completamente superate per diversi mesi.
Ci vuole tempo. Ma servono soluzioni
Che cosa succederà nel frattempo? Difficile immaginare di tenere impegnati gli italiani a cantare da finestre e balconi l’inno d’Italia o Azzurro o Poo-poroppo-popo-poo, a un’ora indicata, ogni giorno per molte settimane. Così come sembra improbabile tenere chiuse tanto a lungo le attività economiche senza impedire la distruzione di lavoro e l’impoverimento generalizzato fino al tracollo totale del paese. Senza dimenticare l’impatto psicosociale della restrizione in casa con la possibile esplosione di conflitti, depressione, attacchi di panico, abuso di sostanze, omicidi e suicidi.
C’è da chiedersi se non sia questo il momento di cercare altre soluzioni, ispirandosi non tanto o non soltanto alle misure costrittive cinesi – impedire la libertà di movimento e la libertà d’impresa, certamente più ‘facili’ in un regime autoritario – quanto, piuttosto, alle misure ‘tecnologiche’ – basate sull’intelligenza artificiale e sui big data – applicate in Corea del Sud, Singapore, Taiwan. La risposta a questa domanda è certamente: «sì».
Come ha risposto l’Italia
Ma prima di capire quali sono queste misure tecnologiche, ricordiamo quali sono i capisaldi della nostra reazione all’arrivo dell’epidemia. Com’è normale che sia, l’Italia ha messo in campo le attitudini che meglio la caratterizzano. La risposta medico-sanitaria, fondata sul Servizio sanitario nazionale, considerato uno dei migliori nel mondo (è così almeno al Nord, dove si trova l’epicentro della crisi). L’attenzione ai più vulnerabili, anziani, portatori di patologie e malati cronici, che, purtroppo, in molti casi, non riescono a sopravvivere al contagio. La vocazione all’emergenza nata e gestita dalla Protezione civile nella gestione dei terremoti e fondata sull’apporto dei volontari. La capacità di sacrificio morale e di partecipazione civica dei cittadini che, dopo una breve fase di sorpresa, sembrano rispondere bene alle misure contribuendo attivamente alla realizzazione di una politica pubblica nazionale. Infine, la promessa di intervento statale, forzando definitivamente i vincoli europei, per fornire aiuto a quei lavoratori e a quelle imprese che subiranno tutto il peso della chiusura forzata delle attività.
Tuttavia, ognuna di queste positive attitudini nazionali ha dei risvolti preoccupanti. Il Servizio sanitario nazionale non è così forte come si pensa: il numero di posti di terapia intensiva al Nord non è adeguato alla quantità di contagiati che necessitano di cure e molte regioni del Sud rischiano il collasso se i numeri degli infetti fossero gli stessi della Lombardia. La stessa Protezione civile non sembra più la stessa di qualche anno fa e non è ancora stata utilizzata per realizzare quelle zone di assistenza intermedia tra l’isolamento in casa e l’acuzie in ospedale che la Cina ha messo in piedi nelle palestre e nei capannoni. In più, essere bravi ad agire in stato di emergenza potrebbe significare che non lo siamo nel governo ordinario dei processi. Dei cittadini abbiamo già detto che potranno sopportare restrizioni pesanti soltanto per un tempo definito oltre il quale le cose, soprattutto sul piano economico, potrebbero diventare disastrose. Non parliamo poi dello stato del debito pubblico italiano, la cui situazione è nota, e che non potrà che peggiorare quando bisognerà ulteriormente indebitarsi – al quel punto sarà giusto farlo, ovvio – per affrontare la recessione da virus.
Che significa “governare” nel corso di un’epidemia?
Tutto questo può bastare? Al netto della enorme riconoscenza per tutti coloro i quali, ogni giorno, fanno il massimo per salvare le vite dei cittadini, la risposta probabilmente è: «no».
L’Italia non può limitarsi all’approccio clinico-sanitario suggerito da medici e scienziati benemeriti. Né consegnarsi alle strategie repressive di un regime totalitario come la Cina. Il governo del paese non può ridursi alla resistenza al virus. La tutela della salute e della vita ha la precedenza, ma non può ammalare l’Italia di povertà. Stiamo salvando i più vulnerabili ma rischiamo alla fine di ritrovarci in un paese di zombi. La prudenza – splendida virtù cardinale – che ci ha fatto chiudere l’Italia a marzo dovrebbe dirci che l’harakiri non può essere lo strumento ideale per fronteggiare Covid-19. Insomma, il problema del governo è un po’ più complesso dell’impedire il sovraccarico degli ospedali. La scelta fatta dal nostro governo, dopo tanti tentennamenti, è radicalmente diversa rispetto a quella – a dir poco temeraria – che farà il Regno Unito, ma potrebbe rivelarsi comunque un azzardo. Sempre che l’azione emergenziale contro l’epidemia non si trasformi presto in una strategia di governo capace di convivere con un’epidemia ancora presente (con il rischio che i contagi possano comunque riprendere), di prevenirne le possibili conseguenze future e garantire l’esercizio di una normale vita lavorativa ed economica.
Quali sono gli altri strumenti di governo? Certamente gli investimenti specializzati in sanità per aumentare il personale medico-sanitario e creare strutture sanitarie ad hoc. La realizzazione di strutture di assistenza intermedia o di quarantena utilizzando quartieri fieristici, palestre e fabbricati. La trasformazione (o l’ampliamento) delle catene produttive (per esempio, al fine di fabbricare la quantità necessaria di mascherine o di tamponi). Potrebbe essere necessario perfino un controllo ferreo delle frontiere per impedire il contagio “di ritorno”. Ma soprattutto bisogna fare una cosa: usare la tecnologia. Come è successo in Corea del Sud, a Singapore, a Hong Kong e a Taiwan (dove il numero di decessi e di contagi è proporzionalmente inferiore rispetto a quello del nostro paese).
Buone pratiche dai paesi asiatici (no, non parliamo della Cina)
«Ciascuno a suo modo, Singapore, Taiwan e Hong Kong – tre posti con caratteristiche socioeconomiche e politiche notevolmente diverse – sono stati in grado di interrompere la catena della trasmissione della malattia. E lo hanno fatto senza abbracciare le misure drastiche e altamente dirompenti adottate dalla Cina. Il loro successo suggerisce che anche altri governi possono fare progressi». Così scrive sul New York Times Benjamin J. Cowling, professore di epidemiologia delle malattie infettive all’Università di Hong Kong.
A Hong Kong, per esempio, città che condivide un confine con la Cina continentale ed è formalmente parte della Cina, spiega Cowling, «subito dopo il primo caso dichiarato a Wuhan, sono state ampliate le stazioni di screening della temperatura esistenti nei luoghi di ingresso e ai medici locali è stato chiesto di segnalare alle autorità sanitarie della città qualsiasi paziente con febbre o sintomi respiratori acuti risalendo alla “storia” del recente viaggio a Wuhan». Dopo i primi cinque giorni di controlli, prosegue Cowling, «chiunque attraversava il confine – specie se proveniente dalla Cina continentale – doveva sottoporsi a un periodo obbligatorio di auto-quarantena di 14 giorni. Allo stesso modo sono stati rintracciati e messi in quarantena quanti hanno avuto stretti contatti con i positivi registrati. E siccome la trasmissione poteva verificarsi prima che una persona infetta mostrasse i sintomi, la tracciatura ha incluso tutte le persone che erano entrate in contatto con il paziente a partire da due giorni prima dell’inizio della sua malattia».
Tra le buone pratiche segnalate dalla Technology Review del MIT di Boston c’è il monitoraggio che la Corea del Sud sta realizzando sui cittadini in quarantena tramite una app per smartphone – sia Android che iPhone – sviluppata dal Ministero degli Interni e della Sicurezza. In sostanza, come ricorda Max S. Kim nell’articolo, «migliaia di persone nel lockdown del coronavirus saranno monitorate per rilevare i sintomi, per assicurarsi che restino a casa e che non diventino dei “super-diffusori” del virus; per tenere traccia della loro posizione e per assicurarsi che non stiano rompendo la quarantena sarà utilizzato anche il GPS». L’adozione di queste misure di monitoraggio tecnologico ha considerevolmente limitato l’esplosione dei contagi e, di conseguenza, dei decessi.
«C’è un limite alle risorse umane disponibili per i governi locali per monitorare le persone in quarantena», afferma Jung Chang-hyun, funzionario del ministero che ha supervisionato lo sviluppo dell’app. «L’app è un servizio di supporto volto a rendere più efficiente l’attività di osservazione».
Aggiunge Jung: «Le persone possono uscire dalle aree di quarantena sia intenzionalmente che per errore: ma poiché esiste il rischio di infezione secondaria in entrambi i casi, speriamo che l’app, con una maggiore organizzazione, possa aiutare a bloccare questi incidenti». L’app si unisce a un elenco di altre misure lanciate per combattere l’ondata di nuovi casi in Corea del Sud, tra cui: le stazioni di test «drive-through» per verificare la positività al coronavirus (circa 15 mila al giorno in più), una serie di servizi cartografici sviluppati da privati che monitorano gli spostamenti dei positivi, gli avvisi di emergenza che i governi municipali e distrettuali inviano regolarmente ai telefoni delle persone per informarli di nuovi casi di coronavirus. Ricordiamo che in Corea del Sud, dopo l’esplosione iniziale la curva dei contagi ha già iniziato a flettere: mentre scriviamo, sono morti circa 70 pazienti su circa 8 mila contagi (numeri assai modesti rispetto al caso dell’Italia). Importante la disponibilità del governo sudcoreano a condividere la sua tecnologia con altre nazioni: «Non abbiamo ancora avuto richieste da altri paesi, ma se arrivassero, saremmo pronti a condividere assolutamente queste esperienze», assicura Jung.
Qualcosa del genere è accaduto a Singapore. «Colpita in anticipo, per il fatto di essere uno dei principali partner commerciali della Cina, ma forte dell’esperienza con il virus SARS del 2002-3, Singapore ha iniziato a monitorare attentamente i casi per trovare i punti in comune che li collegavano. Nel giro di un giorno o due, successivi alla scoperta di un nuovo caso, le autorità sono state in grado di mettere insieme la complessa catena di trasmissione da una persona all’altra, come un moderno Sherlock Holmes in possesso di un database. A partire da febbraio, tutti coloro che sono entrati in un edificio governativo o aziendale a Singapore hanno dovuto fornire i dettagli di contatto per accelerare il processo». A raccontare la vicenda di Singapore, ancora una volta sulla Technology Review del Mit, è Spencer Wells, genetista, antropologo, già collaboratore della National Geographic Society. Secondo Walls, «non è semplicemente la capacità di rilevare i casi e spiegare perché sono successi che rendono Singapore un modello di riferimento in questa epidemia: kit di test per acido nucleico sono stati rapidamente sviluppati e distribuiti nei luoghi di entrata al paese. Entro tre ore, mentre gli individui vengono messi in quarantena sul posto, i funzionari possono confermare se sono stati infettati o meno dal virus prima di consentire loro di entrare».
Il caso di Taiwan – a un passo dall’epicentro dell’epidemia, quasi 24 milioni di abitanti, più del doppio della Lombardia, concentrati in poco più di 36 mila km quadrati – lo racconta bene sul suo profilo Twitter Fabio Sabatini, docente di politica economica dell’Università La Sapienza. «Data la frequenza dei voli dalla Cina, si prevedeva che Covid-19 avrebbe travolto l’isola, invece ha registrato soltanto 50 contagi e 1 decesso: come hanno fatto?», si chiede l’economista.
Ecco la sua ricostruzione: «Grazie all’esperienza della SARS, Taiwan ha riconosciuto subito l’emergenza. Il 31 dicembre 2019, tutti i passeggeri provenienti da Wuhan sono stati sottoposti a screening a bordo, prima di scendere dall’aereo. I passeggeri sbarcati da Wuhan nei 14 giorni precedenti sono stati rintracciati e visitati. Quelli con sintomi sospetti sono stati messi in quarantena e accuratamente monitorati. Pochi giorni dopo, le autorità hanno integrato il database delle informazioni sanitarie di tutti i cittadini con i dati dell’agenzia dell’immigrazione. Sono state rintracciate tutte le persone a rischio, che avevano recentemente manifestato sintomi e avevano storie di viaggio sospette. Inoltre, il sistema integrato genera un allarme ogni volta che un paziente a rischio chiede assistenza medica, consentendo ai sanitari di identificare immediatamente i potenziali casi di Coronavirus».
Ovviamente non è mancata la fase del contenimento anche a Taiwan. Ma anche questo è stato realizzato con strumenti digitali. «I pazienti a rischio – perché con sintomi, per aver transitato in aree a rischio nei 14 giorni precedenti o per eventuali contatti con dei contagiati – sono messi in quarantena e testati. Inoltre – avverte Sabatini – devono installare sullo smartphone una app per il monitoraggio di sintomi e spostamenti. Grazie al sistema di tracciamento mediante lo smartphone, è possibile ricostruire la rete di contatti di tutti i contagiati, al fine di testarli, curarli in isolamento e interrompere la catena di contagio».
Come si legge nell’editoriale di Jason Wang, della Stanford University, pubblicato sul Journal of The American Medical Association, il governo ha informato i cittadini con conferenze stampa e comunicati estremamente dettagliati: «un po’ diversi dai bollettini della nostra Protezione Civile, purtroppo», chiosa Sabatini. È stato spiegato pubblicamente che, a causa dell’emergenza, gli ospedali e le farmacie avrebbero temporaneamente avuto accesso alle informazioni sui viaggi dei pazienti. Secondo i sondaggi il pubblico ha reagito molto bene. Nel frattempo scuole, università, palestre e ristoranti sono rimasti aperti. Se e quando il virus si diffonderà, le autorità potranno così contare su un sistema di contrasto già ben rodato.
Tracce digitali per impedire il contagio (e salvare l’economia)
Ovviamente, ricorda Sabatini, «per noi è tardi e il lockdown è necessario. Tuttavia, c’è il rischio che, se non si tracciano i contagiati e la loro rete di contatti al fine di isolarli e curarli, al primo allentamento del lockdown l’epidemia riprenderà a galoppare».
Una deduzione confermata dal paper appena pubblicato su Lancet per il quale bastano pochi casi isolati in circolazione per rilanciare il contagio. In conclusione, avverte Sabatini: «in Italia abbiamo bisogno di un sistema di tracciamento simile a quelli dei paesi orientali che stanno riuscendo, per ora, a contenere l’epidemia. Che cosa aspettiamo?».
Nelle scorse settimane due studiosi come Alfonso Fuggetta, professore di Informatica del Politecnico di Milano, e Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia dell’Università Bocconi, hanno proposto alle istituzioni italiane un progetto per l’uso di big data per il governo strategico dell’epidemia. Ma sono rimasti inascoltati. «La Corea del Sud sta sconfiggendo l’epidemia anche grazie a semplici tecnologie di contact tracing del contagio su smartphone. In Italia, è stato proposto alle autorità l’uso delle stesse tecnologie, settimane fa, ma hanno preferito il modulo cartaceo con l’autodichiarazione», ha scritto Carnevale Maffè su Twitter. «In Corea del Sud – aggiunge Carnevale Maffè in un altro tweet – il fattore di riproduzione (R0) è già stimato sotto 1, grazie alla georeferenziazione dei casi di contagio e alla identificazione dei singoli focolai su mappe molto precise. Le tecnologie salvano la vita, nel rispetto della privacy». Questo perché la proposta si basa su un processo di raccolta dei dati in forma anonima e quindi nel pieno rispetto della privacy delle persone. Verrebbe da dire che, di fronte ai limiti della libertà di movimento e di impresa, alla distruzione del lavoro, all’impoverimento generalizzato e al suicidio dell’economia di un intero paese, una piccola rinuncia alla privacy non sarebbe poi così grave. Qualcuno potrebbe pure obiettare che non ci sono risorse sufficienti per un’operazione del genere. Ma ne servirebbero infinitamente di meno rispetto a quelle che saranno necessarie per resuscitare l’economia.