Quando usciremo dalla peste comunicativa
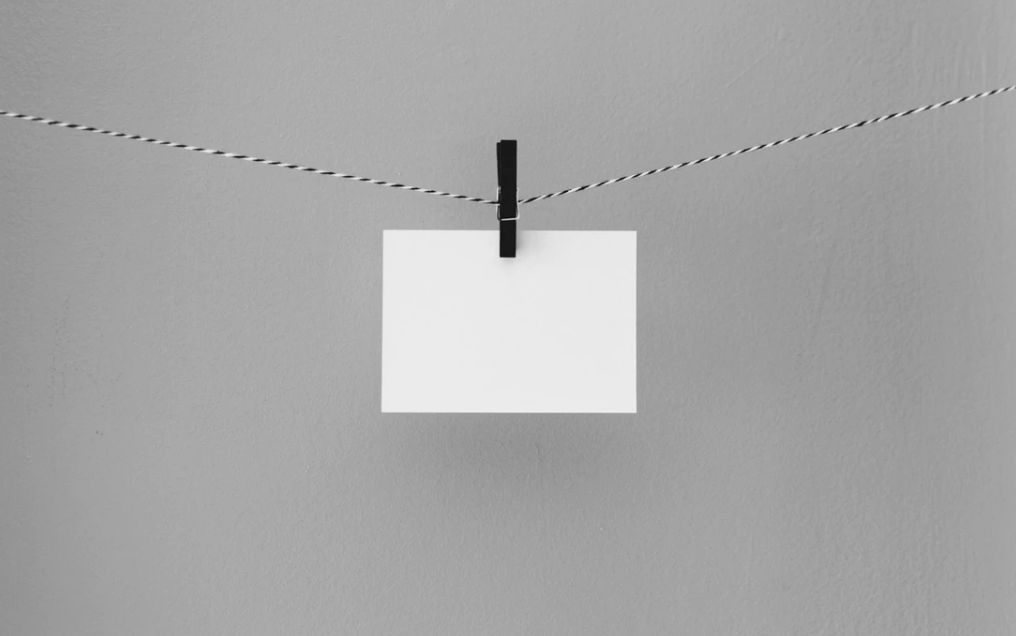
Pubblichiamo in esclusiva un articolo scritto nei primi giorni del 2030, quando una legge sancirà drastiche misure contro la deriva della comunicazione.
Qualche giorno fa (il 1 gennaio di questo 2030) è entrato in vigore il decreto 323/29. Esso impone a ogni organizzazione privata, pubblica o sociale operativa sul territorio nazionale, l’adozione di modalità narrative e di rendicontazione delle proprie attività ispirate al principio che la comunicazione, analogica e digitale (compresa la pubblicità!), è sì un importante strumento di formazione e orientamento della conoscenza e delle opinioni, ma non è fine a se stessa: va sempre e comunque orientata a far nascere, crescere o chiudere una o più relazioni con uno o più segmenti di stakeholder (“aventi titolo”), che siano questi interni (dipendenti), esterni (clienti) o di confine (azionisti, fornitori).
Relazioni comunque e sempre finalizzate al raggiungimento di obbiettivi espliciti e condivisi. In caso contrario, sia l’organizzazione che il titolare del supporto distributivo (analogico o digitale) sono soggetti a sanzioni amministrative.
Il nuovo orientamento (obbligatorio!) della comunicazione
Diverse decine di migliaia di operatori (programmatori, influencer, storyteller, blogger, giornalisti, decisori pubblici, relatori pubblici, lobbisti e tessitori sociali sul territorio) con aspettative diverse, spesso opposte e col fiato sospeso, sono ansiose di verificare se il drastico dettato del 323/29 riuscirà davvero a orientare le organizzazioni e i loro operatori verso pratiche comunicative più discorsive e dialoganti, meno invasive, prepotenti e insistenti, non opinabili e soprattutto più con-vincenti (dal latino vincere-cum).
Dopo un decennio 2020-2029 che ha visto la rappresentazione delle organizzazioni letteralmente “divorare” il valore della loro rappresentanza, spingendole a transitare da un già deleterio shortermismo al ben noto e frenetico nowtermismo, per i proponenti del decreto è fondamentale che le attività comunicative si orientino verso un governo delle relazioni con gli stakeholder. E, ora che sappiamo per certo che la velocità dell’algoritmo è calibrabile in funzione di regole, spazi e obiettivi negoziati e condivisi, che rallentino la velocità.
Ricordiamo qui alcuni momenti del passato focalizzando anche sulle organizzazioni non politiche. Troppo facile sparare solo sui politici e le loro rispettive “bestie”.
I peggiori casi di cattiva rappresentazione dal 2020 in poi
Per esempio la vicenda del ponte Morandi, la cui rappresentazione ha largamente distrutto lo spirito e il capitale sociale di una delle più importanti città italiane: un danno davvero irreparabile partito con la grottesca ripresa sui social del “grandefratello” Casalino del funerale delle vittime del crollo, poi passato per il perlomeno insolito doppio incarico a Comin e Barabino per la tutela della reputazione di Autostrade (a Roma il primo, a Genova il secondo); fino a una conferma “temporanea” (eternamente, “salvo intese”…) di una concessione che ha fortemente diminuito patrimonio e mito di una famiglia identificata per decenni con il successo dell’Italia nel mondo (altro ingente danno al nostro capitale sociale).
Più recentemente, con il governo giallorosso già in coma, un reputato comunicatore già responsabile digitale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e che orgogliosamente sottolineava la propria appartenenza ai comunicatori duri e puri, da cinque giorni dirigente della comunicazione del Ministro della Innovazione (dopo avere transitato fra Eni e Agi con l’incarico di rappresentare tutto il rappresentabile), scaraventa sull’arena della rappresentazione un (si fa per dire) piano dell’innovazione in cui l’imbarazzo degli osservatori si è alternato fra pochezza e banalità del contenuto e l’ispirazione dichiaratamente casaleggiana in pieno conflitto di interesse. Di tutto e di più, purché se ne parli.
Incrociamo poi il sistema bancario, dimentico delle mai chiarite vicende MPS che hanno anche portato alla misteriosa e tragica fine del bravo comunicatore Davide Rossi, prontamente dimenticato dai colleghi; e immemore delle devastazioni del vignaiolo Zonin e dei dirigenti delle altre banche venete e popolari. Un sistema che si trova in parallelo di fronte a una robusta rappresentazione dei principi di responsabilità sociale, di rendicontazione integrata, di valorizzazione del ruolo delle donne… e il giorno dopo (Unicredit) annuncia tranquillamente, come se niente fosse e scontando le reazioni “forzatamente” smorzate dei sindacati, una riduzione di migliaia di posti di lavoro.
Una mossa che peraltro passa quasi inosservata, perché a sua volta incalzata dal crollo, previsto e scontato da almeno un decennio, della Banca Popolare di Bari, con tanto di indagini di corruzione (destinate sicuramente a perdersi nelle nuvole di dati) per il padre padrone nonché presidente ella Banca. Naturalmente solo dopo diversi mesi si capisce che tutta la kermesse era frutto di un disegno comunicativo che “rappresentasse” agli italiani l’opportunità di una ennesima commissione parlamentare di indagine che, vivaddio, è riuscita per un soffio a evitare un’“inverosimile” presidenza esplicitamente antisemita, ma che ha comunque dirottato per mesi e mesi l’attenzione dalle questioni vere che hanno poi portato al crollo economico e finanziario del 21/22.
Il forsennato utilizzo a senso unico della rappresentazione è visibile anche dalla decisione di 180 grandi imprese multinazionali americane di annunciare inopinatamente che andava riscritta del tutto la “ragione esistenziale” (in inglese purpose) dell’impresa, retrocedendo i sempre favoriti azionisti a un ruolo paritario con altri interlocutori come i dipendenti, i fornitori, i clienti e la società civile. Belle parole, nessun impegno, nessuna scadenza.
Al contrario, non più tardi di qualche giorno dopo l’uscita pubblica, il responsabile della stesura di quella revisione (CEO della Johnson&Johnson, che aveva appena “confessato” al New York Times l’emozione di essersi sentito, durante la stesura, “come Jefferson”), è stato condannato da un tribunale a un’elevatissima multa per avere ecceduto nella quantità di oppioidi nei suoi prodotti. E così una rappresentazione immotivata e fine a se stessa ha avuto l’effetto di accelerare la fine dell’infatuazione verso la cosiddetta CSR (un obiettivo sensato, a cavallo fra Greta e la catastrofe ambientale).
La rappresentazione oltre il marketing e il sogno americano. Finalmente.
Ci sono tanti altri recenti episodi di rappresentazione immotivata e controproducente, dalla Boeing alla Wells Fargo, dalla Monsanto alla Via della Seta alla TAV (da entrambe le parti).
Fin da piccolo – padre diplomatico italiano e madre figlia di diplomatico britannico – ho avuto innato il senso della “rappresentanza”, e ho sempre pensato che la “rappresentatività” fosse una valutazione di merito del suo esercizio. Quella che oggi chiamiamo la “rappresentazione”, la narrazione erga omnes della rappresentanza, veniva interamente assorbita nelle prime due accezioni.
Oggi non è più così, ma è bene sapere che fino al 1960 la funzione del governo delle relazioni nelle organizzazioni operava alla grande, e alle dirette dipendenze dei vertici organizzativi. Furono l’esportazione nel mondo del sogno americano e dei consumi di massa che resero il marketing più rilevante. L’esplosione digitale ha solo rafforzato questa linea, perché ci si era erroneamente convinti che la comunicazione fosse la finalità dell’esercizio rappresentativo e non il suo strumento.
Difficile dirlo oggi nel 2030, ma sia Bernays, che Ivy Lee nei primi decenni del Novecento, e poi Grunig negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, avevano non solo praticato, ma sostenuto e argomentato questa verità, travolti però dall’ondata globale del sogno americano. Quel sogno che, con l’accelerazione incontrollata della velocità ha prodotto tutte le ineguaglianze che ancora oggi, nel 2030, affliggono miliardi di persone, costrette a migrare da una terra all’altra in condizioni di vita disperate.
Concludendo, per i suoi proponenti l’applicazione del decreto 323/29 rappresenta un piccolo, ma significativo passo, meno accidentato e più civile, verso un territorio relazionale fra individui, gruppi, organizzazioni, robot e algoritmi.



