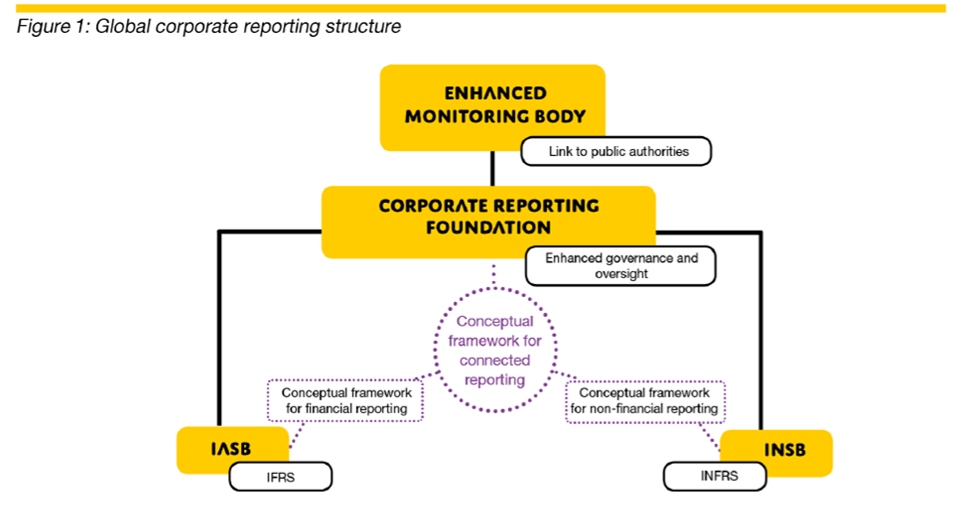Tutte le questioni che il coronavirus pone alla comunicazione di crisi. La proposta di Gianluca Comin all’HuffPost: un incontro tra i direttori dei grandi gruppi editoriali per fronteggiare e dare regole nell’emergenza, e non solo
“La pandemia passerà, come altri fenomeni del genere non dovrebbe durare a lungo, ma l’infodemia resta, e pone delle sfide nuove a tutti noi”. Il virus partito dal mercato di Wuhan oltre a produrre angoscia e attenzione, a porre un’infinità di problemi pratici, ha creato un’importante corto circuito nel delicato settore della comunicazione delle emergenze. Un unicum che pone delle questioni globali e inedite. Ne abbiamo parlato con Gianluca Comin, docente di strategie di comunicazione della Luiss e fondatore Comin and Partners.
Solo oggi, filtrano dalla Cina notizie di farmaci efficaci, smentite dall’Oms. Siamo di fronte a una vera e propria campagna mediatica. Sta funzionando la comunicazione della pandemia?
C’è stata una prima fase in cui tutti hanno comunicato troppo, dalle istituzioni ai medici e ai media, ovviamente tutti con il duplice obiettivo di non creare panico e di “collocare” il rischio perché possa essere governato, ma si è prodotta una sensazione di poco coordinamento. Troppe voci. Poi si è cambiato registro, e la situazione è migliorata, dopo la confusione iniziale oggi c’è decisamente maggiore ordine nella comunicazione. E ho trovato interessante il coordinamento del ministero della Salute con twitter per difendersi dalle fake news.
Che tipo di emergenza è il coronavirus, che problemi pone alla comunicazione di crisi?
È una crisi globale, che pone diverse condizioni. La tua comunicazione si deve confrontare con quella di altri Paesi: è una crisi non localizzata, che tocca tutte le categorie di persone, con una diffusione più ampia possibile. Una crisi che riguarda la salute delle persone, e questo è il classico caso in cui spesso si dà più credito al barista che al medico. Queste condizioni rendono oggettivamente più complicata la gestione della comunicazione. Ma non è finita, una pandemia di questo tipo coinvolge più istituzioni, dal ministero agli ospedali ai porti, e riuscire a coordinare una comunicazione univoca è complicato. Poi c’è un’altra caratteristica: si tratta di un evento in divenire, a differenza di un sisma o di una catastrofe che ha un tempo limitato, una pandemia si sviluppa nel tempo e necessita di continui aggiornamenti: sui contagi, sulle guarigioni, sulle aree di crisi… Tutto questo esige una comunicazione dinamica, più complicata rispetto a una comunicazione che si definirebbe puntuale.
Un passo indietro: da esperto, come si comunica un’emergenza?
Innanzitutto si parte dai pilastri: trasparenza e tempestività, i cittadini vogliono essere aggiornati correttamente e costantemente – più bollettini più volte al giorno, per esempio -; in gioco c’è l’emotività delle persone, di qui la necessità di usare un linguaggio che siamo abituati a sentire. Un uso esagerato del linguaggio scientifico e di termini tecnici possono disorientare. Un altro fattore è la concretezza, ossia dare istruzioni precise su prassi reali: come comportarsi, che tipo di attrezzature usare, come affrontare ambienti di potenziale contagio o come affrontare un viaggio. Infine, ma è molto importante, c’è la capacità di reagire in maniera tempestiva rispetto a comunicazioni false.
E qui entriamo nel tormentato mondo digitale, dei social, delle fake news. Croce e delizia di chi lavora nell’informazione, figuriamoci in un momento di crisi come quella del coronavirus.
Purtroppo le fake news sono ormai prassi in qualsiasi ambito, il punto è come contrastare questo tipo di comunicazione falsa, nata per disorientare o creare panico. Certo, i social media sono fondamentali, veloci. Serve però anche l’autorevolezza dei media tradizionali. L’obiettivo deve essere equilibrare la comunicazione sociale e digitale con comunicazione offline e televisiva. In questo senso, è importante coinvolgere comunità di persone credibili, esperti, professori, giornalisti di fama che rendono autorevole il messaggio, in un momento in cui le istituzioni in generale non godono di grande reputazione pubblica. Ovviamente non puoi arginare le fake news, ma cercare di costruire una comunicazione credibile, trasparente e continua.
Qual è il confine tra corretta informazione ed eccessivo controllo? Dopo un proliferare di informazioni dei primi giorni oggi filtra poco.
In un mondo come il nostro è velleitario pensare di censurare qualcosa, ci sono talmente fonti che è difficile persino per Pechino bloccare i canali. Figuriamoci in Italia, ma non è questo il punto, piuttosto quello che devi attivare è un senso di responsabilità diffusa. Penso a iniziative inedite, come a un riunione dei direttori dei grandi gruppi editoriali che garantiscano autorevolezza, linee guida, senza però impedire al giornalista di fare il proprio mestiere.
Una pandemia, e una comunicazione sbagliata dei rischi e degli eventi, può mettere in ginocchio intere economie.
Il rischio maggiore è che il panico provochi la chiusura delle frontiere e delle merci, c’è il caso del Salone del lusso di Milano, a cui si sta provando a rispondere organizzando collegamenti online. Come stiamo vedendo, un’epidemia di tali dimensioni crea danni ai movimenti delle persone, all’economia legata ai viaggi, alla ristorazione. La buona notizia è che non dura a lungo. Da questo punto di vista anche le imprese possono fare molto, affiancandosi alle istituzioni, possono aiutare a distinguere i rischi reali da quelli emotivi.
Non sono mancati i casi di speculazione politica.
Sì, ma la speculazione politica di fatti come questi ha le gambe corte. Creare storytelling negativi lo posso capire per fattori come immigrazione e terrorismo, ma speculare su salute e paure può ritorcersi contro, ecco, a un politico non consiglierei di cavalcare un’emergenza pandemia in maniera aggressiva.
Aspettando la reale portata della pandemia, un effetto immediato il coronavirus l’ha provocato. A fronte delle eccessive fughe di notizie – vere o false – l’Organizzazione mondiale della sanità ha coniato una parola nuova: infodemia.
Sì, effettivamente è la prima volta che la sento. Trovo interessante questa crasi tra epidemia e informazione, che evoca un’epidemia di informazioni, o un’epidemia di fake news. E ho scoperto sul web che la Treccani online l’ha appena inserita tra le nuovi voci. C’è da dire che l’Oms ha risposto con grande prontezza a questo problema, per la prima volta il settore dell’informazione e la comunicazione si chiama in causa direttamente.
Infodemia come nuovo paradigma?
Di certo stabilisce un nuovo ambito con cui confrontarci, una nuova strada che può essere applicata ad altre cose, pensiamo all’infodemia politica, a certi prodotti commerciali, le applicazioni sono molteplici. Questo salto di qualità nella coscienza collettiva dell’informazione pone una grande sfida ai comunicatori, spinge a mettere in atto competenze, all’utilizzo di strumenti sofisticati e di linguaggi nuovi e interessanti.