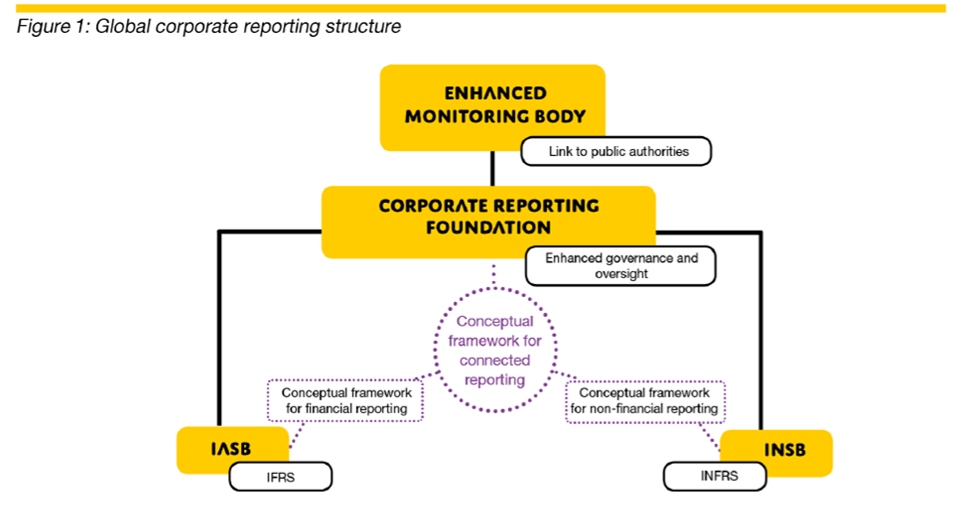Plastica addio: il 2020 sarà l’anno del packaging commestibile? Dalle capsule monodose ai pasti in aereo, tutte le novità

Se ne parla da molto tempo, ma forse sarà il 2020 l’anno della svolta per il packaging commestibile, o comunque del tutto biodegradabile: alcuni prodotti stanno infatti conquistando piccole fasce di mercato e cominciano a collaborare con i grandi marchi globali, ma le previsioni sono tutte di crescita esponenziale.
A fare il punto è la rivista Chemical & Engineering News, settimanale dell’American chemical society, che parte con un esempio: le bevande monodose in capsule (o pod, analoghe a quelle per detersivo) distribuite alla maratona di Londra del 2019, tutte confezionate con la pellicola Ooho a base di alghe dell’azienda londinese Notpla. Queste capsule hanno rimpiazzato le migliaia di bicchieri e bottiglie in plastica che costellavano il percorso della gara per giorni. I corridori potevano mangiare anche la pellicola, oppure scartarla (in questo caso si dissone in 4-6 settimane).
Le capsule sono solo uno dei tanti prodotti – cannucce, involucri, bicchieri, coperchi e molto altro – realizzati, con alghe, zuccheri, amidi di patate, scarti alimentari, proteine del latte e altro ancora. Tutti materiali a elevate prestazioni e migliori rispetto alle bioplastiche, che non sono commestibili e che, in molti casi, secondo gli autori, hanno un’impronta ambientale complessiva non molto distante da altri involucri.
Competere con un materiale come la plastica – molto difficile da eguagliare quanto a prestazioni – è complicato, e oltre a questo bisogna fare i conti con i dubbi sull’igiene, perché qualcuno potrebbe non gradire il fatto di mangiare alimenti o bere bevande toccate da mani non pulite (non a caso si consiglia di maneggiarli con guanti monouso). Come ha spiegato Stefano Farris, dell’Università di Milano, ci sono poi questioni non trascurabili, come il fatto di abituarsi a mangiare cose che si sono sempre scartate e buttate.

Ma il futuro del biopackaging sembra comunque roseo. Secondo la società internazionale di analisi economiche Transparency Market Research, la domanda è destinata a salire del 6,9% all’anno fino al 2024, per un giro d’affari annuale di 2 miliardi di dollari. La crescita è trainata da accordi come quelli che hanno fatto 65 ristoranti della capitale britannica con Just Eat, che prevede la distribuzione di condimenti in capsule Ooho. Anche il marchio di alcolici Glenlivet in una recente manifestazione, la London cocktail week, ha distribuito solo bevande confezionate con lo stesso materiale.
Mentre la Notpla sta sperimentando packaging per cibi pronti quali pasta o patatine, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico la newyorkese Loliware propone cannucce aromatizzate realizzate con derivati da alghe marine e microalghe rosse. Una volta bagnate, queste cannucce sono indistinguibili dalla plastica per 24 ore, possono essere mangiate o, se scartate, si degradano in due mesi. La catena dei Marriott Hotel e l’azienda di alcolici Pernod Ricard hanno iniziato a sostituire le loro cannucce in plastica con quelle della Loliware, e si prevede di venderne 30 miliardi entro la fine dell’anno.
L’indonesiana Evoware si è invece lanciata sugli involucri per hamburger, le bustine di condimento dei noodles istantanei e i sacchetti di caffè. Il fatto che si tratti di un’azienda del secondo paese al mondo per produzione di rifiuti plastici è particolarmente significativo, così come lo è il sostegno che lo sviluppo dei suoi prodotti – a base di alghe – potrebbe dare all’economia locale.

Un altro approccio punta sulle proteine del latte che, se opportunamente lavorate, offrono prestazioni molto elevate e, in più, possono essere recuperate dagli scarti dell’industria casearia. Nel caso delle pellicole create da ricercatori dello US Department of Agricolture, gli ingredienti di base sono la caseina con aggiunta di proteine della frutta come la pectina. Le miscele ottenute riescono a offrire una resistenza all’ossigeno 500 volte superiore a quelle dei plastificanti tradizionali. In questo caso si stanno ultimando partnership con aziende che possano produrre le pellicole di proteine del latte su grande scala, ma già si pensa di usarle per i formaggi e altri alimenti altamente deperibili.
Materiali completamente biodegradabili sono in studio anche per altre funzioni nell’ambito alimentare. La messicana E6PR, che propone una bioplastica degradabile per tenere insieme le lattine di birra (in unità di sei), già adottata dalla Corona e da decine di altri marchi nazionali e internazionali.

Restano difficoltà tecniche da superare come la suscettibilità all’umidità, che complica il trasporto e l’immagazzinamento di alcuni di questi materiali, nonché il contatto con certi alimenti (si pensi, per esempio, al gelato o alle bevande calde). Inoltre è necessario che le fonti primarie non siano inquinanti, e che i costi non siano troppo alti, ma la ricerca va avanti. Questo tipo di packaging potrebbero avere applicazioni in settori cruciali, come quello degli involucri per i fast food, degli snack e degli alimenti deperibili.
Inoltre ci sono applicazioni con grandi potenziali come, per esempio, quello dei pasti sugli aerei o sulle navi, che potrebbero diventare come quelli immaginato dallo studio di design PriestmanGoode. Un pranzo su un vassoio fatto con fondi di caffè, contenuto in piatti di crusca di grano e noce di cocco, protetto da coperchi commestibili (per esempio di wafer) e accompagnati da capsule a base di alghe e latte per salse e condimenti. Anche in Italia sono già in vendita stoviglie di questo genere: la tavola è insomma destinata a cambiare, e non solo per le pietanze presenti.