Benetton: l’incompetenza che distrugge valore (e crea dolore)

Non serve spendere molte parole, per richiamare alla memoria la tragedia di Genova: basta dire “Ponte Morandi”,e il dolore e lo sgomento – a poco più di un anno dal disastro – si riacutizzano immediatamente. Per chi volesse comunque rinfrescarsi la memoria sulle varie fasi della pessima gestione di quella crisi da parte dei Benetton e di Autostrade Per l’Italia, ne ho scritto in questo articolo.
Le reazioni dei manager di Autostrade e della famiglia Benetton
Il silenzio della famiglia Benetton in occasione del disastro – peraltro contrario a qualunque buona prassi di crisis management – non è stato d’aiuto, né ha generato empatia nei confronti della ricca famiglia di imprenditori Veneti: il confine tra (presunta) riservatezza e disinteresse è infatti assai labile. “Il silenzio delle prime ore? Un segno di rispetto”, secondo l’intervista rilasciata a tutta pagina al Corriere della Sera, quando probabilmente più del rispetto poterono gli interessi degli azionisti, e la famiglia decise di rompere, appunto, il silenzio.
A peggiorare lo scenario, la festa tenuta dai Benetton a Cortina il 14 e 15 agosto, a poche ore dalla tragedia, e giustificata maldestramente da un’amica di famiglia invitata quella sera: “Mettetevi nei loro panni, c’erano ospiti che arrivavano dall’estero, come potevano annullare tutto?”
Poi, agli inizi del mese di ottobre 2018, un ulteriore incredibile aggiornamento, che riportavo così sul mio Blog “C’è un limite alla mediocrità del management dei grandi gruppi italiani? L’indagine della Guardia di Finanza successiva al disastro di Genova sta dipingendo uno scenario a tinte più fosche del previsto: passando al setaccio una trentina di cellulari di utenze intestate sia ad Autostrade per l’Italia che al Ministero delle Infrastrutture, è risultato evidente come vari scambi di comunicazioni – sia email che WhatsApp – fossero presenti solo da una parte, laddove avrebbero dovuto essere esattamente speculari tra mittente e ricevente. Uno speciale software ha confermato sia la cancellazione dei messaggi, che la data di originale invio (mesi e mesi fa), che il fatto che l’intervento doloso di “auto-censura” risale a dopo il disastro. Cosa si è voluto nascondere? E cosa è andato perduto, oltre alla dignità di questi manager?”
Successivamente, i giornali hanno portato l’attenzione su come nessuna delle figure maggiormente coinvolte nell’inchiesta abbia risposto alle domande dei Magistrati: tutti i principali indagati si sono infatti avvalsi della facoltà di non rispondere, inclusi i dirigenti tecnici di Autostrade responsabili del tronco oggetto del disastro. Certamente, una facoltà garantita dal nostro Codice Penale, ma nel contempo un intralcio deliberato sulla strada della definizione di un quadro di verità, intralcio che suona ingiurioso verso le 43 vittime della tragedia e le loro famiglie.
Non basta: un nuovo scandalo per Autostrade per l’Italia, e una tragedia sfiorata
Ora, incredibile a dirsi, nuovi sconcertanti sviluppi: in un anno, nulla pare essere cambiato nelle male pratiche di questo importante gruppo imprenditoriale italiano, nonostante la tragedia, nonostante i morti. Come riportato dai mass-media, infatti, la Procura di Genova ha disposto 9 misure cautelari in relazione a presunti report di sicurezza falsificati dai funzionari della concessionaria SPEA (gruppo Atlantia), su due distinti viadotti. “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto” (data della tragedia del ponte Morandi, ndr). A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, controllata dai Benetton. Indovino ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla autostrada A26 (Genova – Gravellona Toce), in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale previsto per il 21-22 ottobre 2018, e quando si trova a redigere la relazione esprime tutte le sue perplessità alla responsabile della sorveglianza dell’Ufficio Tecnico Sorveglianza Autostradale di Genova. “Vuol dire che la gente coinvolta non ha capito veramente un cazzo”. Il falso report – da quanto riportano le cronache – doveva servire a garantire il passaggio di un trasporto eccezionale da 141 tonnellate su un viadotto potenzialmente a rischio. “Più andiamo oltre, più rosicchiamo margini di sicurezza – aggiunge Indovino – e quello è un viadotto che ha delle problematiche”. Ma “il mittente che c’è dietro è pesante” (Autostrade per l’Italia, ndr) e quindi si decide di procedere. A quel punto, secondo l’indagine, Maurizio Ceneri, responsabile dei controlli di Spea Engineering, ha compilato un documento che attestava falsamente la perdita di sicurezza del viadotto al 18%, a fronte di quella reale del 33%, permettendo così il passaggio del trasporto eccezionale. Passaggio che molto probabilmente ha fatto vivere una notte assai agitata alle persone coinvolte, ma che poi è andato a buon fine, evitando così un nuovo disastro, a pochi mesi da quello, tragico, di Genova.
A seguito di questi fatti, Atlantia, la holding dei Benetton, ha sospeso i dipendenti coinvolti nel nuovo scandalo, e ha diramato uno scarno comunicato nel quale annuncia che “Prenderà senza esitazione e nell’immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate”. Che è – evidentemente – la cosa che più interessa al top management del gruppo.
Cambio al vertice in API: ma tardi, e con paracadute d’oro
Inoltre, nel Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2019, gli azionisti e l’Amministratore Delegato Giovanni Castellucci hanno raggiunto un accordo per le dimissioni di quest’ultimo, liquidato con oltre 13 milioni di euro. Inoltre, confermano le cronache “…per qualsiasi giudizio civile, penale o amministrativo che dovesse coinvolgere Castellucci, anche dopo la cessazione dei rapporti, in relazione all’attività resa in esecuzione dei medesimi, ogni onere relativo, anche per indennizzi e risarcimenti e per spese legali e peritali, sarà a carico della Società”. In considerazione del valore distrutto dall’inettitudine del management del gruppo, incapace di vincere la sfida costituita dalla gestione di queste tragiche e delicate vicende, avrei francamente – più appropriatamente – proposto un’azione di responsabilità: ma si sa, come per i nostri amici a 4 zampe, vale il detto “tale manager, tale padrone”; tutti d’amore e d’accordo nel creare pregiudizio all’azienda a causa della loro imperizia.
Da ricordare che per le famiglie rimaste senza casa per il crollo del Ponte Morandi Atlantia stanziò inizialmente una media di 10.000 Euro a testa, cifra risibile se paragonata all’oltre 1 miliardo di utile annuale della società. Franco Ravera, presidente dell’associazione ‘Quelli del ponte Morandi’, ha commentato: “Potevano agire diversamente, leggere quelle cifre fa tanta rabbia. Andava fatta una valutazione morale, non si può fare finta che il 14 agosto 2018 non sia successo nulla. La cosa che fa più male è ripensare agli incontri con Autostrade avvenuti subito dopo il 14 agosto, alle scuse mancate, e all’indisponibilità a dialogare con noi”, ha concluso Ravera.
Una storia peraltro già vista in occasione dei Dieselgate Volkswagen, dove l’AD – che secondo molti qualificati osservatori non poteva non sapere delle truffe legate alla manomissione dei report sulle emissioni nocive in atmosfera – venne dimissionato con una liquidazione monstre da quasi 60 milioni di Euro: il top management delle grandi corporation non paga quasi mai, quale sia il disastro, e a prescindere dal numero di morti.
Gestione della comunicazione… o etica?
Un collega che stimo, riflettendo sulla gestione di Autostrade, ha scritto: “A ben guardare le decisioni prese da Edizione ed Atlantia nel corso delle ultime 72 ore giungono 400 giorni in ritardo. La discontinuità auspicata oggi dalla famiglia Benetton e l’audit interno affidato a consulenti esterni da parte di Atlantia avrebbero dovuto essere la naturale conseguenza del drammatico crollo del Ponte, e una delle prime azioni di crisis management adottate da Atlantia. La riorganizzazione delle società operative con la nomina di nuovi dirigenti e l’avvio di una fase rigorosa di audit interno di tutte le società controllate avrebbero probabilmente evitato che le società del Gruppo finissero nuovamente nell’occhio del ciclone. Difficile infatti difendersi dall’accusa mossa dalla Procura di Genova che ‘dopo la tragedia di Genova i tecnici di Autostrade e Spea hanno continuato a ammorbidire i risultati delle misurazioni sullo stato di salute dei tratti in questione’, senza poter dimostrare di aver intrapreso azioni di governance che lo potessero evitare”.
Tutto corretto. Ma alla luce di questa carrellata di atteggiamenti e comportamenti irresponsabili, irriguardosi verso la sicurezza dei cittadini, e soprattutto pervicacemente reiterati, occorre interrogarsi nel profondo, a mio avviso, non solo sotto il profilo tecnico, ovvero circa il mancato rispetto delle più elementari norme di crisis management, quanto piuttosto sulle cause remote alla base del problema: a mio avviso, la cultura aziendale propria di questo colosso delle concessioni pubbliche.
Benetton e Autostrade: persistere nel distruggere valore
L’Università di Harvard ha – già da anni, inascoltata – messo la pietra tombale sulla presunta alternativa “etica versus profitto”, spiegando e documentando scientificamente che l’introduzione di preoccupazioni etiche nel business a livello strategico incrementa il valore medio della capitalizzazione di borsa delle aziende del 25 per cento. É sconcertante come una famiglia d’imprenditori dallo straordinario pedigree come i Benetton non abbia ancora fatto propri questi concetti, e soprattutto non si sia posta concretamente – negli ultimi lunghi 12 mesi, con tutto ciò che è successo – il problema di indagare nel profondo e con urgenza il tema della cultura d’impresa all’interno della propria azienda. Perché la mancanza di etica ha un prezzo, per le aziende, eccome: ne scrivevo proprio di recente.
A conferma di ciò, è bene ricordare che già la vicenda del crollo del viadotto Polcevera fu un bagno di sangue per gli azionisti dell’azienda, e ora la nuova inchiesta giudiziaria ha causato altre perdite per quasi il 20% della capitalizzazione di borsa della società. Buonuscita dell’AD Castellucci a parte, i numeri ufficiali sulle spese sostenute finora dalla concessionaria autostradale sono scritte nero su bianco nella relazione annuale 2018 della “casa madre” Atlantia, e poi nella semestrale del 30 giugno 2019: “Nel corso del primo semestre 2019 sono stati effettuati ulteriori accantonamenti pari a 6 milioni di euro correlati essenzialmente ai risarcimenti agli eredi delle vittime e ai feriti, portando l’onere complessivo a 513 milioni di euro”. Soldi persi dai Benetton, certo, ma anche da tutti gli investitori, istituzionali, privati e piccoli azionisti, che nella loro gestione avevano riposto fiducia.
Ora, novelli Luigi XVI, apparentemente incuranti di tutto ciò che è accaduto e di quanto di vergognoso sta ulteriormente emergendo in queste settimane, la dinastia di imprenditori trevigiani continua a fare affari e contratta per preparare l’ingresso in Alitalia, così da soddisfare i politici che hanno volto lo sguardo a Treviso per pietire interesse (e soldi). Ma attenzione, perché la Torre del Tempio e Place de la Concorde potrebbero essere dietro l’angolo.
Post scriptum
Al ridicolo non c’è mai fine: grazie alla magia degli algoritmi che posizionano automaticamente le ADV online, in calce a vari articoli sul nuovo scandalo che ha colpito Autostrade per l’Italia, trovate la pubblicità che vedete nello screenshot qui sotto. “Colorata e divertente”, dice Benetton: si riferisce forse alla propria gestione delle concessioni autostradali? Possibile che l’azienda sia incapace di “modulare” il proprio marketing sulla base della situazione ambientale? È il senso della prima lezione del corso universitario in Reputation management, lo capiscono anche i discenti, e hanno 18 anni…
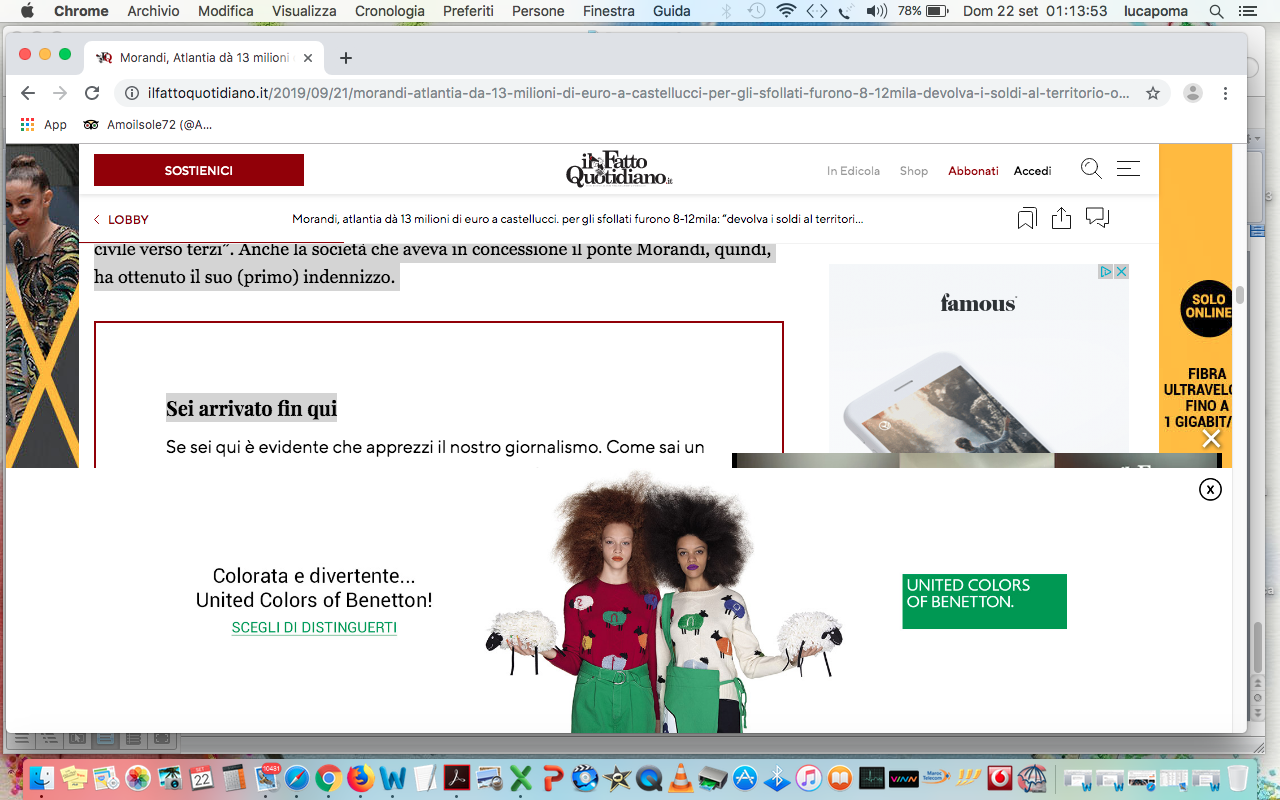
Aggiornamento (ottobre 2019)
I mass-media denunciano cosa sarebbe accaduto in Atlantia prima del crollo del Ponte Morandi: “Risparmiamo, ora arrivano i Cinesi”, ovvero manutenzioni al ribasso sulla rete autostradale per compiacere i nuovi soci in ingresso nel gruppo. Più della metà del pacchetto azionario del Benetton (6,97%) è acquistato da un consorzio guidato dai tedeschi di Allianz Group, l’altra metà è ceduto a Silk Road Fund, fondo sovrano cinese. L’iniezione di liquidità – che porta nelle casse del colosso controllato dai Benetton 1,48 miliardi – apre a un’altra mega-fusione, con l’avvio delle grandi manovre per l’acquisizione della società spagnola Abertis. “Devo spendere il meno possibile… sono entrati i tedeschi, a te non te ne frega un cazzo ma sono entrati anche i cinesi… devo ridurre al massimo i costi… e devo essere intelligente de portà alla fine della concessione… lo capisci o non lo capisci?”, dice un dirigente le cui esternazioni venivano registrate da un collega. Per i Giudici che nelle scorse settimane hanno firmato gli ordini di arresto per altri tecnici accusati di aver falsificato l’esito di varie ispezioni, “emergono con prepotenza le logiche commerciali sottese agli interventi manutentivi”. I dirigenti del gruppo Atlantia intervengono in modo esplicito sulla sicurezza delle infrastrutture pubbliche, chiedendo ai tecnici di rivedere al ribasso le valutazioni di rischio su alcuni viadotti: “Che sono tutti ’sti 50 (il numero indica un coefficiente di rischio, più alto è, e più urgenti sono le manutenzioni da eseguire, ndr)? Me li dovete toglie… Adesso riscrivete”. Atlantia – in risposta a questo nuovo vergognoso scandalo – dichiara “di aver avviato un audit interno”. Con calma: tanto le persone sono già morte, non c’è fretta. Armatevi di altrettanta calma e pazienza, Voi lettori, e scaricatevi il Codice etico di Atlantia (Gruppo Benetton): leggerete parole chiave importanti come “legalità, onestà e correttezza”, “integrità”, “lealtà e buona fede”, “trasparenza”, “rispetto delle persone”, “sicurezza, salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro”, “benessere economico e crescita della comunità”. Nel Codice etico si legge anche che esso “responsabilizza coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con il Gruppo Benetton in ordine all’osservanza di detti principi, e che il gruppo nella gestione degli affari si impegna ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, qualità e liceità ed operare con la diligenza professionale o del buon padre di famiglia”. Se non parlassimo, purtroppo, di un’incredibile tragedia, ci sarebbe da ridere…
Aggiornamento (dicembre 2019)
Sorprendentemente, alcuni giorni fa Luciano Benetton (84 anni, patron del gruppo) è intervenuto con una lettera a pagina intera sul Corriere della Sera, nella quale si è lamentato per quella che ha definito “una campagna d’odio” ai danni della famiglia e delle società del gruppo, che a suo dire avrebbero “commesso degli errori”: “è inaccettabile la veemenza con la quale veniamo accusati”, lamenta l’imprenditore trevigiano, che dice di essere “colpito e sorpreso” dal comportamento del manager del gruppo. Ammette tuttavia – a margine, lei che del gruppo Atlantia è azionista di maggioranza – di aver “avvallato un management che si è rivelato non idoneo”. Ma non perde l’occasione per “sgridare” i mass-media, che dovrebbero, a suo dire, trovare un linguaggio “più adatto per trattare questo argomento”, e le istituzioni, che dovrebbero essere “più serie”.
E’ anche un po’ piccato, il Signor Benetton, capite? Al punto da tenere lezioni. Se non fosse vero, parrebbe una barzelletta.
Aggiornamento (dicembre 2019)
I sostegni degli stralli a sud che sembrano aver ceduto per primi sono gli stessi su cui un professore di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, Carmelo Gentile, aveva notato preoccupanti segni di corrosione o altri possibili danni durante dei test effettuati lo scorso ottobre.
Il professor Gentile avvisò il gestore del ponte, Autostrade per l’Italia, che secondo il professore non fece mai seguito alla sua raccomandazione di eseguire un accurato modello matematico e attrezzare il ponte con sensori permanenti.
“Probabilmente hanno sottovalutato l’importanza dell’informazione”, ha detto il professor Gentile in un’intervista.
Autostrade non ha mai negato le conclusioni del professor Gentile, ma ha ribadito che nessuno aveva ravvisato elementi di urgenza. In un comunicato, la società ha precisato che i suggerimenti del professor Gentile erano stati inclusi nel progetto di retrofitting del viadotto approvato a giugno, e ha accusato il Ministero delle Infrastrutture di mesi di ritardo nell’autorizzazione dei lavori.
Aggiornamento (novembre 2020)
Giovedì 12 novembre 2020 – finalmente – la giustizia ha fatto ben parlare di se con l’arresto dell’ex Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, Giovanni Castellucci, ed altri manager di vertice del gruppo italiano. Paola Faggioni, il giudice che si sta occupando del dossier, ha a tal proposito dichiarato in modo inequivoco: “Sono state accertate gravi condotte criminose legate a una politica imprenditoriale volta alla massimizzazione dei profitti derivanti dalla concessione dello Stato, mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie per la manutenzione della rete autostradale, a discapito della sicurezza pubblica”. Prima del disastro del ponte Morandi, evento per certi versi tristemente annunciato, i manager si scambiavano messaggi su Whatsapp sull’evidente stato di irrimediabile corrosione dei cavi, messaggi poi infantilmente e criminalmente cancellati dalle chat. Ora all’AD Castellucci (del quale trovate un intrigante ritratto qui) si vede revocare la sontuosa liquidazione milionaria che senza esitazione l’azienda controllata dalla famiglia Benetton – che porta sulle spalle la responsabilità se non altro morale per quanto accaduto – gli aveva riconosciuto in occasione delle Sue dimissioni, dopo il disastro di Genova: se non ci fossero 43 morti, e non fosse una vicenda quantomeno tragica, parrebbe un romanzo di quart’ordine.. (to be continued)
Edit il 29/12/2019 h 17:38
Edit il 13/12/2019 h 16:38
Edit il 13/12/2019 h. 12.29
Edit il 08/12/2019 h 15:40
Edit il 13/10/2019 h 01:15
Edit il 06/10/2019 h 18:35
Edit il 22/09/2019 h 16:55
Edit il 22/09/2019 h. 11.49
Edit il 22/08/2019 h. 15.15
Edit il 19/11/2020 h. 11:57


