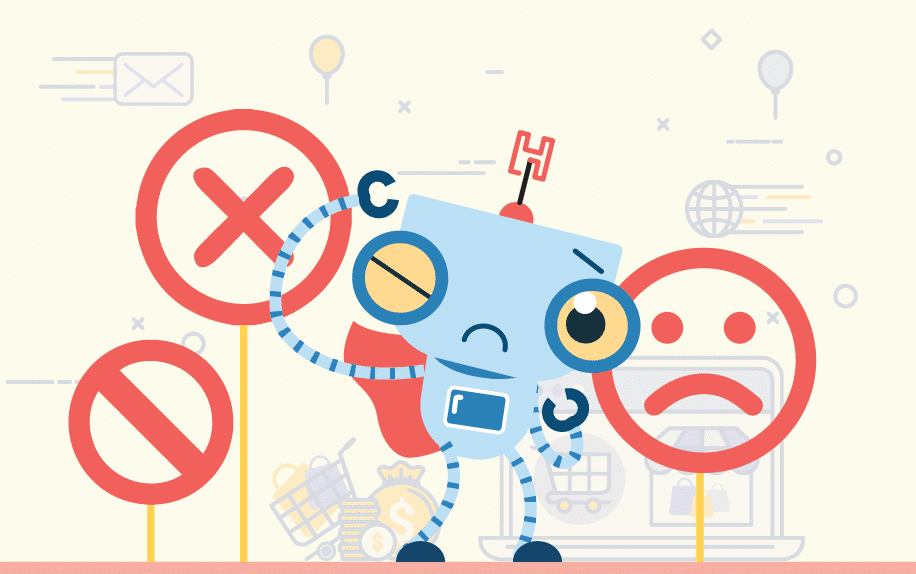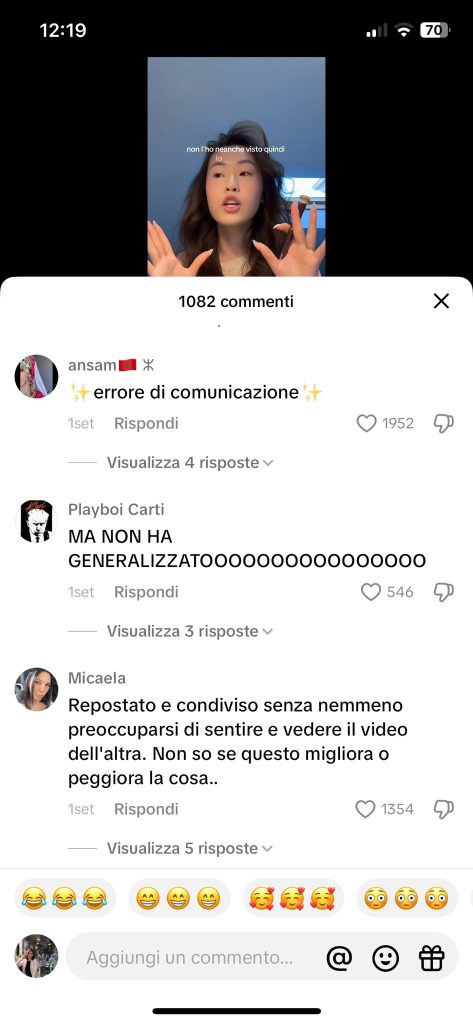Andare oltre l’ESG

SONO STATI ANNI DIFFICILI per l’ESG, l’acronimo con cui si indicano la misurazione e la gestione della performance ambientale, sociale e di governance di un’azienda. Negli Stati Uniti, il termine è diventato un bersaglio per entrambe le parti della scena politica. Per chi si posiziona a sinistra, l’ESG non obbliga a sufficienza le aziende ad affrontare le grandi sfide della società, in particolare quelle relative al cambiamento climatico. Per chi sta dall’altra parte, rappresenta un tentativo insidioso di far adottare alle aziende un’agenda liberal, alterando così i mercati e la libera concorrenza. Da tutte le parti arriva poi la critica al greenwashing, ovvero la pratica, da parte di aziende e investitori, di enfatizzare in modo eccessivo gli sforzi ESG. Questa raffica di critiche ha fatto perdere lustro all’ESG agli occhi di molti dirigenti. Alcuni addirittura praticano il greenhushing, evitano cioè di parlare pubblicamente delle loro iniziative ESG.
Tuttavia, il bisogno di collegare in modo trasparente la performance finanziaria di un’azienda con la sua performance ambientale, sociale e di governance rimane, e anche le sfide sociali che le imprese devono contribuire ad affrontare non sono scomparse, a partire dal cambiamento climatico. È, dunque, il momento di fare il punto sull’ESG e tracciare un percorso per un movimento sulla sostenibilità aziendale. A tal fine, negli ultimi due anni ho fatto la spola tra le fazioni in conflitto impegnate nel dibattito, incontrando liberal e conservatori, critici e sostenitori, a New York, Washington e in Europa, cercando di trovare un terreno comune.
Ci vorranno anni perché il dibattito sull’ESG trovi una soluzione. Alcune sfide, del tutto legittime e complesse (sia da un punto di vista politico che tecnico) non sono nemmeno lontanamente vicine a trovare una soluzione. Ne è un tipico esempio la questione se utilizzare la materialità singola o quella doppia per valutare le performance ESG. La materialità singola (chiamata anche materialità finanziaria) tenta di quantificare le questioni ESG importanti per la creazione di valore per gli azionisti, cioè quelle questioni che rappresentano dei rischi per un’azienda. Questa è la visione dominante dell’ESG oggi in uso. La materialità doppia tenta di misurare anche l’impatto di un’azienda, in altre parole le esternalità positive e negative che crea e che rendono il mondo un posto migliore o peggiore, ma che non influenzano direttamente la performance finanziaria aziendale. L’impatto, però, è estremamente difficile da quantificare e non esiste un accordo, in sede politica, sul fatto se sia più o meno appropriato pretendere che i manager forniscano tali informazioni a investitori e altri stakeholder chiave. In generale, i Paesi europei e i liberal statunitensi spingono per regole che impongano la materialità doppia, convinti che le sfide di misurazione siano un ostacolo superabile. I conservatori statunitensi e molti dirigenti aziendali preferiscono la materialità singola, sostenendo che la materialità doppia non sarebbe né fattibile né giustificata. Insomma, è un bel pasticcio.
Al centro del dibattito ESG c’è la questione fondamentale del ruolo dell’impresa nella società: cosa significa essere un’azienda responsabile? Mettendo da parte tutta la retorica fiorente sul tema, è questa la sfida che si trovano oggi ad affrontare i leader aziendali. Devono essere chiari su come le loro aziende creano valore per gli azionisti e su come le loro iniziative ESG contribuiscono a farlo. Devono essere altrettanto chiari su cosa le loro aziende, anche volendo, non possono fare con l’ESG per rendere il mondo un posto migliore e cosa appartiene alla sfera delle politiche pubbliche. Troppe aziende, investitori e politici confondono i due ambiti.
Le aziende possono e devono fare pressione affinché i Governi introducano regole efficaci in tema di ESG, ma non è su questo che si concentra l’articolo. Quello che invece farò è offrire tre strategie che i leader aziendali possono utilizzare per gestire le pressioni contrastanti che animano il dibattito ESG. La base per tutte e tre le strategie è il riconoscimento della differenza tra ESG tradizionale e impatto (in altre parole, la differenza tra materialità singola e doppia). Queste strategie consentiranno ai leader di passare da posizioni reattive alla capacità di orientare attivamente le discussioni che si sviluppano all’interno della scena politica.
SIATE CHIARI SUL VOSTRO SCOPO
Ogni azienda deve definire il proprio scopo con precisione. Troppe mission, vision e valori sono enunciati in modo talmente ampio che potrebbero valere per qualsiasi organizzazione. Chiarezza dello scopo significa anche che sono chiare le questioni ESG essenziali che influenzano direttamente la creazione di valore, senza che ciò includa gli impatti positivi e negativi più ampi che un’azienda ha sul mondo esterno. I sostenitori del capitalismo degli stakeholder e della materialità doppia non amano questo approccio, perché sostengono che, col tempo, gli interessi degli stakeholder e quelli degli azionisti convergono. Questo, semplicemente, non è vero. Non tutto ciò che conta per gli stakeholder riguarda il valore per gli azionisti. I compromessi sono inevitabili.
Colin Mayer, mio collega all’Università di Oxford, sostiene che lo scopo di un’azienda è quello di produrre soluzioni redditizie ai problemi delle persone e del pianeta e di ridurre al minimo il profitto che crea problemi. Lo scopo di Exxon Mobil è soddisfare le esigenze energetiche del mondo in modo redditizio. Questo oggi comporta la fornitura di energia sia inquinante sia rinnovabile. Il CEO dell’azienda, Darren Woods, ritiene che, nell’arco di una decina d’anni, il suo business a basse emissioni di carbonio (come la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l’idrogeno) potrebbe essere più grande del suo storico business di petrolio e gas, ma non gli dispiace affatto soddisfare le esigenze energetiche di oggi con il business tradizionale dei combustibili fossili.
Alcune aziende utilizzano i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per definire il proprio scopo, collegando esplicitamente il proprio lavoro alla lista dei bisogni insoddisfatti dell’umanità steso dall’ONU. Ad esempio, Nike sottolinea i suoi contributi agli obiettivi 3 (buona salute), 5 (parità di genere), 8 (buona occupazione e crescita economica), 12 (utilizzo responsabile delle risorse) e 13 (lotta contro il cambiamento climatico). Anche Schneider Electric collega il proprio lavoro agli OSS e produce rapporti trimestrali sui progressi compiuti.
Oltre a identificare i bisogni insoddisfatti dei clienti, le aziende devono articolare i fattori ESG che rappresentano rischi materiali per la creazione di valore per gli azionisti. Gestire i fattori di rischio specifici per settore può impedire al mondo di diventare un posto peggiore di quello che è, ma non lo rende necessariamente un posto migliore. Un’azienda può realizzare performance insoddisfacenti sul piano ESG pur avendo un impatto positivo. La bassa valutazione ESG di Tesla è un caso emblematico. Secondo l’agenzia di rating S&P Global, Tesla ha un punteggio ESG totale di 40 (su un massimo possibile di 100). Ottiene 53 sull’ambiente (laddove il massimo del settore è 81), 29 sull’impatto sociale (il massimo del settore è 84) e 40 sulla governance (il massimo del settore è 69). Sebbene i suoi veicoli elettrici abbiano un impatto ambientale positivo, Tesla ha avuto con la sua forza lavoro continui problemi che ne hanno influenzato il valore azionario. L’idea di fondo (sbagliata) di chi critica l’ESG da destra è che la materialità singola sia il riflesso di un’agenda politica liberal. Non c’è niente di così ambizioso, si tratta semplicemente di occuparsi dei temi legati alla sostenibilità che hanno un impatto sulla creazione di valore.
Quasi tutte le aziende producono esternalità negative, anche quelle ben posizionate sui temi ESG e con un impatto positivo sul mondo. È importante essere sinceri a tale proposito. Queste esternalità negative sono ciò su cui si concentra chi critica l’ESG da sinistra, secondo cui le aziende non farebbero abbastanza per affrontarle. Le esternalità negative, però, sono inevitabili e non influenzano necessariamente le valutazioni ESG. Owens Corning ha un punteggio ESG assegnatogli da S&P Global di 85 e ottiene il punteggio più alto su ogni elemento ESG consentito dal suo settore. È impegnata a creare un’economia circolare e allinea le proprie attività agli OSS. Allo stesso tempo, le fonti d’energia non rinnovabili (carbone incluso) rappresentano poco più della metà del suo consumo energetico, i suoi prodotti dipendono fortemente dall’acqua e generano un alto grado di stress idrico per le comunità locali, senza contare che smaltisce considerevoli quantità di rifiuti pericolosi nelle discariche. L’azienda ha l’obiettivo di migliorare tutti questi problemi fino ad arrivare a zero rifiuti in discarica entro il 2030. Nel futuro immediato, tuttavia, queste attività non rappresentano rischi reali per le sue performance finanziarie, quindi non hanno una grande influenza sul suo rating ESG.
Per essere un’azienda responsabile, una società deve avere dei piani per ridurre le proprie esternalità negative: ogni azienda sa quali sono. Le ONG, i giornalisti e altri gruppi di controllo sono diventati molto abili nell’interpellare le aziende su un’ampia gamma di questioni ambientali e sociali. La sfida, per le aziende, è come gestire gli impatti negativi che genera, anche quelli che non sono rilevanti dal punto di vista ESG, senza danneggiare la creazione di valore per gli azionisti. In molti casi, le aziende possono fissare degli obiettivi. Un esempio classico è quello di ridurre le emissioni di carbonio in accordo con il consiglio di amministrazione. Fissare obiettivi può stimolare l’innovazione e rappresentare una fonte di vantaggio competitivo.
Uno degli esempi più significativi di esternalità negativa è quello delle sigarette. Philip Morris International o PMI (di cui sono consulente retribuito) si è posta l’obiettivo di ottenere, entro il 2030, due terzi dei ricavi netti da prodotti “senza fumo”. A tal fine, ha sviluppato un prodotto a base di tabacco riscaldato che è meno dannoso del fumo di sigaretta (anche se non del tutto innocuo) e più redditizio del tradizionale business delle sigarette. L’azienda sta vivendo un’incredibile trasformazione aziendale, proprio sulla scia di questo suo ambizioso obiettivo.
Alla fine, però, è la regolamentazione il modo principale con cui le esternalità negative vengono mitigate. Nuove leggi possono di punto in bianco renderle rilevanti da un punto di vista finanziario. È attraverso la regolamentazione che i Governi stabiliscono le condizioni per la creazione di valore per gli azionisti, rendendo le aziende responsabili degli impatti negativi che producono. Una tassa sul carbonio, che sostengo, ne è un buon esempio. Le aziende, specialmente negli Stati Uniti, sono generalmente considerate contrarie a qualsiasi nuova legge e regolamentazione, ma opporsi a tutte le regolamentazioni per partito preso è un errore. È giusto che le aziende si lamentino perché la società civile chiede loro troppo, ma la conseguenza è che devono essere chiare su ciò che il Governo dovrebbe fare per affrontare le esternalità negative. Sarebbero le prime a trarne beneficio se dessero degli input sulle normative piuttosto che semplicemente opporvisi.
Incoraggiare questo tipo di regolamentazione è in gran parte l’approccio che Owens Corning ha adottato per affrontare le proprie esternalità negative. Nel suo rapporto di sostenibilità del 2023, l’azienda scrive: «Con i sistemi e le politiche che abbiamo in atto, siamo nella condizione di soddisfare i vari requisiti […] in tutto il mondo. Questi sistemi e politiche ci preparano anche per il futuro, dal momento che gli organi di governo di tutto il mondo stabiliscono regolamentazioni sempre più stringenti per far fronte agli impatti negativi del cambiamento climatico». Allo stesso modo, in una dichiarazione d’intenti firmata da ogni membro del board, PMI osserva che «con il giusto incoraggiamento normativo e il supporto della società civile, le vendite di sigarette potranno terminare nel giro di 10-15 anni in molti Paesi.»
In sostanza, per essere un’azienda responsabile occorre avere uno scopo chiaro, e ciò richiede una profonda comprensione di ciò che l’azienda può e non può fare per affrontare le sfide sociali e ambientali e fornire allo stesso tempo rendimenti a lungo termine per i suoi azionisti.
SIATE TRASPARENTI NEI VOSTRI BILANCI DI SOSTENIBILITÀ
Gli standard di rendicontazione pongono le basi per la trasparenza ESG. Tredici anni dopo aver co-fondato il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) con Jean Rogers, devo purtroppo dire che non siamo ancora arrivati a un insieme universalmente riconosciuto di standard, ma ci siamo quasi. Gli standard di rendicontazione finanziaria richiedono alle aziende di riportare le performance finanziarie sia positive sia negative, quelli di rendicontazione di sostenibilità faranno lo stesso. Permetteranno alle aziende di essere più trasparenti nel riportare sia le performance ESG sia quelle d’impatto. Se le aziende stanno rendendo il mondo un posto migliore mentre fanno guadagnare gli azionisti, saranno in grado di spiegare come lo fanno. Se stanno peggiorando il mondo, risulterà evidente. Se stanno migliorando il mondo a scapito degli azionisti (e probabilmente di alcuni stakeholder), sarà altrettanto chiaro. Una rendicontazione limpida che utilizzi standard condivisi è l’unico modo per evitare il greenwashing e non nascondersi dietro il greenhushing.
Attualmente, esistono diversi modelli di riferimento che plasmano gli standard a livello globale. L’International Sustainability Standards Board (ISSB), sviluppato dalla IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation, si concentra sulla materialità finanziaria. In Europa, il Sustainability Reporting Board (SRB) ha sviluppato 12 standard che richiedono alle aziende di relazionare su questioni ESG finanziariamente rilevanti e su quelle che producono un impatto sociale più ampio. Negli Stati Uniti, la SEC ha diramato una regola sulla trasparenza climatica ma, dopo aver affrontato cause legali da parte di gruppi che volevano di più dalla norma e da quelli che non la volevano affatto, l’ha sospesa. Infine, la Global Reporting Initiative (GRI), che risale alla fine degli anni ‘90, si concentra principalmente sugli impatti esterni di un’azienda, rivolgendosi agli stakeholder interessati dagli effetti sociali complessivi prodotti dalle azioni aziendali. È in corso un dibattito per armonizzare questi standard in modo da facilitare il carico di rendicontazione per le aziende e raggiungere uno standard globale uniforme. Nel frattempo, le aziende in Europa devono ovviamente conformarsi agli standard SRB. Le aziende che utilizzano gli standard GRI dovrebbero continuare a farlo. E tutte le aziende dovrebbero lavorare per implementare gli standard ISSB.
SIATE COSTRUTTIVI NEL COINVOLGERE AZIONISTI E STAKEHOLDER
Le proposte degli azionisti, sia pro che anti-ESG, sono ormai al centro della guerra culturale che si sta combattendo negli Stati Uniti. Le proposte legate all’ESG sono salite da 273 nel 2022 a 337 nel 2023. Principalmente, sono state presentate alle assemblee generali annuali di aziende che hanno un grande impatto sul clima (come Chevron ed ExxonMobil) o che sono strettamente legate a questioni sociali di alto profilo (come i diritti dei lavoratori in Amazon e l’uguaglianza razziale in Walmart). Tuttavia, il supporto degli investitori a tali proposte è diminuito: nello stesso periodo, si è passati da un 30% a un 20%, in media. Contestualmente, le proposte anti-ESG, per lo più centrate sulle azioni DEI (diversità, equità e inclusione), sono aumentate: dalle 30 del 2021 alle 79 del 2023. Ottengono, però, un supporto molto inferiore da parte degli investitori, attestandosi intorno al 3%.
La qualità delle proposte ESG degli azionisti varia e alcune sono focalizzate più su opinioni politiche (basate sui valori) che su benefici economici o finanziari (basate sul valore). Le proposte pro-ESG tendono ad ammantarsi di concetti che richiamano la creazione di valore per gli azionisti, ma gli argomenti che portano sono spesso vaghi e non supportati da prove, come “il rischio climatico è un rischio finanziario” e “la diversità migliora la performance”. Ironia della sorte, mentre i critici di destra imputano al’ESG di voler promuovere un’agenda politica liberal, la maggior parte delle proposte anti-ESG sostenute dai conservatori è palesemente di natura politica (dato che usa dichiarazioni del tipo “affrontare il cambiamento climatico mina l’industria dei combustibili fossili in America” e “i programmi DEI discriminano gli uomini bianchi”). Affermano che l’ESG è dannoso per i valori azionari, ma non portano alcun argomento reale che dimostri perché la loro visione alternativa sarebbe migliore.
Anche se le proposte ESG degli azionisti sono aumentate, ben poche aziende le accolgono. Ciononostante, il fenomeno mostra bene le pressioni che tutte le aziende si trovano ad affrontare. Il cambiamento climatico (nel mirino dei progressisti) e la DEI (nel mirino dei conservatori) sono i due argomenti che generano la pressione maggiore sulle aziende. La sinistra, tipicamente rappresentata da ONG e investitori socialmente responsabili, vuole che le aziende si assumano maggiori responsabilità nell’affrontare le questioni ambientali, sociali e di governance. La destra, tipicamente rappresentata da politici e associazioni di categoria conservatrici, accusa le aziende di intromettersi nelle questioni di politica pubblica a scapito della creazione di valore per gli azionisti. Spinte contrastanti sono connaturate a un mondo di visioni ideologiche contrapposte. Non spariranno mai.
Il modo migliore per un’azienda di affrontare queste pressioni è attraverso una rendicontazione trasparente e un coinvolgimento costruttivo, anche di gruppi estremamente ostili. Ignorarli non li farà sparire. Denigrarli porterà a una risposta emotiva, non razionale. I leader aziendali e i loro CdA dovrebbero ascoltare ciò che i critici hanno da dire. Dovrebbero quindi spiegare quali questioni legate alla sostenibilità non sono importanti per la creazione di valore, riconoscendo che alcune di esse potrebbero diventare rilevanti in futuro qualora la legge dovesse cambiare. Le aziende dovrebbero spiegare cosa possono e cosa non possono fare riguardo alle loro esternalità negative e identificare le aree in cui è necessario introdurre qualche forma di regolamentazione. Alcuni di quelli che si aspettano che un’azienda “faccia di più” ascolteranno, altri no. Alcuni ascolteranno e saranno d’accordo in privato, ma manterranno una posizione diversa in pubblico, perché questo fa parte della loro strategia complessiva per esercitare pressione sul settore privato e su quello pubblico.
Ecco perché è così importante, per un’azienda, essere proattiva nel coinvolgere azionisti, ONG, politici e associazioni di categoria. Deve essere chiara sul fatto che le questioni legate alla sostenibilità sono vitali per la creazione di valore e spiegare come questo funzioni in termini finanziari. Deve dare forma alla propria narrativa invece che giocare in difesa contro quelle create da altri. Prendiamo Unilever, che ha affrontato delle critiche per la sua attenzione alla sostenibilità. Sotto la guida del nuovo CEO, Hein Schumacher, ha sviluppato un “piano d’azione per la crescita” che, secondo una lettera pubblica dello stesso Schumacher e del CSO Rebecca Marmot, fa sì che l’azienda si concentri sul fare meno cose meglio e con maggiore impatto. La lettera dice che questo approccio si applica anche alla sua agenda di sostenibilità. L’azienda ora si concentra principalmente su quattro grandi priorità di sostenibilità: clima, natura, plastica e mezzi di sussistenza. «Questi sono gli ambiti di maggior rilevanza per il nostro business, quindi abbiamo implementato piani dettagliati, con scadenze precise, per garantirne il raggiungimento, allo stesso modo in cui siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi finanziari.»
NON SI PUÒ NEGARE che i leader aziendali debbano affrontare alcune questioni difficili riguardo a cosa significhi essere un’azienda responsabile. Queste questioni devono essere risolte con metodo e imparzialità. In altre parole, all’opposto di come la guerra culturale in atto tratta le questioni ESG. Per questo motivo, sospetto (e spero) che l’acronimo ESG alla fine scomparirà completamente. Piuttosto che parlare di ESG, i dirigenti aziendali devono essere chiari e trasparenti su quanto le loro siano aziende responsabili che stanno gestendo le esigenze di azionisti e stakeholder, e su quali esternalità negative non possono migliorare senza che intervengano dei cambiamenti nel contesto normativo. Spetterà quindi al resto di noi, la comunità intera, avviare una conversazione costruttiva su come creare al meglio una società equa e sostenibile per le generazioni future. Vista attraverso questa lente, superare le guerre culturali sull’ESG è, in realtà, la parte più facile.
ROBERT G. ECCLES è visiting professor di Pratiche manageriali alla Saïd Business School dell’Università di Oxford e presidente fondatore del Sustainability Accounting Standards Board.