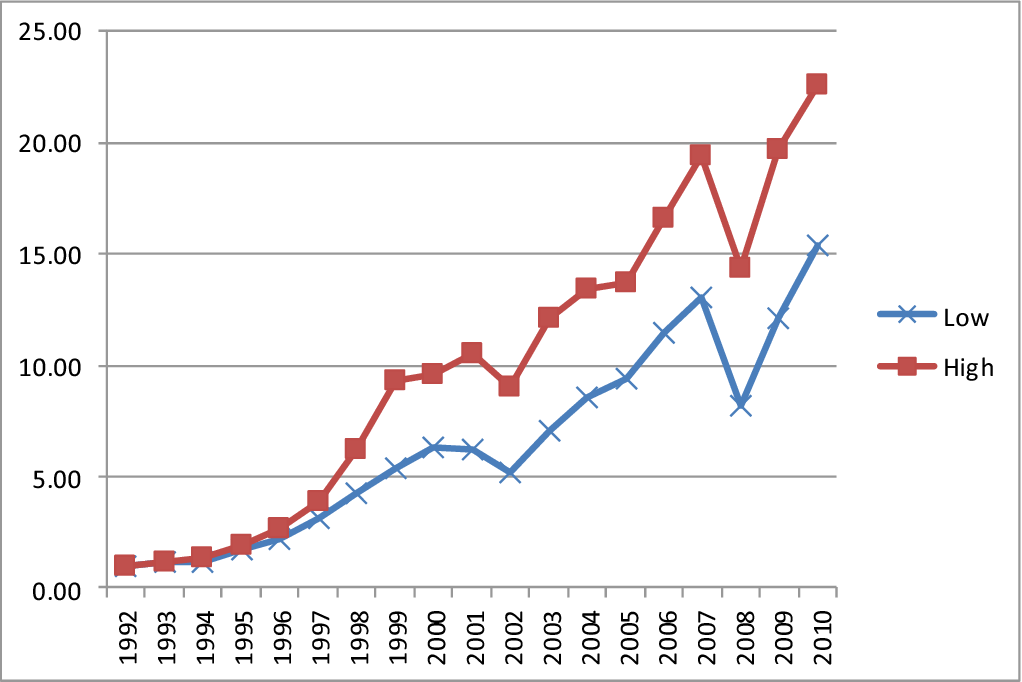Il problema centrale di Libra, la nuova moneta digitale di Facebook, sarà la fiducia? Probabilmente sì. Eppure vale la pena proporre una riflessione più radicale. Se le criptovalute strettamente intese, come Bitcoin o Ethereum, nascono dal completo rifiuto di un’autorità centrale – ad esempio, una Banca centrale o anche il sistema delle istituzioni finanziarie – e dunque dall’impossibilità di affidarle un ruolo di controllo e certificazione di scambi e transazioni, tutto questo non si potrà certo dire della divisa voluta da Menlo Park e da altri (per ora) 27 grossi partner che vanno da Mastercard a Uber, da Coinbase a PayPal, in un mix di player finanziari, dei servizi e delle criptovalute strettamente intese.
Decentralizzazione, insomma, ma fino a un certo punto. Perché la blockchain sulla quale sarà basata Libra sarà comunque in mano all’omonima associazione ginevrina che ne orchestrerà l’intera organizzazione. I primi nodi attraverso cui le transazioni saranno processate, validate e registrate passeranno infatti dai membri fondatori, contrariamente allo schema classico delle criptovalute, davvero fuori dal controllo anche di un pur ampio nucleo di soggetti principali. In altre parole, come si domanda The Verge, se gli americani non si fidano della Federal Reserve o gli europei diffidano della Bce, perché dovrebbero fidarsi di Mark Zuckerberg, di Visa o di Mastercard come garanti dell’infrastruttura di una nuova valuta?
Me lo spiega molto bene Fabio Pezzotti, cofondatore di Iconium Blockchain Ventures Spa, una società fintech dedicata al lancio, sviluppo, e partecipazione in progetti legati a cripto-valute, token e altri asset digitali: “Sarà interessante vedere la reazione di utenti, aziende e governi a Libra. Facebook ha creato un consorzio importante e tecnologicamente eccellente, ma sembra manchi uno dei pilastri della blockchain: la decentralizzazione. Da capire anche le reazioni dei vari governi che stampano monete sovrane. Potrebbero essere rese inutili o almeno molto meno utilizzate nei pagamenti p2p e nell’e-commerce globale. Inoltre, visto che ogni Paese ha una sua normativa, spesso differente dalle altre, i problemi che la stablecoin di Facebook dovrà risolvere saranno molto più simili a quelli ad esempio di PayPal che non a quelli delle criptovalute decentralizzate come Bitcoin. Detto questo, secondo noi Libra faciliterà e incrementerà l’adozione di criptovalute in generale dal mercato, quindi sarà funzionale all’intero ecosistema, ma troverà forti resistenze negli ambiti più tradizionali. JP Morgan e Goldman Sachs, ad esempio non partecipano al progetto”.
Insomma, l’impressione e soprattutto il rischio che Libra corre – e la creazione dell’ecumenica no profit a Ginevra né è un po’ la controprova, così come l’assenza di nomi come Google, Apple o Amazon dalla santa alleanza – è che in fondo venga pur sempre etichettata come la “moneta di Facebook”. Non la “moneta di nessuno”, come in fondo sono state le più celebri criptovalute, etichetta che le ha condotte all’ottovolante delle quotazioni e al ricatto della speculazione. Discorso diverso per i token, ovviamente, spesso legati a una Ico, un’Initial coin offering, sorta di quotazione di nuove imprese o piattaforme (o di medesimi progetti di criptovalute) con distribuzione di crediti digitali. Anche il nome, in fondo, punta a sollevare il tema della fiducia: si chiama Libra, come suggerisce Arcangelo Rociola dell’Agi, “non perché vuole ‘riequilibrare’ il potere della finanza a favore di Zuck&Co. Ma libra (bilancia) è puro marketing, dà idea di stabilità, equilibrio, insomma ‘fidarsi che sta roba funziona’”. Poche illusioni.
Facebook ha immaginato il progetto, pensato la blockchain, messo insieme i partner e, soprattutto, il social network porta in dote il suo continente digitale di oltre 2,3 miliardi di utenti. Avendo anche piena contezza di quanti e dove non abbiano accesso a servizi bancari tradizionali, dunque proseguendo nella sua campagna ai mercati in via di sviluppo, fallita con l’internet gratis e ora di nuovo alla carica con il banking gratis. La benzina iniziale per alimentare la macchina. I borsellini di Libra esordiranno su WhatsApp e Messenger, in cui saranno incorporati, e il loro primo utilizzo sarà quello fra privati, nello scambio di crediti fra “amici” e utenti. Insomma, conosceremo Libra anzitutto tramite l’ecosistema di Zuckerberg. Dunque, come spiega giustamente The Verge, almeno all’inizio “usare Libra significherà fidarsi di Facebook, prova molto dura nel 2019”. Ma soprattutto, mentre la missione delle criptovalute era appunto quella di frammentare il potere di controllo e certificazione finanziaria fra migliaia di nodi diffusi e anonimi, ma soprattutto inabili ad allearsi per conquistare quel controllo tanto contestato, usare Libra significherà fornire ancora più potere a uno dei colossi del pianeta. Una piattaforma che in fondo non ha dimostrato di meritare troppa fiducia nell’uso dei dati dei suoi utenti.
In altre parole, Libra non è una criptovaluta, come in molti ripetono in queste ore, ma potrebbe al contrario uccidere quel mondo. Per esempio, almeno nei primi cinque anni, solo le società che fanno parte dell’associazione potranno fare “mining” di Libra, cioè creare la valuta, il tutto al fine di renderla più stabile. Così la Libra Association diventerà nella sostanza una nuova Banca centrale che coordinerà e custodirà il tesoretto di asset sulla base dei quali quella “stablecoin” metterà radici e pomperà i muscoli (saranno “asset a bassa volatilità, come depositi bancari e titoli di Stato a breve termine denominati in valute di Banche centrali stabili e ad alta reputazione”).
In questo senso la blockchain di Libra procederà probabilmente in molto spedito ma tradendo l’impostazione di fondo sulla fiducia. Per evitare gli scossoni è infatti fondamentale affidarsi a un’autorità centrale, per quanto sui generis, come quella della Libra Association. Almeno all’inizio, per i famosi cinque anni individuati nel white paper di Menlo Park, quando i problemi della scalabilità saranno risolti (o meglio, disinnescati) e l’accesso all’associazione dovrebbe essere più semplice, così come la possibilità di proporsi come nodo della catena. Ma i player fondatori saranno così magnanimi da lasciar entrare altri, cioè da perdere parte del controllo che praticheranno fin dall’inizio su Libra? Forse i cinque anni sono solo una promessa, un modo per partire con una blockchain sotto controllo e poi si vedrà quel che succede. Intanto cominciate a digitalizzare i vostri soldi e a convertirli in Libra.
Fiducia, insomma, fiducia allo stato puro. Che passa pur sempre dai dati. Lo spiega bene oggi su Repubblica Eugeny Morozof, fra i più celebri studiosi di digitale e critici dei pachidermi hi-tech: “Bisogna essere pazzi o masochistici per fidarsi ancora di Facebook che parla di “bene pubblico” o “privacy”: hanno dimostrato negli anni che queste non sono loro preoccupazioni Vi fidereste di un’azienda che – nelle parole del suo ex senior staff – è impegnata a creare dipendenza digitale e poi dice di lavorare al “bene pubblico”?”. Ma il punto ruota soprattutto intorno ai dati: “Quando quello che facciamo produce dati chiunque controlla i dati controlla anche tutto quello che facciamo: le transazioni monetarie non fanno eccezione”.
Se ne sa ancora poco, certo. Ma molti sono già sulle barricate. Dalla politica ai più celebri critici come Matt Stoller di Open Markets che ha definito la proposta come “un Fondo monetario internazionale privato e globale guidato dai compagni di merende della tecnologia”. Il percorso sarà lungo, nonostante le aperture concorrenziali nel mondo della finanza che hanno dato grande spolvero al contesto fintech Facebook si muoverà pur sempre da una parte iper-regolamentato (ma la capacità di lobbying non gli manca) e dall’altro in mano alle grandi istituzioni bancarie private, anch’esse – non solo le Banche centrali – semafori del mercato delle valute e in ultima istanza delle politiche monetarie dei Paesi. Non fosse, basta ricordarlo, nelle loro scelte sull’acquisto dei debiti sovrani o sul finanziamento alle imprese, cioè nel modo in cui impiegano la liquidità dei cittadini.
Certo è che, per ora, chiamare Libra una criptovaluta è un errore di fondo: “Con questa operazione Facebook cerca di entrare in modo deciso nell’ambito della finanza digitale – spiega a Esquire Raffaele Mauro, managing director di Endeavor Italy e autore del libro “Hacking finance” (Agenzia X) – si tratta di una mossa importante visto l’impatto potenziale legato alla dimensione della base utenti, circa 2,4 miliardi di persone, già profondamente interconnesse tra loro da un ecosistema di applicazioni e servizi come WhatsApp e Instagram. E’ troppo presto per giudicare nel merito la validità del progetto, ma la direzione è chiara. Il mondo del consumer internet in occidente vive dei tentativi di “cinesizzazione” con piattaforme che cercano di integrare o centralizzare diverse categorie di servizi, creando grandi vantaggi per gli utenti ma anche ulteriori dimensioni di rischio in termini di sicurezza e privacy. Si tratta di un mondo molto diverso rispetto al retroterra culturale dal quale sono nate le criptovalute, legate ai principi di decentralizzazione e non-censurabilità, quest’ultimo difficilmente può essere accomunato ai progetti dei giganti dell’economia di Internet”.