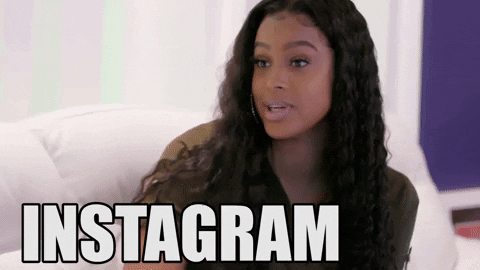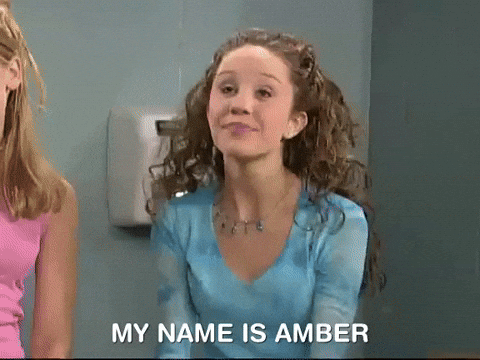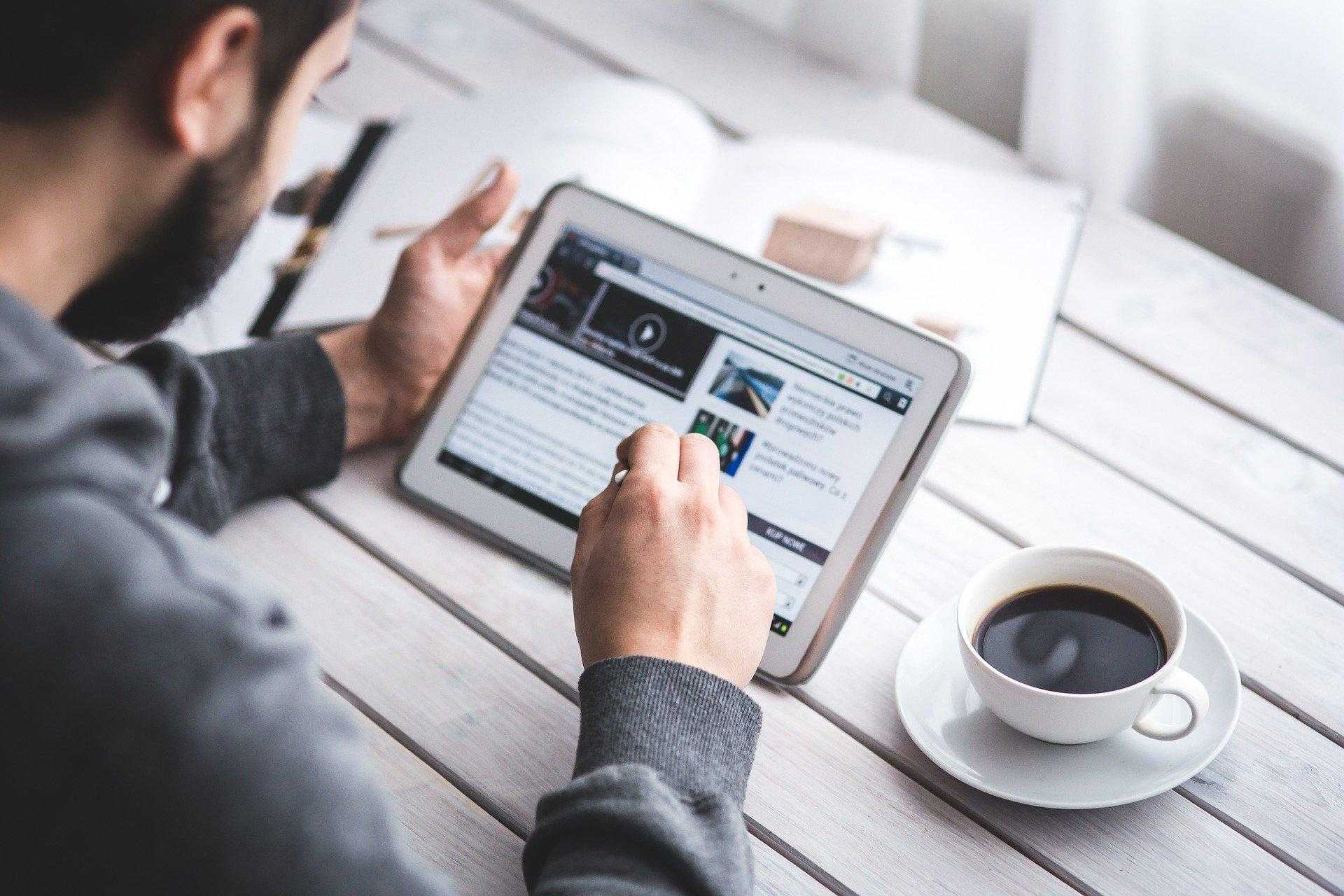F8, FACEBOOK: DA NEWSFEED A MESSENGER, STORIES E GRUPPI
“As the world gets bigger and more connected, we need that sense of intimacy more than ever. That’s why I believe that the future is private”
Mark Zuckerberg ha aperto con queste parole questa edizione dell’F8, la conferenza annuale dedicata al futuro dell’ecosistema Facebook.

La privacy è rapidamente diventata un tema molto caldo nei piani di sviluppo di tutte le piattaforme, in particolare di Facebook, che nell’ultimo anno è stato al centro di una serie di controversie legate alla scarsità di controllo delle informazioni personali degli utenti.
Il CEO di Facebook ha identificato 3 aree fondamentali per l’evoluzione della comunicazione online:
• messaggistica privata
• contenuti effimeri
• piccoli gruppi
Negli ultimi anni l’impegno di Facebook è stato soprattutto dare alle persone la possibilità ci connettersi con tutto il mondo, oggi la nuova sfida è trovare il modo di dare agli utenti controllo e protezione in termini di privacy: fino a ieri Facebook è stata soprattutto una piazza dove incontrare nuove persone, prendere parte a conversazioni pubbliche e condividere i nostri contenuti potenzialmente con chiunque; domani quelle stesse piattaforme dovranno darci la possibilità di fare lo stesso, ma in una sfera più privata, come se ci trovassimo nel salotto di casa nostra, dove siamo noi a decidere chi far accomodare e dove possiamo essere veramente noi stessi.
Zuckerberg sottolinea che il miglior modo per esprimerci liberamente è farlo con le persone di cui ci fidiamo e con cui vogliamo interagire, proprio come nel salotto di casa, dove possiamo agire con più naturalezza e con meno timori rispetto a quanto facciamo in pubblico.
Questa premessa non riguarda soltanto la piattaforma Facebook, ma tutto l’ecosistema.
Nei piani di Zuckerberg, Messenger diventerà ancora più centrale: verrà lanciata un’App completamente rivista, più leggera e veloce, disponibile anche da desktop, e soprattutto avrà una encryption end-to-end, proprio come Whatsapp.
Ci sarà una completa integrazione di Facebook Watch, per spingere le persone a guardare contenuti video insieme ai propri amici o familiari, proprio come farebbero nel salotto di casa, commentando e interagendo in tempo reale.

All’interno di Messenger troveremo anche uno spazio dedicato alla scoperta di contenuti dei nostri contatti più stretti: sarà possibile decidere chi potrà trovare e vedere quei contenuti.

Questo significa che i brand dovranno essere capaci – ancor più che in passato – di creare contenuti che le persone non solo vogliano guardare, ma che desiderino anche condividere e commentare insieme ai loro amici.
Un’altra importante novità per i brand riguarda la possibilità di aggiungere “lead generation template” all’Ads Manager, dando così alle aziende l’opportunità di intrattenere conversazioni più intime con i propri consumatori e aiutandole a instaurare una relazione ancora più diretta.

Non va dimenticato che sarà possibile inviare pagamenti via Messenger, facendo sì che Facebook diventi a tutti gli effetti un Marketplace da cui non ci sarà bisogno di uscire per finalizzare un acquisto.
Anche Instagram sarà ancor più focalizzato nella possibilità di effettuare acquisti direttamente dalla piattaforma, senza mai abbandonarla, dal momento della scoperta a quello del checkout: Shop From Creators è una nuova funzionalità che consentirà ai creator di avere una connessione ancora più diretta con i brand con cui stanno collaborando.
“Le persone stanno già acquistando grazie ai creator, chiedendo loro informazioni sui prodotti via Direct o nei commenti”.
Fino a ieri solo i brand potevano inserire tag relativi ai propri prodotti, d’ora in poi potranno farlo anche creator e influencer: questo consentirà loro di fornire alle persone le informazioni che stanno cercando, anticipando quello che oggi succede, appunto, nei commenti o via Direct.
Saranno anche disponibili analytics che permetteranno di capire quali contenuti stanno performando meglio – relativamente allo shopping – e questo aiuterà i creator e gli influencer a capire quali collaborazioni sono più in linea con i gusti e gli interessi delle persone che li seguono: questo può diventare un grande vantaggio – soprattutto nel medio/lungo periodo – sia per i creatori, sia per i brand, che avranno un ulteriore strumento per valutare la bontà – o meno – di una collaborazione.
Shop From Creators entrerà in fase di test nei prossimi giorni, coinvolgendo alcuni influencer come Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner e Leesa Angelique che dichiara:
“Parte del mio lavoro è fornire consigli e suggerimenti sul mondo beauty. Solitamente scrivo descrizioni molto lunghe e dettagliate relative ai prodotti che sto usando: questo nuovo strumento renderà molto più facile far sapere alle persone cosa sto indossando o che prodotti sto provando”

Diventerà quindi ancora più importante per i brand individuare i creator più adatti con cui collaborare, scegliendoli sulla base del tipo di contenuti che si desidererà veicolare e degli obiettivi che ci si è posti: se già oggi si tratta di un asset strategico di enorme importanza, con questo strumento e lo spostamento del baricentro dal feed/timeline a un ambiente sempre più privato e diretto, sarà davvero importante essere in grado di creare quelle che Zuckerberg definisce “meaningful interactions”.
Verranno poi introdotti nuovi strumenti pensati per spingere le persone a focalizzarsi sui contenuti: il nuovo Create Mode permetterà di creare un contenuto da zero, senza bisogno di caricare una foto o un video, e darà la possibilità di utilizzare una serie di tool creativi per incentivare le persone a produrre sempre più Stories.
“Focus on the photos and videos you share, not how many likes they get.”

La seconda area d’interesse indicata come cruciale da Zuckerberg riguarda proprio i contenuti effimeri: meno rilevanza ai Like e alle vanity metrics e più focus sulla creatività delle Stories.
La notizia più sorprendete riguarda la volontà di ridurre il focus sul numero di follower e sulla visibilità dei Like di ogni contenuto: Adam Mosseri – Head of Instagram – spiega che la direzione della piattaforma sarà quella di premiare sempre più i contenuti di qualità (offrendo nuovi strumenti ai creator, appunto) e la volontà di connettersi con altri utenti, non soltanto in cerca di Like, ma per interessi affini.
La popolarità di questo formato è in continua crescita su tutte le piattaforme dell’ecosistema Facebook (mentre rimane piuttosto costante su Snapchat, che di fatto le aveva rese mainstream nel 2010) e sta facendo sì che Instagram stia – per alcuni aspetti – sostituendo Facebook nel modo in cui le persone – sopratutto le generazioni più giovani – accedono ai contenuti, interagiscono con i loro amici e con i brand.

Proviamo a pensare a come usavamo i canali social 10 anni fa e a come lo facciamo oggi. È cambiato tutto: dai formati, al modo in cui ci esprimiamo, al tipo e quantità di contenuti che consumiamo.
Facebook è diventato un luogo completamente diverso, un po’ per la nascita e l’evoluzione di altre piattaforme, come Instagram appunto, un po’ perché è cambiato il contesto in cui viviamo, gli strumenti che usiamo per accedere a internet e l’attenzione verso alcune tematiche relative alla privacy.
“Today we’re making changes that put Groups at the center of Facebook and sharing new ways Facebook can help bring people together offline.”
Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la terza grande area di interesse: i gruppi.

Facebook è nato come piazza virtuale, un luogo a cui accedere quando si voleva interagire con i propri amici e familiari; è poi diventato anche il posto in cui informarsi e interagire anche con le aziende.
La visione di Zuckerberg è quindi di dare più controllo alle persone che vogliono condividere i loro interessi: lo stanno già facendo usando i Gruppi. Per questo saranno elemento sempre più centrale non solo nella nuova interfaccia di Facebook (che verrà rilasciata nei prossimi giorni sia per mobile, sia per desktop), ma anche a livello strategico.

FB5, è questo il nome del redesign che Zuckerberg definisce “the biggest change we’ve made to the Facebook app and site in five years”: la nuova interfaccia darà molta più centralità ai Gruppi, che già oggi sono utilizzati da più di 1 miliardo di persone ogni mese, e ha l’obiettivo di veder crescere questo numero, che – idealmente – dovrebbe coincidere con quello delle persone che usano Facebook (2.38 miliardi) per incentivare gli utenti a connettersi con altre persone con gli stessi interessi e le stesse passioni.
Se volessimo riassumere le novità che riguardano la piattaforma Facebook, potremmo dire: meno centralità al Newsfeed, più enfasi su Gruppi, Marketplace e Watch.
Tutto questo, ovviamente, avrà un grosso impatto sul modo in cui i brand dovranno comunicare e sarà quindi ancora più importante che in passato guardare a Facebook come ecosistema fatto di diverse anime e non come a silos a compartimenti stagni: si apriranno nuove opportunità – anche relative ai prodotti sponsorizzati – e andranno studiate ancora più in profondità le abitudini delle persone, sfruttando ogni touchpoint secondo le sue regole e le sue specificità.
Sarà fondamentale, nei prossimi mesi, non solo capire in che modo rivedere alcune logiche che si erano consolidate, ma anche capire come nuovi canali potranno diventare strategici per raggiungere consumatori che stanno modificando non solo il loro modo di accedere ai contenuti, ma anche di acquistarli (basti pensare a quanto velocemente stiano evolvendo soluzioni in VR o AR – Kimberlee Archer, Head of Developer Marketing AR/VR, ha dichiarato che nell’ultimo anno +1 miliardo di persone hanno fruito di contenuti AR, giusto per avere un’idea della rapidità con cui si stanno diffondendo).

Questi cambiamenti, chiaramente, hanno anche a che vedere con la volontà di Facebook di individuare altre fonti di guadagno, oltre all’advertising: lo scorso anno sono le revenue sono state di circa $56 miliardi, quasi interamente provenienti da prodotti sponsorizzati.
Negli ultimi mesi il tasso di crescita degli utenti registrati in Europa e USA è rimasto pressoché costante, ma impone di trovare nuovi modi di monetizzare per sostenersi: le novità presentate durante l’F8 vanno nella direzione di tenere per più tempo possibile le persone all’interno delle applicazioni dell’ecosistema, integrando strumenti di e-commerce che i brand potrebbero iniziare ad usare.
Queste nuove feature, unite a quelle legate a Stories e video (soprattutto l’incentivo a guardarli insieme ad altre persone), vanno proprio nella direzione di far sì che per molte persone internet corrisponda a Facebook (inteso come ecosistema), proprio come successo in Cina con WeChat, che integra una serie di funzionalità che – di fatto – lo rendono internet tout court per moltissime persone.
L’elenco delle altre novità annunciate durante i due giorni di F8 è ancora lungo, quindi se volete approfondire potete leggere i post condivisi sulla Newsroom di Facebook qui e qui.
Se invece volete commentare con noi la nuova direzione che sta prendendo Facebook, potete farlo nei commenti o seguendoci su Facebook, Instagram e Twitter.