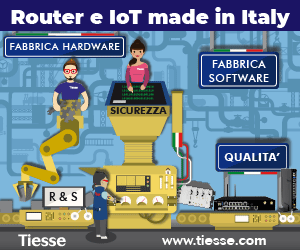Riflessioni personali su come sia vivere da immigrati nell’America di Trump

Di Helio Fred Garcia
Titolo originale: Personal reflectionon being an immigrant in Trump’s America
Sono un immigrato, un americano per scelta. Ho scelto di essere un americano perché di tutti i posti del mondo – e ho avuto la fortuna di aver visitato o lavorato in dozzine di paesi in sei continenti – questo è uno dei pochi posti in cui le circostanze della tua nascita non determinano il resto della tua vita. E dove l’aspirazione nazionale, ancora in corso d’opera, ci incoraggia a essere noi stessi migliori. Sono stato in grado di costruire una buona vita qui. Ho sposato una persona meravigliosa e insieme abbiamo cresciuto due giovani donne straordinarie. Mi sono laureato in due delle migliori università del paese e sono professore in entrambi. Ho lavorato con o per alcune delle migliori aziende del mondo. Passo come un americano e porto con me tutte le manifestazioni del privilegio bianco.
Ma non è stato sempre così.
Benvenuto in America – Ora vattene a casa o altrove!
Quando sono arrivato dal Sud America da bambino, ero diverso dagli altri bambini. Sono stato un bersaglio facile. Pelle e ossa. Con un nome imprecisabile, un forte accento straniero e una padronanza molto debole della lingua inglese.
Ero l’altro. Ero un bersaglio. Sono stato tormentato per anni da un branco di ragazzi che hanno visto in me l’opportunità di sentirsi superiore. Mi è stato costantemente detto di tornare da dove vengo. Ma ciò che è iniziato con insulti, insulti e insulti si è trasformato in violenza fisica e umiliazione sessuale. Sono stato picchiato. Sono stato trattenuto da ragazzi che a turno mi pisciavano addosso per poi scappare ridendo. Più di 50 anni dopo porto cicatrici intorno agli occhi, dove sono stato preso a calci con un pesante stivale. Ora che non ho più i capelli, si notano molte altre cicatrici, specialmente nella parte superiore e posteriore della mia testa, dove sono stato colpito con bastoni, pietre e in almeno un caso con un mattone. Ho anche cicatrici sulla mia anima.
Ma sono stato anche molto fortunato. Avevo un certo numero di insegnanti premurosi e dotati che mi hanno fatto il loro “progetto”, investendo tempo e amore non solo a scuola ma anche oltre l’aula. Grazie a loro sono diventato maggiorenne nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, come Paggio, osservando la Camera dibattere gli atti di impeachment contro il presidente Richard Nixon. Da allora ho incontrato presidenti e primi ministri, un re, diversi principi, un papa e centinaia di leader religiosi della maggior parte delle tradizioni di fede del mondo. Ho consigliato centinaia di amministratori delegati e funzionari pubblici. Ho visitato la Casa Bianca per lavoro tre volte, sotto tre presidenti.
Ma nel mio settimo decennio ho ancora la paura viscerale di trovarmi da solo con uomini con i quali non ho un rapporto di autorità. Evito eventi sportivi; non esco con gruppi di uomini. Ho solo una manciata di amici maschi. Il mio terapista mi conferma che quasi 50 anni dopo gli assalti soffro ancora di una forma di disturbo post traumatico da stress. Sono ancora il ragazzino rannicchiato terrorizzato dai bulli.
Semper Fi!
Mio padre ha lavorato per quasi 30 anni per l’esercito degli Stati Uniti, insegnando a graduati e soldati in addestramento. Lui e mia madre, che non sono mai diventati cittadini, sono sepolti nel cimitero di West Point. Mio padre mi ha sempre detto che non c’è onore più grande che insegnare alle persone che indossano l’uniforme delle forze armate degli Stati Uniti.
A 21 anni sono diventato cittadino americano. Ho prestato giuramento affermando che avrei protetto e difeso la costituzione e servito la nazione. L’ho fatto. Anche se io personalmente non ho mai indossato l’uniforme, per quasi 30 anni ho insegnato e consigliato alti ufficiali dell’esercito degli Stati Uniti – principalmente marines. Ho insegnato a dozzine di generali e migliaia di alti ufficiali e sottufficiali, nonché membri di alto livello di ciascuno degli altri servizi armati. Quasi tutti questi insegnamenti sono stati proposti su base pubblica pro bono. È la mia forma di servizio nazionale.
Gran parte della mia carriera è stata una forma di sovra-compensazione per essere inarticolato e impotente. Ho lavorato per alcune delle migliori società di consulenza di comunicazione. Per quasi 20 anni ho posseduto e gestito una società di consulenza e coaching per la gestione delle crisi e la comunicazione della leadership. Il nostro lavoro aiuta i leader a diventare leader migliori sfruttando il proprio potere con umiltà ed empatia, costruendo fiducia collegandosi in modo significativo con gli altri. Ho scritto quattro libri su come usare il potere della comunicazione al meglio.
Ma sono stato anche profondamente consapevole dell’uso della comunicazione per ferire, danneggiare e umiliare. E di come il linguaggio disumanizzante e demonizzante possa portare alcune persone a commettere atti di violenza.
Il tono dall’alto
Il Centro Simon-Skjodt per la prevenzione del genocidio del Museo dell’Olocausto definisce i “discorsi pericolosi” come discorsi di odio che, nelle giuste condizioni, possono influenzare le persone ad accettare, perdonare e commettere violenza contro i membri di un gruppo.
E stiamo vedendo quel tipo di discorso in questo momento storico. Il 14 luglio il presidente Trump ha twittato su quattro nuovi membri del Congresso, tutte donne di colore. Una di essi, On. Ilhan Omar, è rifugiata dalla Somalia, che è venuta in America da bambina, è diventata cittadina americana e ha scelto una carriera nel servizio pubblico. Gli altri sono tutti cittadini americani.
Tweet di Trump:
“È interessante vedere le donne democratiche e progressiste, che originariamente provenivano da paesi i cui governi sono una catastrofe completa e totale, la peggiore, la più corrotta e inetta in qualsiasi parte del mondo (anche se hanno un governo funzionante), ora ad alta voce e dire ferocemente al popolo degli Stati Uniti, la più grande e potente nazione sulla terra, come deve essere gestito il nostro governo. Perché non tornano indietro e aiutano a riparare i luoghi totalmente distrutti e infestati dal crimine da cui provengono? Dopo, tornino a mostrarci ciò che hanno ottenuto”
Naturalmente, tre dei quattro non provenivano da paesi diversi dagli Stati Uniti. Ma che lo abbiano fatto o meno, “tornare da dove vieni” è un’esperienza familiare di molti immigrati. È persino incorporato nella legge degli Stati Uniti, come primo esempio di razzismo. La Commissione per le pari opportunità nell’occupazione degli Stati Uniti, sul suo sito web sui diritti del lavoro degli immigrati, la elenca come un esempio esplicito del tipo di linguaggio che può violare le leggi federali sul lavoro:
“Esempi di condotta potenzialmente illegale includono insulti o epiteti etnici, come prendere in giro l’accento straniero di una persona o commenti come ‘Torna da dove vieni’, sia da parte di supervisori che da colleghi”.
La dichiarazione di Donald Trump su questi quattro membri della Camera dei Rappresentanti è semplicemente la più recente manifestazione di un fenomeno senza precedenti: l’uso del linguaggio da parte di un presidente degli Stati Uniti che ispira alcune persone a commettere violenza.
L’ex segretario del dipartimento della sicurezza nazionale Jeh Johnson, parlando del presidente Trump nel febbraio 2019, ha dichiarato: “Le persone ascoltano davvero i loro leader… La civiltà del nostro dialogo sta deviando verso il basso, in modo tale che gli individui … si sentono incoraggiati e, forse, hanno persino il diritto di prendere in mano la situazione e compiere atti di violenza”.
Tutte e quattro le donne congressuali segnalano aumenti significativi delle minacce di morte nei loro confronti. Ma vediamo anche la disinibizione che sottopone gli immigrati – e quelli percepiti come immigrati – a insulti, esclusione e violenza. Dieci giorni dopo i commenti di Trump’s Go Back, a uno dei miei ex studenti, dalla Cina, un uomo ben vestito ha sputato gridando: “Stupido asiatico, torna nel tuo paese”. Quando l’ho pubblicato su Facebook, un altro studente, dal Perù, ha commentato dicendo che il giorno prima un cliente – un cliente! – ha chiesto da dove veniva, e poi gli ha chiesto, “Perché non torni lì, allora?”
Molti altri miei amici, colleghi e studenti hanno riportato esperienze simili, con un notevole aumento questa settimana. Sono preoccupato per l’effetto del linguaggio di Trump, che può influenzare alcuni dei suoi seguaci a commettere violenza contro i suoi rivali e critici. Ma mi preoccupo di più dell’attuale generazione di immigrati, perchè per quanto brutta sia stata la mia esperienza – ed è stata piuttosto negativa – all’epoca non esisteva un Presidente degli Stati Uniti che ispirasse insulti, umiliazioni e violenza contro di me e altri immigrati.