“La bestia”, ovvero del come funziona la propaganda di Salvini
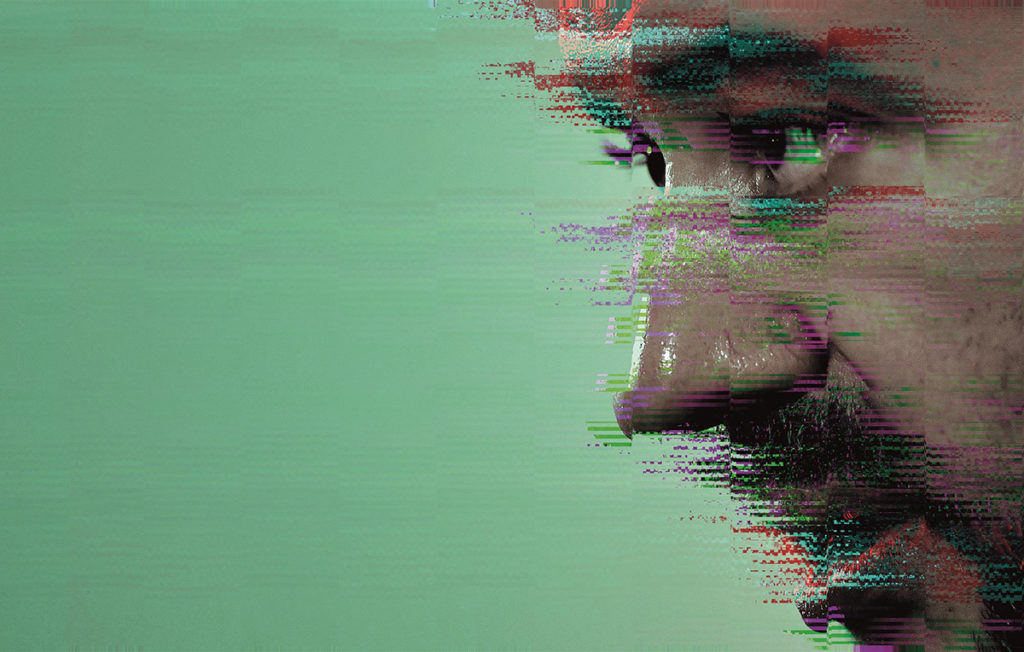
Intervista a Alessandro Orlowski, ex hacker e spin doctor digitale, che ci parla della strategia comunicativa della Lega, dell’affaire Cambridge Analytica, del business dei falsi profili twitter, del Gdpr, Facebook e molto altro
Alessandro Orlowski è seduto a un tavolino di un bar di Barcellona. Nato a Parma nel 1967, vive in Spagna da 20 anni. Ex regista di spot e videoclip negli anni ’90 e grande appassionato di informatica, è stato uno dei primi e più influenti hacker italiani. Fin da prima dell’arrivo dei social network, ha lavorato sulle connessioni digitali tra gli individui, per sviluppare campagne virali. Negli anni ha condotto numerose campagne in Rete, come quella per denunciare l’evasione scale del Vaticano o i gruppi estremisti negli Stati Uniti e in Europa. Oggi fa lo spin doctor digitale: ha creato Water on Mars, startup di comunicazione digitale tra le più innovative, e guidato il team social risultato fondamentale per condurre il liberale Kuczynski alla presidenza del Perù. Ci accomodiamo, e cominciamo a parlare con lui di politica nel mondo digitale, per arrivare presto a Matteo Salvini e allo straordinario (e inquietante) lavoro che sta realizzando online.
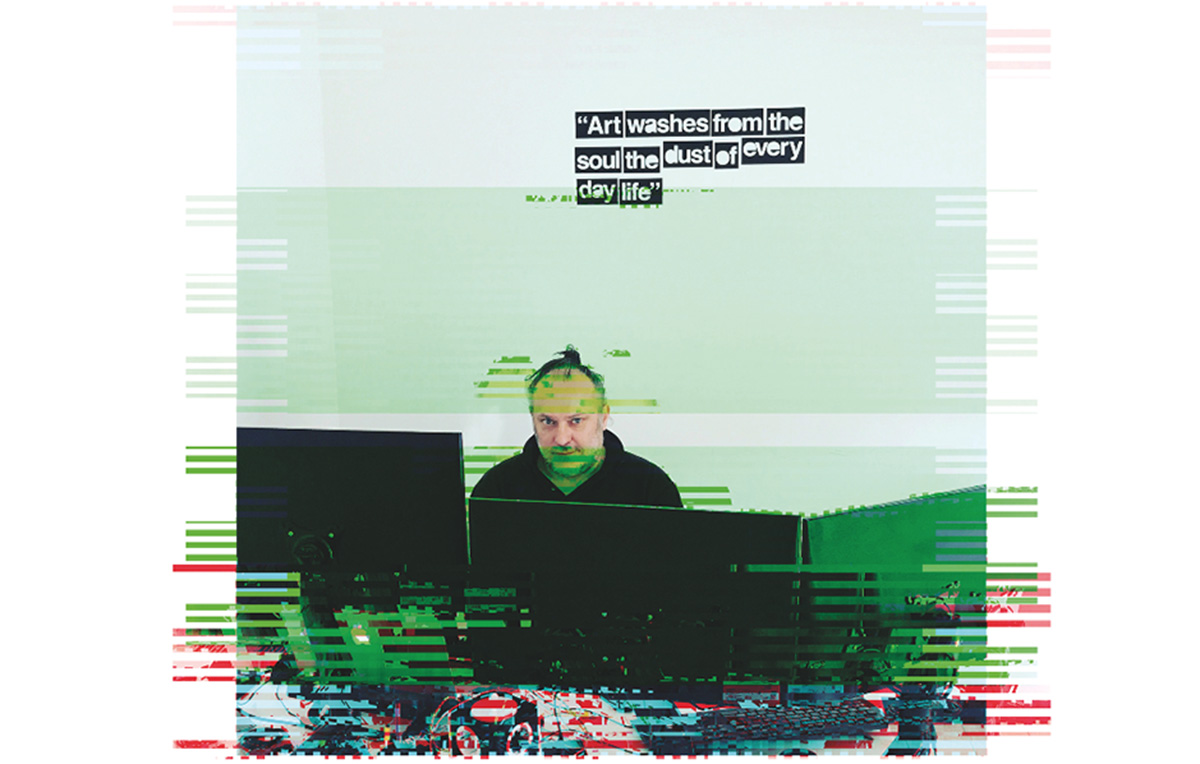
Alessandro Orlowski: Nato a Parma 50 anni fa, è tra i maggiori esperti
di hacking e comunicazione politica digitale in Italia
Che evoluzione ha avuto negli anni il concetto di “rete social”?
Nasce nei primi anni ’80 con le BBS, le Bulletin Boards System, antesignane dei blog e delle chat. La prima rete sociale, però, è stata Friendster nel 2002, che raggiunse circa 3 milioni di utenti. A seguire l’amatissima (da parte mia) MySpace: narra una leggenda nerd che fu creata in 10 giorni di programmazione. Il primo a usare le reti social per fini elettorali è stato Barack Obama nel 2008.
Oggi in Italia chi è il politico che maneggia meglio questi strumenti?
In tal senso la Lega ha lavorato molto bene, durante l’ultima campagna elettorale. Ha creato un sistema che controlla le reti social di Salvini e analizza quali sono i post e i tweet che ottengono i migliori risultati, e che tipo di persone hanno interagito. In questo modo possono modi care la loro strategia attraverso la propaganda. Un esempio: pubblicano un post su Facebook in cui si parla di immigrazione, e il maggior numero di commenti è “i migranti ci tolgono il lavoro”? Il successivo post rafforzerà questa paura. I dirigenti leghisti hanno chiamato questo software La Bestia.
Quando nasce La Bestia?
Dalle mie informazioni nasce dal team di SistemaIntranet di Mantova, ossia dalla mente di Luca Morisi, socio di maggioranza dell’azienda, e Andrea Paganella. Morisi è lo spin doctor digital della Lega, di fatto il responsabile della comunicazione di Salvini. La Bestia è stata ideata a fine 2014, e finalizzata nel 2016. All’inizio si trattava di un semplice tool di monitoraggio e sentiment. Poi si è raffinato, con l’analisi dei post di Facebook e Twitter e la sinergia con la mailing list.
Come funziona l’analisi dei dati, su cui si basa la strategia?
Diciamo che a livello di dati non buttano via nulla: tutto viene analizzato per stabilire la strategia futura, assieme alla società di sondaggi SWG e a Voices From the Blogs (azienda di Big Data Analysis, ndr). I loro report, su tutti quelli del professore Enzo Risso, sono analizzati attentamente dal team della Lega, composto da Iva Garibaldi, Alessandro Panza, Giancarlo Giorgetti, Alessio Colzani, Armando Siri e altri.
La Bestia differenzia il suo operato a seconda dei social, per rendere immutata l’efficacia di Salvini in base allo strumento?
Per chi si occupa di marketing e propaganda online, è normale adattare la comunicazione ai differenti social. Twitter è l’ufficio stampa, e influenza maggiormente i giornalisti. Su Facebook ti puoi permettere un maggiore storytelling. È interessante vedere come, inserendo nelle mailing list i video di Facebook, la Lega crei una sinergia con la base poco attiva sui social: la raggiunge via mail, e aumenta così visualizzazioni e condivisioni.
Operano legalmente?
Camminano su un lo molto sottile. Il problema riguarda la gestione dei dati. Hanno creato, per esempio, un concorso che si chiama “Vinci Salvini” (poche settimane prima del voto, ndr). Ti dovevi registrare al gioco online e quanti più contenuti pubblicavi a tema Lega, maggiori erano le possibilità di incontrare Salvini. È stato un successo. Il problema è che non sappiamo come siano stati gestiti i dati. A chi venivano affidati? A Salvini? Alla Lega? A una società privata?
C’è qualche legame con lo scandalo Cambridge Analytica in questo utilizzo “disinvolto” dei dati personali?
Difficile rispondere. Circolano voci in merito all’apertura di una sede di Cambridge Analytica a Roma poco prima delle elezioni italiane, progetto abortito in seguito allo scandalo che ha coinvolto la società britannica. Un partito italiano, non si sa quale, avrebbe richiesto i suoi servizi. È noto che la Lega volesse parlare con Steve Bannon (figura chiave dell’alt-right americana, fondamentale nell’elezione di Donald Trump, ndr) in quel periodo, incontro poi avvenuto in seguito.
La destra – più o meno estrema – sta vincendo la battaglia della comunicazione digital?
Si muovono meglio dei partiti tradizionali, che non sono riusciti a evolversi. Lo dimostra Bannon, e pure Salvini, che a 45 anni è un super millennial: ha vissuto il calcio balilla, la televisione, Space Invaders e le reti social.
Vedi analogie tra la strategia social di Donald Trump e quella di Salvini?
Salvini ha sempre guardato con attenzione a Trump. Entrambi fanno la cosa più semplice: trovare un nemico comune. E gli sta funzionando molto bene. Nel nuovo governo si sono suddivisi le responsabilità: al M5S è toccato il lavoro, con la forte macchina propagandistica gestita dalla Casaleggio Associati, alla Lega la sicurezza e l’orgoglio nazionale, gestiti da Morisi e amici.
Sta pagando, non c’è che dire.
La totale disinformazione e frotte di like su post propagandistici e falsi – per esempio l’annuncio della consegna di 12 motovedette alla Guardia costiera libica (a fine giugno, ndr) – portano a quello che si definisce vanity KPI: l’elettore rimane soddisfatto nel condividere post che hanno migliaia di like, e quindi affermano le loro convinzioni. Consiglio la lettura di The Thrill of Political Hating di Arthur Brooks.
Esiste una sorta di meme war all’italiana?
Le meme war non esistono. Ci possono essere contenuti in forma di meme per denigrare i competitor e inquinare i motori di ricerca. Ricordiamoci anni fa, quando su Google scrivevi il cognome “Berlusconi” e il motore di ricerca ti suggeriva “mafioso”: fu un esempio di manipolazione dell’algoritmo di Google. Lo stesso sta succedendo in questi giorni: se scrivete la parola “idiot” e fate “ricerca immagini”, compaiono solo foto di Trump.
Come è stata finanziata l’attività delle reti social della Lega?
La Lega voleva creare una fondazione solo per ricevere i soldi delle donazioni, al fine di poter tenere in piedi le reti social senza passare per i conti in rosso del partito. Il partito è gravato da debiti e scandali finanziari (a luglio il tribunale di Genova ha confermato la richiesta di confisca di 49 milioni di euro dalle casse del partito, ndr). Le leggi italiane lasciano ampio margine: permettono di ricevere micro- donazioni, senza doverle rendere pubbliche. È una forma completamente legale. In ogni caso, potresti chiederlo direttamente a Luca Morisi (Morisi non ha risposto ai tentativi di contatto da parte di Rolling Stone, ndr)
Hanno ricevuto finanziamenti dall’estero?
Recentemente l’Espresso ha raccontato che alcune donazioni al partito provengono da associazioni come Italia-Russia e Lombardia- Russia, vicine alla Lega. D’altra parte, sono stati i russi a inventare il concetto di hybrid war. Il generale Gerasimov ha teorizzato che le guerre moderne non si devono combattere con le armi, ma con la propaganda e l’hacking.
Un sistema come La Bestia alimenta la creazione di notizie false?
Non direi che ci sia un rapporto diretto tra le due cose, ma sicuramente c’è un rapporto tra La Bestia e il bias dei post che pubblicano. Come ha spiegato lo psicologo e premio Nobel Daniel Kahneman, di fronte a una notizia online la nostra mente si avvale di metodi di giudizio molto rapidi che, grazie alla soddisfazione che dà trovare conferma nei nostri pregiudizi, spesso porta a risposte sbagliate e illogiche, ossia biased.
Salvini lavora su questo bias?
Lo fa il suo team, e anche quello del M5S: amplificare notizie semi-veritiere, viralizzandole e facendole diventare cultura condivisa, che viene confermata sia dalla fonte considerata carismaticamente onesta e affidabile, sia dal numero di condivisioni che la rendono in quel modo difficilmente contestabile. Vai tu a convincere del contrario 18mila utenti che hanno condiviso un post di dubbia veridicità! Una delle figure chiave delle fake news della Lega è stato e forse ancora è il napoletano Marco Mignogna, che gestiva il sito di Noi con Salvini, oltre a una ventina di portali pro-Salvini, pro-M5S e pro-Putin (nel novembre 2017 si è occupato del caso il NYT, ndr).
Quanto di ciò che hai detto fin qui vale anche per il Movimento 5 Stelle?
Non c’è dubbio che dietro al M5S ci sia una buona azienda di marketing politico. La loro propaganda è più decentralizzata rispetto a quella della Lega, tutta controllata da Morisi. Creano piccole reti, appoggiandosi agli attivisti “grillini” e risparmiando così denaro. Non pagano per rendere virali i post di Grillo o di Di Battista. Anche se oggi, con il M5S al governo, la strategia è in parte cambiata.
Quanto influisce l’attività di trolling sul dibattito politico?
Dipende dal contesto politico e dal Paese, in alcuni casi può essere molto violenta. Per creare account su Twitter esiste un software acquistabile online, che ti permette di generarne mille in tre ore, ognuno con foto e nome distinto. Parliamo di account verificati con un numero di cellulare: c’è un servizio russo che, per 10 centesimi, te ne fornisce uno appositamente. Con 300 o 400 euro puoi crearti in un pomeriggio un migliaio di account Twitter verificati. A quel punto puoi avviare un tweet bombing, cambiando la percezione di una notizia. È semplice e costa poco.
Ci sono conferme sull’esistenza di una rete di troll leghisti?
Non è facile rispondere, perché ci sono diverse tipologie di reti troll, organiche o artificiali. A volte distinguere le due senza tool specializzati è quasi impossibile. Per esempio, le reti di troll formate da persone reali spesso si auto-organizzano, sapendo benissimo che un utente singolo può avere due o più account social sullo stesso network. È normale vedere un utente pro-Lega o pro-M5S gestire anche cinque account con nomi diversi: cento persone in un gruppo segreto di Facebook o su un canale Telegram, con cinque account ciascuno, fanno 500 troll pronti ad attaccare, e scoraggiare utenti standard a un confronto politico.
Esistono quindi reti costruite ad hoc?
Una di queste botnet è stata smantellata da un gruppo di hacker italiani sei mesi fa: era collegata a una società romana che gestiva una rete di 3mila account Twitter, collegati a un migliaio di account Facebook. Non mi stupirei se un team gestito da Morisi avesse automatizzato e controllasse qualche centinaio o migliaio di account. Qualcosa di simile era già nelle loro mani, con un sistema di tweet automatici su diversi account (documentato da diverse fonti giornalistiche lo scorso gennaio, ndr). L’unica pecca del loro team è la sicurezza informatica, come si è potuto notare dal leak delle informazioni del loro server, avvenuto all’inizio di quest’anno.
Cosa sappiamo sul “gonfiamento” dei numeri social di Salvini?
Abbiamo notato alcune discrepanze, ma in questo momento di grande successo mediatico di Salvini non sono più rilevanti. Abbiamo scoperto alcune botnet di Twitter nate contemporaneamente che, dopo pochi giorni e nello stesso momento, hanno seguito tutte l’account ufficiale di Salvini. La relazione con il suo account era il fatto che supportavano account di estrema destra in Europa, quindi attribuibili a persone vicine a Voice of Europe e gruppi simili, legati a Steve Bannon, come #Altright o #DefendEurope. La pratica di creare fake account è comune: solo pochi giorni fa Twitter ne ha cancellati alcuni milioni.
C’è un modo per riparare simili storture?
C’è poco da fare. In seguito allo scandalo Cambridge Analytica, Facebook ha colpito tutti, impedendo ai ricercatori di studiare questi fenomeni. Le cose non sono cambiate, anzi. Anche a seguito dell’adozione del GDPR (il regolamento sulla protezione dei dati personali, ndr) nei prossimi anni vedremo come si raffineranno le campagne politiche online: sarebbe utile avere leggi che impongano maggior trasparenza su come funzionano le reti social e, naturalmente, maggiore tutela per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i propri big data.



