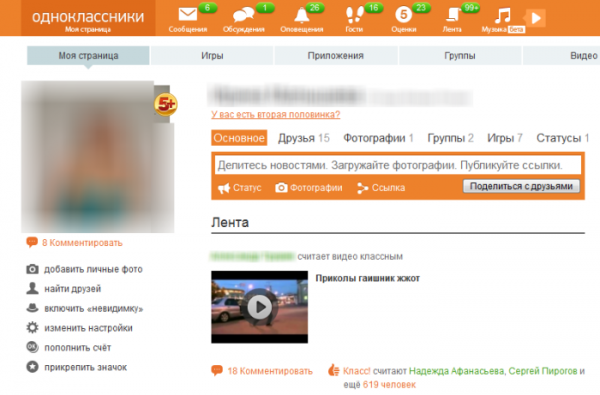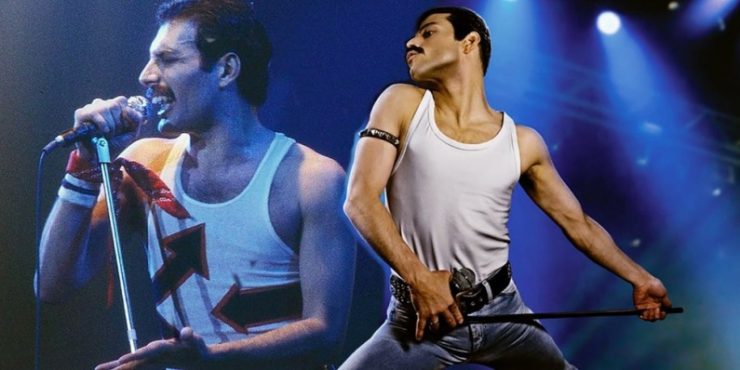Salvini usa i bot per dominare su Twitter?

La campagna #SalviniNonMollare contro il processo al ministro ha fatto segnare numeri importanti anche grazie al contributo di account automatizzati. Che ruolo hanno avuto, e come funzionano?
Quando il gip del tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, tra il 24 e il 25 gennaio ha guadagnato trazione su Twitter la campagna #SalviniNonMollare. Questo hashtag ha generato un numero impressionante di retweet: la loro somma è di 25 milioni, mentre i tweet nuovi sono stati 90mila nel periodo analizzato, cioé tra la mattina del 24 gennaio e il primo pomeriggio del 25. Chiaramente, la campagna è finita nei trend mondiali: ma, forse, è stata dopata dall’uso di bot e di profili automatizzati.
Il grafico mostra chiaramente quanto questi profili abbiano contribuito a rilanciare i messaggi della campagna. Andando a calcolare quanto i tweet della campagna sono stati ritwittati in media per ogni ora, e dividendo tra presunti bot e utenti umani, scopriamo come i bot abbiano avuto un ruolo molto importante nel rilanciare i messaggi salviniani.
Si può notare come i bot siano stati il rumore di fondo costante di #SalviniNonMollare, sostenendone la portata.
Ecco perché, nonostante un apporto in termini strettamente assoluti piuttosto basso, questo tipo di profili è stato molto importante per il discorso salviniano.
Come si scova un bot? Questa guida del laboratorio di analisi forense del Consiglio atlantico offre un prontuario molto attuale. Un primo criterio è vedere se nel profilo ha delle cifre nel nome: molti account del genere sono costituiti da un codice alfanumerico costituito da un nome proprio di persona seguito da 8-9 cifre (per esempio: Francesco25971258). Questi nickname sono il tipo di nome che ci si aspetterebbe da una macchina: una stringa di testo più un codice numerico, progressivo o no ha poca importanza.
Un altro criterio è vedere quando questo profilo è stato creato. Se il profilo in questione ha delle caratteristiche in linea con quanto detto fin qui, di norma è stato aperto pochi giorni o poche ore prima della conversazione a cui ha preso parte; in questo caso, è probabile che siamo davanti a un bot. Infine, se un utente ha zero o pochi seguaci ma ha dei comportamenti anomali, stesso discorso, probabilmente è un bot.
A cosa servono gli account automatizzati? A fare volume, ad attirare l’attenzione su una conversazione online, facendola entrare nei trend. In questo modo, il leader politico che lancia un hashag può dire di avere tanti seguaci attirando l’attenzione di media e utenti casuali, in modo da estendere la propria platea. Che una manovra del genere fosse nell’aria lo dimostra lo storico della nascita dei profili che hanno partecipato a #SalviniNonMollare.
Dei profili che hanno partecipato a #SalviniNonMollare, molti sono stati creati a gennaio 2019. Di questi, molti assomigliano a bot, soprattutto tra quelli creati tra dicembre e gennaio. Un dettaglio che rende molto sospetti questi account è proprio lo scarsissimo numero di seguaci. Infatti, come mostra la tabella sotto all’istogramma, molti di questi profili ne hanno pochissimi.
Che un profilo Twitter vecchio abbia più follower di uno nato recentemente è plausibile. Ma che ci siano probabili bot con zero follower e che risalgono al 2017 fa ipotizzare che ci sia qualcuno (o qualcosa) che crea utenti con il medesimo modus operandi. Ci sono molti indizi in questo senso.
Andando a cercare i nomi dei profili che costituiscono il grafico, notiamo come ci siano account che hanno un nome identico ma che sono stati creati a poche ore di distanza. Particolarmente chiaro è il caso una certa Paola, iscritta su Twitter a gennaio 2019, ma con due identità diverse create (al secondo) a due minuti di distanza. Un caso? Poco plausibile.
La prova che ci siano stati dei meccanismi automatizzati a portare avanti una parte rilevante di questa campagna ci viene dall’analisi di quante volteabbiano twittato (retweet inclusi) i profili all’ora. Quello che emerge è un quadro sorprendente ma non del tutto contraddittorio con quanto detto finora. Che su Twitter operino dei bot è cosa nota, però che certi account vadano in automatico è un altro paio di maniche.
Il grafico mostra quanti profili hanno postato almeno 60 volte in un’ora durante il periodo preso in esame. L’idea è che, per scrivere un tweet, ci voglia un minuto (un limite arbitrario ma verosimile) e che, quindi, se un utente twitta con questa frequenza c’è qualcosa che non va. Guardando con superficialità al modo in cui si sono comportati i profili ufficiali della Legaverrebbe da dire che i veri bot sono gli account istituzionali del Carroccio, che per quasi tutto il 24 gennaio hanno postato più di 200 volte in un’ora. Ma ovviamente in questo caso si può supporre una programmazione dei tweet.
Dal grafico emerge anche un altro elemento: i presunti bot mostrano una fiammata di attività condensata in poco tempo, poi tendono a sparire. Infatti, nel grafico precedente ci sono molti profili con le caratteristiche del bot per come descritto fin qua: Tizzy44196287 o AnnaMar3074405, ad esempio. Profili del genere compaiono nella conversazione e scompaiono l’ora successiva. Tra questi, uno dei più interessanti ai fini di quest’analisi è Barbara34041885.
Questo profilo è nato il 7 di gennaio, eppure, quando si tentano di scaricare i suoi tweet dall’Api di Twitter, quello che otteniamo è il limite massimo concesso dal social network quando si cerca di ottenere la timeline di un profilo, ovvero 3200 post. Ma questa non è l’unica anomalia.
Come si vede, Barbara è un utente molto attivo. E ha poche centinaia di follower. Per quanto questa caratteristica dovrebbe tagliarla fuori dalla nostra caccia al bot, è il modo in cui twitta a farci propendere che qualcosa non vada.
La giornata di Barbara inizia tra le 4 e le 5 del mattino e finisce intorno alle 23. I suoi tweet non sono regolari, eppure sembra che agisca con metodo. Il picco di attività si è registrato in concomitanza con #SalviniNonMollare, dopo di che, è tornata a ritmi più bassi (umani?) scendendo costantemente sotto i 60 tweet all’ora.
Da dove provengano, di chi siano, quali fini e strategie perseguano questi bot (o presunti tali), non è dato saperlo. Infatti, molti di questi si nascondono dietro a località plausibili. Oppure, quando si registrano, non danno questa informazione.
Twitter, ciclicamente, organizza delle vere e proprie retate contro questi profili che, però, ricompaiono regolarmente. Tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto nel mondo delle campagne Twitter di questo tipo. I media non hanno quasi considerato #SalviniNonMollare e l’hashtag è sparito dalle tendenze. Quale sarà il ruolo dei bot nella campagna elettorale per le europee, lo scopriremo nei prossimi mesi.