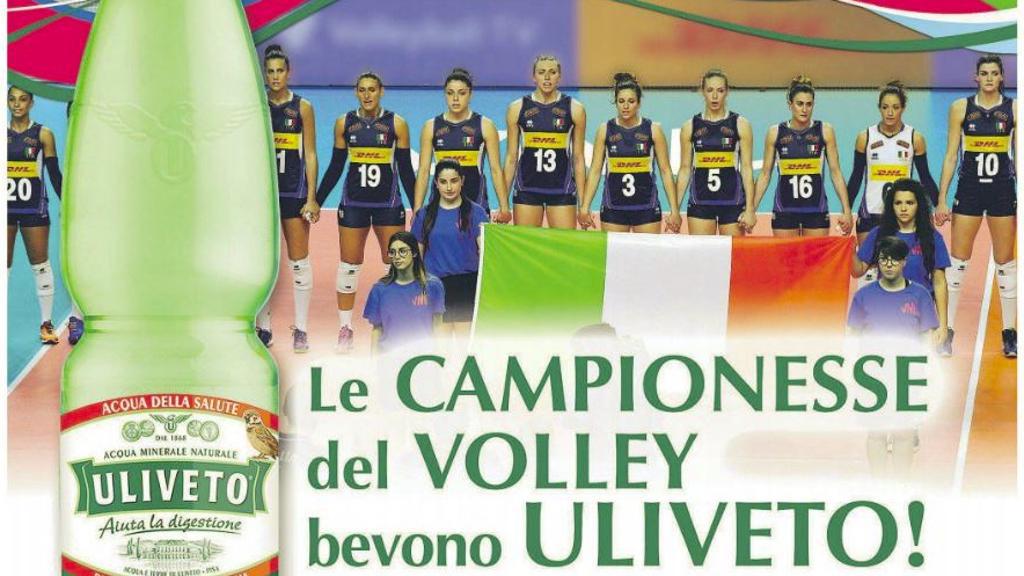Il costo delle comunicazioni scadenti

Non riconoscendo l’importanza delle buone comunicazioni, i leader possono incappare in costi elevati per le proprie organizzazioni.
Nel nuovo film, “Horrible Bosses” sicuramente i personaggi negativi sono colpevoli di peccati ben peggiori della mera comunicazione qualitativamente scadente, ma – dopo aver visto il trailer, questa settimana – mi ha fatto riflettere (ancora) sulle implicazioni e sui costi associati a una leadership inefficace. “Horrible Bosses” è pieno di scenari irrealistici e insinuazioni ridicole su come certi dirigenti si comportino oggi. La realtà, però, non è una questione su cui ridere molto. Per mia diretta esperienza, alcuni errori non intenzionali possono essere i più cari per le aziende.
La maggior parte dei leader oggi non inizierebbe mai la propria giornata pensando. “Oggi ignorerò di proposito i miei impiegati.” Detto questo, non riconoscendo l’importanza delle buone comunicazioni, i leader possono incorrere in costi significativi per le proprie organizzazioni. Ho visto di persona quanti danni possano arrecare situazioni come comunicazione insufficiente, problemi di comunicazione o nessuna comunicazione.
Come al solito, i dati ci mostrano quanto sia pesante il costo di una cattiva comunicazione:
- 37 miliardi di Dollari: costo totale stimato delle incomprensioni dei dipendenti (includse azioni o errori di omissione da parte di impiegati che hanno frainteso o sono stati male informati sulle politiche aziendali, sui processi aziendali, sulla propria funzione sul posto di lavoro, o una combinazione dei tre fattori) in 400aziende di almeno 100.000 dipendenti, sondate negli Stati Uniti e nel Regno Unito (il costo medio per azienda è 62,4 milioni di dollari l’anno);
- 041 Dollari, è il costo per lavoratore – anno dovuto a perdita di produttività derivante da barriere nella comunicazione.
Al contrario:
- Le aziende che hanno come comunicatori altamente efficaci hanno, avuto il 47% in più di rendimento complessivo per gli azionisti negli ultimi cinque anni rispetto ad aziende i cui leader sono i comunicatori meno efficaci;
- Best Buy ha rilevato che punteggi più elevati di coinvolgimento dei dipendenti hanno portato a una miglior prestazione dei relativi negozi. La società ha scoperto che per ogni punto percentuale di aumentato del coinvolgimento dei dipendenti, i singoli negozi hanno visto un aumento del reddito operativo di 000 Dollari all’anno.
Questi pochi fatti sono la punta dell’iceberg per ampiezza e profondità di una ricerca che dimostra un ritorno economico tangibile per quelle aziende che comunicano bene con i propri dipendenti e per i problemi che si presentano quando non lo fanno.
Sfortunatamente, le cattive capacità comunicative sono il risultato di una decisione consapevole dei leader di non migliorare. “Non ho tempo per comunicare”, è un mito comune che sento, insieme al pensiero che “la gente non ointraprenderà azioni se non parliamo loro di cose concrete”.
I leader comunicano con o senza intenzione, quindi il mio punto di vista è: potreste essere bravi anche nella comunicazione.
Migliorare la comunicazione implica molto più che diffondere il messaggio correttamente in modo che sia ascoltato (anche se questo da solo può già essere una sfida); significa assicurarsi che il messaggio risuoni e sia compreso dagli ascoltatori in modo tale da spingerli all’azione. È un duro lavoro, ma ne vale la pena. Tutto ciò che un leader ha bisogno di ottenere compiuto oggi è fatto attraverso le persone.
Quindi cosa possono fare i leader per essere migliori comunicatori?
- Smetti di inventare scuse. Impegnati a migliorare, per te, il tuo team e la tua azienda. Assegna il tempo, l’energia e le risorse necessarie per far arrivare il tuo messaggio nel contesto giusto e con lo scopo di coinvolgere i tuoi dipendenti.
- Prendi uno specchio. Rifletti su ciò che gli altri vedono e leggono ogni volta che interagiscono con te. Capisci dove sei, non dove pensi di essere. Se possibile, ottieni dati su come stai procedendo, con una sondaggi ed analisi a 360°.
- Sii concentrato sul pubblico. Sapere da dove viene tuo pubblico aiuta i leader a posizionare i messaggi nel modo giusto in modo che siano significativi e pertinenti. I leader devono anche sfruttare i canali e i mezzi di comunicazione utilizzati dal loro pubblico per assicurarsi che le proprie comunicazioni arrivino effettivamente ai destinatari.
- Avere un piano ed essere propositivo. Creare una strategia di comunicazione e tradurla in un piano orientato all’azione. Non aspettarti risultati immediati. Il “Fallo e basta” non funziona nella comunicazione. I leader devono iniziare con una valutazione chiara dei risultati aziendali che vogliono raggiungere, e poi avere un cronoprogramma nel quale disporre le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi.
- Ascolta e interagisci. Chiedere suggerimenti ai dipendenti e agire sulla base delle suggestioni ricevute, dire grazie, articolare le aspettative, fornire informazioni significative e non far girare messaggi a vuoto. Questi sono i modi in cui dimostri di apprezzare i tuoi dipendenti.
- Sii persistente. Ricorda, una buona comunicazione è un’abilità e, come tutte le abilità, ci vuole pratica e analisi dei riscontri step by step per migliorare.
Garantire comunicazioni coerenti e strategiche ti consentirà di allineare i tuoi dipendenti e il loro ruolo, con le tue aspettative e il quadro generale degli obiettivi di business. La posta in gioco sono soldi veri, Il vero denaro è in gioco e solo degli “Horrible Bosses” non se ne prenderebbero cura.
L’autore: David Grossman, ABC, APR, Fellow PRSA, è autore di You Can not Not Communicate e del seguito, You Can Not Not Communicate 2 . È fondatore e CEO di The Grossman Group , una società di consulenza di comunicazione con sede a Chicago.