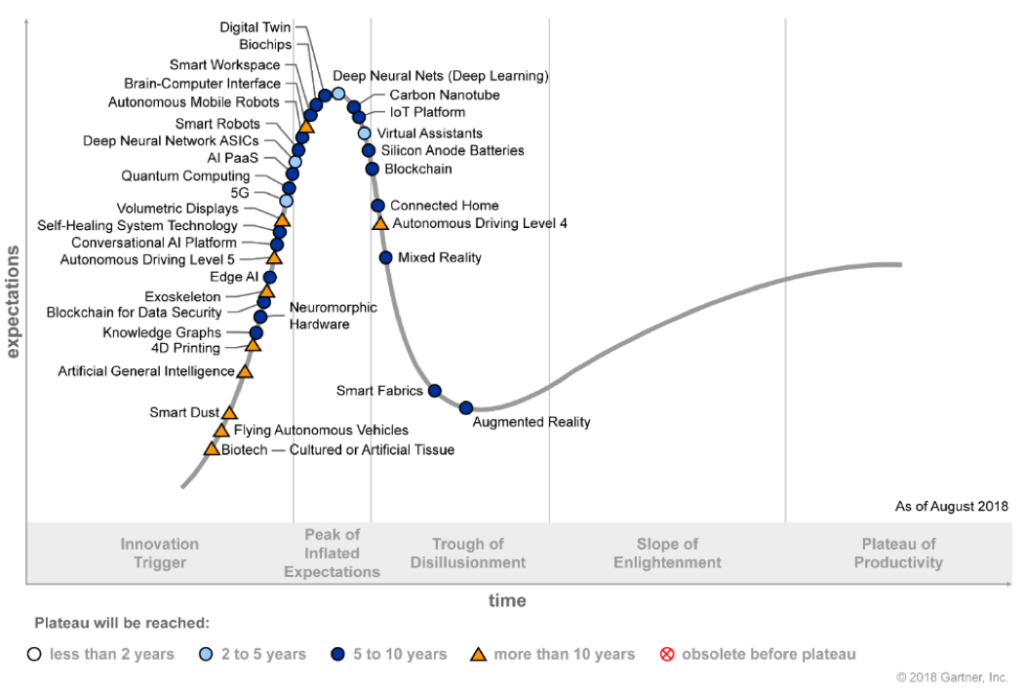La Blockchain, in italiano “catena di blocchi”, è un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche – dati, memoria, Cpu, banda – per rendere disponibile alla comunità di utenti un database virtuale, generalmente di tipo pubblico, ma ci sono anche esempi di implementazioni private, e in cui ogni partecipante ha una copia dei dati.
Alla base del funzionamento della Blockchain c’è la sicurezza poiché il database condiviso è centralizzato e criptato; in questo modo viene garantita la sicurezza e la conservazione delle informazioni in esso contenute, inoltre, per effettuare delle modifiche è necessario il consenso di tutti e comunque vengono registrate tutte le versioni precedenti.
L’utilizzo della tecnologia Blockchain è ancora molto nebuloso poiché si può spaziare dall’impiego all’interno del mondo criptovalute, fino ad arrivare ai settori più disparati come banche, trasporti, sanità, finanza, sicurezza, istruzione, assicurazioni. Questi che abbiamo appena elencato sono alcuni degli ambiti che, secondo gli esperti, saranno prima o poi contaminati dalla Blockchain.
Blockchain è anche pronta a sbarre all’Università di Pisa, primo ateneo in Italia e tra i primi in Europa ad adottare il registro criptato digitale in cui archiviare in ordine cronologico e pubblico tutte le informazioni legate alla carriera universitaria, così da porre fine ai millantatori di titoli di studio.
Ma ora ai diversi ambiti alternativi di applicazione della tecnologia Blockchain se ne aggiunge un altro: il suo utilizzo nella progettazione di una Smart City.
Le Smart City combinano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel tentativo di migliorare i servizi come i trasporti attraverso la razionalizzazione che produce una riduzione dei costi. Un esempio semplice in tal senso è l’impiego di sensori per la segnalazione di parcheggi liberi, oppure i sistemi di illuminazione che utilizzano i sensori per rilevare l’attività umana nella zona e a seconda dell’afflusso aumentano o diminuiscono l’illuminazione.
L’Internet of Things e la Blockchain rappresentano un ulteriore step per lo sviluppo delle Smart City. L’applicazione dell’Internet of Things all’interno di un ecosistema complesso come quello urbano porta con sé una serie di problematiche.
Se da un parte l’IoT può essere sfruttata per una gestione intelligente ed interconnessa del flusso del traffico, la Blockchain entra in gioco perché in questo contesto è fondamentale mantenere la sicure dati.
Nell’esempio che prenderemo in rassegna, ossia un’avanzata smartcity di Tokyo, c’è tutto questo ma anche molto altro. Si tratta di un esperimento implementato all’interno del distretto di Daimaruyu che, in un’area di 120 ettari nel quale il 30% degli edifici appartiene a Mitsubishi, riunisce tre quartieri di Tokyo compresi fra la Tokyo Station e il Palazzo imperiale.
Ci sono diversi stakeholder e aziende che hanno preso parte al progetto. Fujitsu ha creato l’infrastruttura tecnologica, ossia quella che consentirà alle aziende di condividere i propri dati senza perderne il controllo. Alla base di tutto c’è sempre la condivisione di dati in modo sicuro e strutturato per creare valore, rispettando sicurezza, privacy e relazioni tra le aziende che vi partecipano.
La tecnologia impiegata, di tipo open source, appositamente progettata sotto la Linux Foundation per un utilizzo in contesto aziendale, è una Blockchain Hyperledger Fabric che sfrutta la “tecnologia contenitore” per ospitare contratti smart chiamati “chaincode” che comprendono la logica applicazione del sistema. In Hyperledger Fabric le regole definite per la specifica Blockchain stabiliscono chi può validare l’ingresso di membri nella Blockchain, autorizzare e verificare ogni transazione.
Fujitsu ha progettato l’infrastruttura software Virtuora DX attraverso la quale permette di condividere data e smart contracts. Virtuora DX è un servizio cloud che consente alle aziende di portare visibilità e valore nei dati in loro possesso, condividerli, e accelerare la co-creazione di valore. Questo tipo di tecnologia è necessaria perché i dati possono essere sfruttati in modo sicuro per creare innovazione senza però che essi escano dal perimetro aziendale.
All’interno di un’area come quella di Daymaruyu, un distretto ad alta densità economica dove sono presenti 106 grattacieli – 4.300 uffici -, 280mila persone impiegate, 40mila ristoranti, 90mila negozi, 13 stazioni ferroviarie e metro, 28 linee, hanno la loro sede principale 16 delle più grandi aziende al mondo.
In quest’area, che non ha nulla da invidiare alla città rappresentata nel visionario film Minoriry Report, l’infrastruttura tecnologica consente di condividere le informazioni di tipo economico che provengono dalla gestione dei palazzi di proprietà di Mitsubishi, dai sensori IoT raccolti da aziende di trasporti – è presente anche un servizio di bus senza conducente -, dai negozi relativamente all’andamento delle vendite e dalla disponibilità dei beni, dal flusso di dati provenienti dagli hotel sulle camere disponibili, oppure i tavoli liberi all’interno dei ristoranti.
L’aggregazione di questi dati a diversi livelli – si può anche conoscere l’andamento dei prezzi degli immobili al metro quadro, oppure quante persone sono presenti all’interno di un locale ma anche sapere il valore e la quantità di ogni transizione effettuata – potrà quindi essere sfruttata dall’azienda che si collega, previa autorizzazione, per progettare un determinato servizio oppure per la sua attività commerciale.
L’esempio del distretto di Daymaruyu conferma l’ascesa delle Smart City che ormai sono diventate un obiettivo principale per molti paesi.
Escludendo il Giappone, secondo i dati diffusi dall’IDC, i paesi che compongono l’area Asia-Pacifico spenderanno nel 2018 in progetti di città intelligenti 28,3 miliardi di dollari, raggiungendo i 45,3 miliardi nel 2021. In tutto questo la Blockchain ha rapidamente guadagnato consensi e può essere considerata una parte integrante del successo delle Smart City.
Questa tecnologia può essere utilizzata anche per assegnare un’identità digitale verificata ad ogni cittadinocosì da consentirgli di accedere ad un sistema interconnesso. Tutto questo si traduce nella fruizione di un’ampia gamma di servizi governativi, professionali e privati – come la richiesta di prestiti bancari, la gestione della proprietà, il trasporto pubblico, lo shopping online o il pagamento delle tasse -, il tutto con estrema facilità e velocità.