Social media e sanità
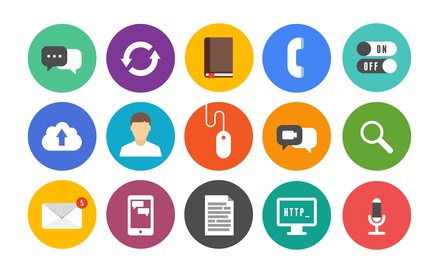
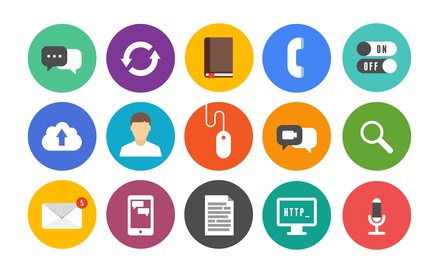

Il video-appello in tv con amplessi e baci appassionati: “Fatelo ovunque anche senza Mondiali!”
Ricordate lo slogan “Chicco dove c’è un bambino”? Beh adesso, tenetevi forte perché sono migliaia, milioni, trilioni. L’azienda di articoli per l’infanzia ha lanciato una nuova pubblicità tv in onda da qualche giorno inneggiando al baby boom. Chicco va ai Mondiali di calcio e vuole segnare tanti gol. Lo spot si propone come un inno alla vita, peccato che la vita non sia uno spot.
La premessa è la seguente: “Non sarà il 1982 o il 2006 ma anche quest’anno le notti possono essere magiche”. Sì, perché l’Italia è fuori, ma gli uomini lo mettano dentro. Davanti alle facce degli italiani affranti per il flop della Nazionale, una voce fuori campo con tono enfatico ricorda: “Per la prima volta dopo 60 anni l’Italia non gioca il Mondiale. Una tragedia”. Perché? Perché “ogni urlo di allegria, ogni gesto di esultanza, ogni Mondiale vinto finisce sempre con il baby boom. Un’esplosione dell’indice naturale di natalità, una pioggia di neonati che ci ha allagato di ottimismo facendo dell’Italia una nazione straordinaria”. Così le immagini di festa sfumano in un uomo che guarda con cupidigia la sua donna e le salta addosso. E via con l’Italia produttiva e ottimista del dopoguerra. Con tanto di bianco e nero per rievocare i bei tempi che furono. Viene anche un po’ da sorridere quando lo spot mostra donne e uomini soli, tristi e sconsolati e la voce fuori campo sale d’intensità e pathos sottolineando che oggi la situazione è diversa.
Qual è la soluzione a tanta depressione? Ma semplice per dindirindina! “Facciamo un altro baby boom! Abbiamo bisogno di migliaia, milioni, trilioni di bambini che ci aiuteranno a crescere portando l’Italia dove è giusto che sia” (Che significa ‘dove è giusto che sia’? A uno stage non retribuito? A “cercasi 20enne con esperienza nel settore di 5 anni?” A 500 euro mensili?).
Sempre più coinvolto nell’orgasmico spot il narratore esorta a “farlo per l’Italia, facciamolo tutti, l’uno con l’altro, uniamoci e moltiplichiamoci all’infinito”. L’invito che sa di ordine, di nazionalistica chiamata alle armi, diventa sempre più retorico: “Facciamolo per amore o semplicemente per voglia di farlo. Facciamolo dovunque, ovunque, e comunque sia. Facciamolo per l’Italia perché in questo Mondiale, i gol li segniamo noi”. E si vedono uomo e donna fanno sesso in casa, in ufficio, dal barbiere, in un parcheggio, dentro la macchinetta della foto tessera (c’è pure il souvenir, nda). Così impostata, sembra che alla Chicco non frega niente se siete innamorati, se avete un progetto di vita in comune, se avete la disponibilità per mantenere il “gol mondiale” (ma si può paragonare un figlio a un gol?!) dalla culla ai 20 anni sperando che non sia un bamboccione. C’è da riempire seggioloni e vendere biberon. Quindi accoppiatevi come conigli ovunque voi siate, tanto poi passa Pantalone a pagare. Se invece siete coppie omosessuali, vi dovete arrangiare. A voi non spetta neppure ogni 4 anni.
Lo spot è una rivisitazione in chiave commerciale della celeberrima frase pronunciata da John Fitzegerald Kennedy il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca nel 1961: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese”. Nel caso della Chicco, di patriottico c’è al massimo la stinta bandiera tricolore sulla faccia dei tifosi.
Lo spot ha spaccato i social: chi applaude all’iniziativa, chi ricorda all’azienda l’autogol (per restare in tema) avendo spostato la produzione all’estero (“dite, facciamo crescere l’Italia ma la produzione abbigliamento Chicco dov’è? All’estero!!!”), chi ricorda la storia (“Questo spot sembra uscito dal ventennio”) e chi risponde in modo pragmatico (“Se potessi, farei 2, 3, 10 figli, ma non credo che l’azienda me li crescerebbe o mi darebbe una mano a livello economico. È facile, troppo facile dire “fate figli”, poi come li mantengo?”, comica la risposta della Chicco: “crediamo che i bambini riescano a portare tanta speranza, anche nei momenti più difficili”. La signora darà da mangiare ai pargoli pansperanza e latte di sorrisi). Molti hanno criticato la superficialità con cui è stata derubricata ad atto sessuale l’importante decisione di mettere al mondo un bambino che invece dovrebbe rappresentare la sublimazione dell’amore di coppia. In qualunque modo sia formata. In fin dei conti un figlio non assomiglia a un pacchetto di patatine da mangiare davanti a una partita.

Da poche centinaia di utenti fino ai due miliardi di oggi: l’espansione del social network sembra non avere mai fine.
ochi giorni dopo la sua nascita, Facebook aveva già alcune centinaia di iscritti. Lo scorso giugno, il social network di Mark Zuckerberg ha raggiunto quota due miliardi di utenti attivi al mese. Un risultato raddoppiato nel giro di cinque anni dopo aver solcato, nel 2012, il traguardo di un miliardo. Si tratta di una crescita tanto veloce quanto, soprattutto, costante nel tempo. D’altra parte, come scrive Harry McCracken in un lungo articolo pubblicato su Fast Company, il colosso di Menlo Park si è sempre focalizzato su un unico obiettivo: come convincere sempre più persone a iscriversi al servizio.
Fin dall’inizio, lo sviluppo è stato guidato e indirizzato da un team composto da esperti di web marketing e analisti dei dati. Insomma, l’approccio è il seguente: capire e comprendere quali sono i bisogni degli utenti; se è necessario, anche anticiparli. Il Growth Team è nato nel 2007 e ha supervisionato e indirizzato tutte le innovazioni e i cambiamenti del social network. Dal lancio di Facebook Live al servizio Safety Check, passando per i droni a energia solare in grado di portare internet nelle parti più remote del mondo; fino al pulsante “donate” per le organizzazioni senza scopo di lucro o le campagne di crowdfunding. A guidare il loro operato, l’analisi dei comportamenti delle persone e delle loro abitudini. Informazioni che permettono agli analisti di creare modelli statistici in grado di prevedere i bisogni futuri degli utenti. “La nostra filosofia è quella di porci sempre un obiettivo in più. Quando nel 2007 avevamo toccato quota 70 milioni, ci siamo detti: non ci basta. E così, poco dopo, tutti hanno iniziato a immaginare come poter arrivare a 100 milioni”, ha detto alla stessa Fast Company Alex Schultz, manager del Growth Team fino al 2014.

Il primo grande fattore di sviluppo di Facebook, ovviamente, è stata la lingua. Per potersi espandere, oltre all’inglese, il social network si è reso il prima possibile disponibile anche in francese, spagnolo o tedesco. Ma non solo, anche in somalo o afrikaans. Senza dimenticare dialetti come il sardo o la lingua berbera Tamazight. E se è impossibile rendere alla perfezione le centinaia di idiomi disponibili, sono proprio gli stessi utenti a offrire traduzioni, ad esempio di concetti come ‘tag’ o ‘poke’.
Ma è l’approdo sullo smartphone ad aver favorito l’espansione globale del social network. Secondo gli ultimi dati, relativi a dicembre 2016, sono più di un miliardo gli utenti attivi ogni giorno che accedono da un dispositivo mobile. Una crescita possibile solo se non si rinuncia a inseguire i potenziali utenti, anche se questi vivono in zone povere in cui la connessione è di scarsa qualità. Ed è per questo motivo che, nel 2011, Facebook ha acquisito Snaptu: una startup israeliana che aveva creato una versione leggera in grado di funzionare anche con telefoni meno potenti. Così è nato Facebook Lite: fruibile anche nelle zone poco coperte da internet. Solo nello scorso febbraio, il social network ha aggiunto 200 milioni di nuovi iscritti provenienti da paesi come il Vietnam, il Bangladesh o la Nigeria.

Allo stesso tempo, coinvolgere nuovi utenti significa anche disegnare Facebook in modo che possa essere utilizzato intuitivamente da tutti coloro che si iscrivono per la prima volta con uno smartphone. Per questo motivo, negli anni sono cambiate anche piccole cose, più importanti di quanto potrebbero sembrare: nella schermata di login, al posto dello sfondo in blu, ci sono oggi immagini di persone che condividono foto o video; la frase “iscriviti a Facebook” è stata sostituita con “crea un nuovo account”, permettendo inoltre di sostituire la password senza prima scrivere quella errata.
“Nel nostro lavoro teniamo conto di diversi aspetti: se gli utenti possiedono una casella di posta elettronica, se sanno cosa sia, se conoscono il wifi e se sanno che possono trovarlo in alcuni punti e in altri no”, spiega a Fast Company, il responsabile del settore Design Luke Woods. E siccome, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in una famiglia è spesso presente un solo dispositivo per più persone, è diventato possibile passare da un account all’altro, senza ripetere l’accesso al proprio profilo.
L’analisi dei dati si sposa con quella dei bisogni reali degli utenti; per esempio quando si trovano in situazioni di pericolo. Safety Check è un servizio che, in caso di attentato terroristico o catastrofe naturale, permette di comunicare ad amici e parenti che si è sani e salvi. E anche questo prodotto è stato pensato e sviluppato in modo da poter convincere sempre più persone a iscriversi a Facebook. “Vogliamo avere un impatto nel mondo e per averlo dobbiamo pensare a servizi che funzionino”, afferma Naomi Gleit, la vice presidente della divisione dedicata al sociale.
Molto probabilmente, il futuro prossimo di Facebook potrebbe essere scritto nella realtà aumentata. Lo ha spiegato lo stesso Mark Zuckerberg, in un’intervista rilasciata a Recode lo scorso aprile: “Gli oggetti di cui abbiamo bisogno non devono necessariamente essere materiali. Vuoi giocare a un gioco da tavolo? Ti basta muovere le dita ed ecco il gioco. Vuoi guardare la tv? Non hai bisogno dello schermo, ma ti basta acquistare un’app da un dollaro per per poterla vedere”. Il colosso di Palo Alto non ha ancora nei suoi piani la creazione di un modello di occhiali a realtà aumentata, ma sta aprendo la propria piattaforma agli sviluppatori in modo che possano creare nuove funzionalità per gli utenti. Il tutto con l’obiettivo di continuare a crescere, oggi, ma soprattutto domani.

Di solito l’App Store di Apple viene considerato una fonte sicura per le app per i dispositivi macOS, ma pochi giorni fa è emerso che Calendar 2di Qbix, un’app di gestione agende molto popolare, usava i computer degli utenti per fare cryptomining, ossia generare criptovalute (specificamente Monero) a favore dell’azienda senza il consenso degli utenti.

IL CHURCH INVESTORS GROUP SI PREPARA ALLE ASSEMBLEE 2018
Retribuzione dirigenti, gender diversity, lotta al climate change. Il Cig ha posto tre paletti per mantenere l’appoggio alle aziende Uk. Il gruppo, con 17 miliardi di asset in gestione, non voterà i dirigenti di imprese che non compiono progressi nei tre settori
La chiesa inglese ha preso un posizione forte sulla presenza femminile nei board aziendali. Una questione etica, certo, che però il Church Investors Group(Cig) mira a risolvere con il potere del suo patrimonio finanziario. In realtà, il discorso affrontato dal Gruppo, che detiene un totale di asset pari a circa 17 miliardi di sterline, è più ampio e riguarda l’appoggio ai dirigenti aziendali nella prossima stagione di voto a fronte di tre temi: la retribuzione dei dirigenti; le azioni poste in essere nella lotta al climate change; e, come detto, la gender diversity in posizioni apicali.
Proprio quest’ultimo punto ha attirato l’attenzione di diversi commentatori perché si tratterebbe di uno scacco a diverse società quotate nei principali listini europei a partire dal Ftse350. Il Cig, infatti, ha minacciato un voto contrario alla rielezione dei presidenti delle commissioni nei casi in cui il board non sia composto per almeno un terzo da donne. Un voto apertamente contrario a tutto il consiglio direttivo andrà a quelle aziende in cui le dirigenti di sesso femminile sono meno del 25 per cento. E qui, secondo gli ultimi dati pubblicati lo scorso novembre dalla rivista Hampton-Alexander, che mira ad aumentare il numero di donne nei consigli di amministrazione Ftse, c’erano 301 imprese nel Ftse350 alla fine di giugno 2017, in cui la proporzione di donne nel consiglio di amministrazione era inferiore al 33 per cento. Un totale di 170 imprese avrebbe fallito il test della Cig, avendo una rappresentanza femminile in cda inferiore al 25%; tra queste la società energetica Bp, Barclays, il colosso assicurativo Prudential e quello alimentare Just Eat.
Il Financial Times, poi, sull’onda della discussione generata dal Cig, ha citato anche i dati del 30%Club, l’associazione nata nel 2010 che punta a una gender diversity nei board di almeno il 30% entro il 2020. Ebbene, sono 62 e 42 le società che hanno superato la soglia del 30% nel Ftse 250 e nel Ftse 100. Analizzando, invece, i dati resi disponibili dalla società di ricerca BoardEX, a ottobre 2017 erano soltano 27 le società del Ftse100 che rientrano nella categoria del 33 per cento.
Sul fronte delle remunerazioni dei dirigenti, il Gruppo di investitori della chiesa inglese voterà contro i direttivi in cui non ci sarà disclosure sul rapporto tra i redditi più alti e quelli più bassi all’interno della società, e quelli in cui gli amministratori delegati percepiscono pensioni “eccessive”. Se la pensione è superiore al 30% dello stipendio, «ci asterremo dal voto», ha detto il gruppo. Il cambiamento climatico è la terza area chiave: si voterà contro la rielezione della presidenza se una società sta compiendo pochi progressi nella transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio.
La stagione delle riunioni annuali del 2018 inizierà in primavera, e lo scorso anno il Cig non ha sostenuto il 60% delle relazioni sulle retribuzioni presentate dalle società Ftse350. «Le migliori aziende contribuiscono al bene comune attraverso i loro prodotti e servizi e il modo in cui trattano i loro dipendenti», ha affermato Edward Carter, presidente del Cig. «I loro dirigenti capiscono che se non fanno qualcosa sull’equità e sui rischi che questo comporta, sono essi stessi parte del problema e rischiano di perdere la fiducia degli investitori e, in definitiva, la loro licenza di operare».