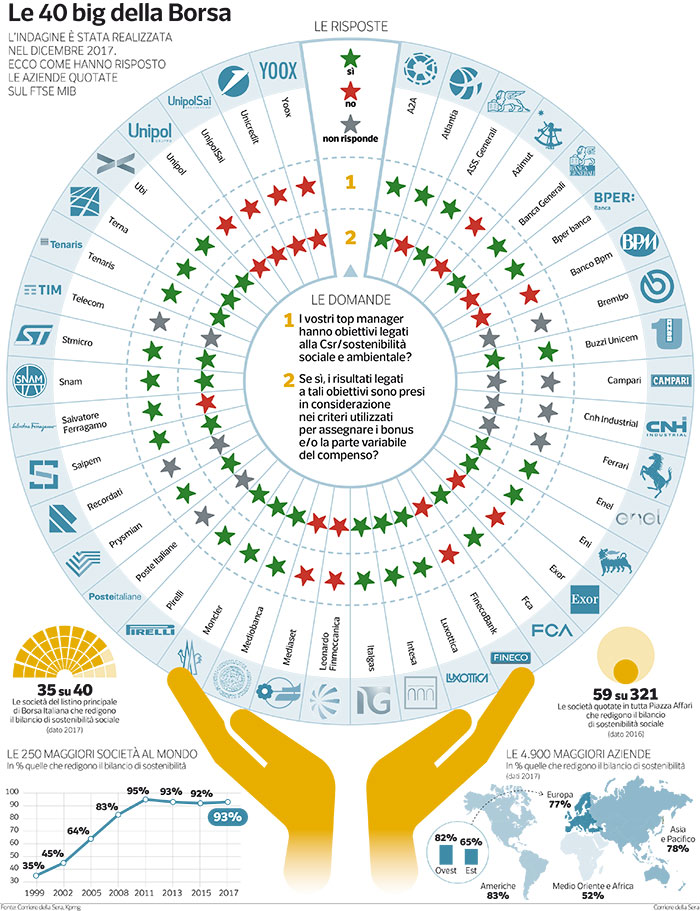Pubblicata la memoria difensiva che Mark Zuckerberg enuncerà davanti ai politici. Il ceo dirà che gli dispiace e racconterà come migliorerà Facebook
È stato un mio errore e mi dispiace. Io ho creato Facebook, io lo gestisco e io sono responsabile di ciò che accade
Mark Zuckerberg è arrivato a Washington e si sta preparando per la sua full immersion di due giorni al Congresso. Prima al Senato, poi alla Camera, il ceo di Facebook dovrà rispondere alle domande dei politici. Temi principali: l’influenza della sua azienda nelle elezioni americane (il cosidetto Russiagate) e la capacità di Facebook di proteggere i dati degli utenti (lo scandalo Cambridge Analytica).
La Commissione di Energia e Commercio della Camera, che attende Zuckerberg mercoledì alle 16 (ora italiana), ha pubblicato la memoria difensiva di sette pagine con cui il ceo aprirà la sua audizione (qui il documento originale, in inglese).
Le scuse
Il testo si apre con le stesse identiche parole con cui il ceo ha iniziato la sua conferenza con i giornalisti il 4 aprile. Ma aggiunge due parole fondamentali, la cui assenza finora era stata notata: “mi dispiace“. D’altronde, come svela il New York Times, per prepararsi agli incontri al Congresso il ceo ha lavorato con un team di esperti di comunicazione e con uno studio legale guidato da Reginald J. Brown, ex assistente speciale del presidente George W. Bush.
Obiettivo degli specialisti: far apparire Mark Zuckerberg il più umile e il più schietto possibile, di modo che risponda direttamente alle domande dei parlamentari e non sembri eccessivamente difensivo.
La privacy
Nel suo memoriale, Mark Zuckerberg riassume il caso Cambridge Analytica ed elenca tutte le attività messe in campo dall’azienda per proteggere i dati degli utenti. Facebook, assicura il ceo, sta controllando tutte le app che come Cambridge Analytica hanno avuto accesso a una grande quantità di informazioni prima del 2014, prima cioè del cambio di regole per evitare che fossero presi dati senza autorizzazione.
La questione russa e le elezioni
Sulle infiltrazioni russe, ammette Zuckerberg, “siamo stati lenti, ma la nostra abilità nel gestire queste minacce sta crescendo e migliorando rapidamente”. Nello specifico, Zuckerberg annuncia nuove tecnologie per prevenire abusi, come strumenti di intelligenza artificiale avanzata per bloccare account fasulli.
Facebook assumerà altre persone che si occupino di sicurezza.
A livello pratico, d’ora in poi per fare pubblicità politiche si dovrà confermare la propria indennità e la propria posizione. Le persone che gestiscono grandi pagine dovranno essere verificate, di modo che non possano farlo con account fake. Il ceo annuncia anche un test in corso in Canada: uno strumento che permetta di vedere tutte le pubblicità che una pagina sta promuovendo. A cui si aggiungerà un archivio su tutte le passate adv politiche.
La promessa
La memoria difensiva si chiude con una promessa: “La mia priorità principale è sempre stata la nostra missione sociale di connettere le persone, creare comunità e avvicinare il mondo. Gli inserzionisti e gli sviluppatori non avranno mai la priorità fintantoché sarò a capo di Facebook”.