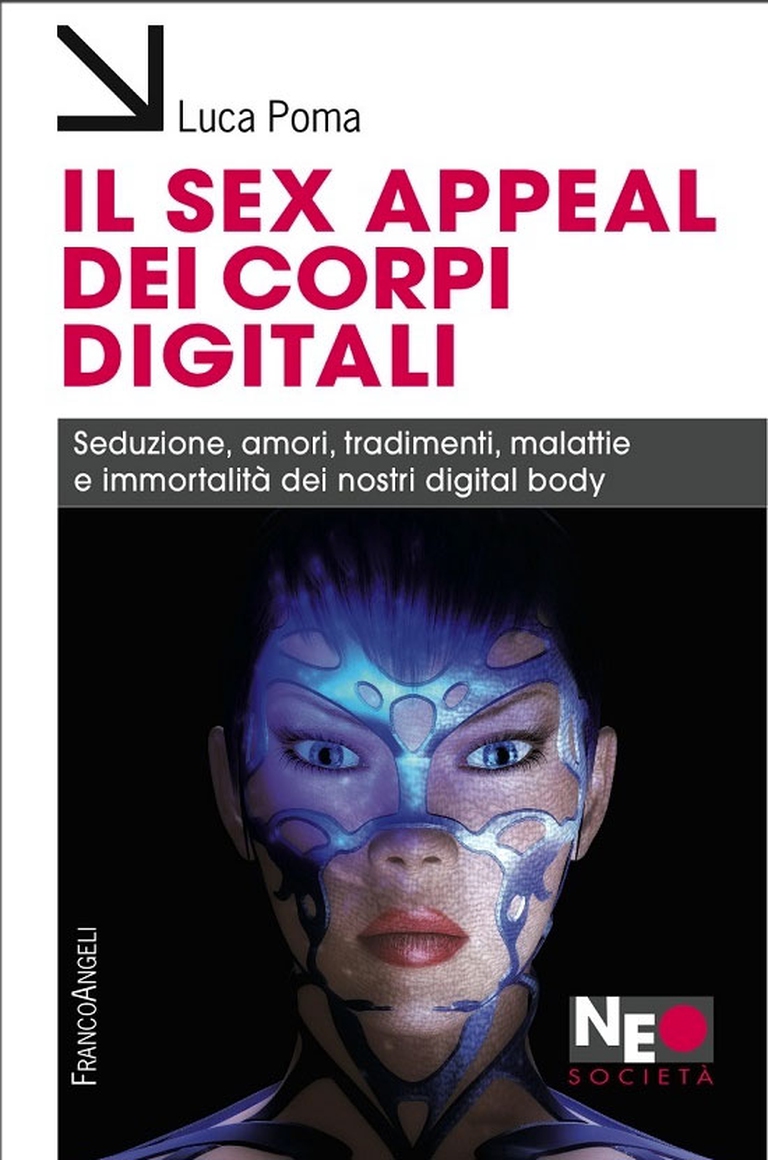Qualche tempo fa, si è cominciato a parlare di una (presunta) pericolosità dell’olio di palma. Le maggiori industrie dolciarie italiane lo hanno tolto dagli ingredienti dei loro prodotti, ma con un’eccezione: la Ferrero ha deciso di distinguersi, compiendo una scelta opposta e perciò ha manifestato l’intenzione di continuare ad utilizzarlo.
Lo ha fatto con un’efficace campagna di comunicazione, attuata pure con l’organizzazione di eventi. Come riportato dal quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore, Alessandro D’Este, amministratore delegato della Ferrero Commerciale Italia, ha dichiarato: “Vogliamo far parlare gli esperti per la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri consumatori”. Nello stesso articolo si può leggere: “Non è vero che l’olio di palma produce alla salute danni diversi dagli altri oli e grassi (Elena Fattore, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri). Non è vero che viene danneggiato l’ambiente, se si usa l’olio di palma certificato secondo gli standard più severi (Chiara Campione, Greenpeace)” (1).
In uno spot, intitolato “Ferrero. Da 70 anni la qualità prima di tutto”, come avviene nella migliore pubblicità, si ricorre agli strumenti della retorica, come quello di ordine affettivo, l’ethos, cioè “il carattere che deve assumere l’oratore per accattivarsi l’attenzione e guadagnarsi la fiducia dell’uditorio”. Infatti “quali che siano i suoi argomenti logici, essi non hanno alcun potere senza questa fiducia” (2).
A parlare è la società, per bocca di alcuni suoi dipendenti, i quali trasmettono al pubblico cinque messaggi:
“Eravamo una piccola famiglia. Se in 70 anni siamo diventati un grande successo italiano nel mondo è perché da sempre abbiamo a cuore la stessa cosa: la qualità”.
“Preserviamo i profumi del cacao con una lavorazione nata da un’esperienza di decenni”
“Come tutti gli oli vegetali di qualità, il nostro olio di palma è sicuro. Proviene da frutti spremuti freschi e da fonti sostenibili ed è lavorato a temperature controllate, perfetto per esaltare il gusto dei nostri prodotti e renderli così cremosi”.
“E le nocciole? Tostate all’ultimo per esaltarne gli aromi”.
“Perché, sì, lo sappiamo. Ogni scelta che facciamo in questa famiglia, sarà anche per la tua. E per la mia”.
Sul piano strutturale, il motivo centrale, ossia il procedimento che svolge la funzione di principio organizzatore di un testo, è la sua costruzione circolare, dovuta all’epanadiplosi, ovvero alla ripetizione, all’inizio e alla fine e quindi in una posizione di peculiare rilievo, del concetto dell’azienda come una famiglia. Esso rimanda all’idea di persona, che, secondo Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, “introduce un elemento di stabilità. Qualsiasi argomento sulla persona ha come fondamento questa stabilità: la si presuppone, interpretando l’atto in funzione della persona”. Tuttavia “la stabilità della persona non è mai del tutto sicura: certe tecniche linguistiche contribuiranno ad accentuare l’impressione di permanenza” (3).
Perciò il commercial della Ferrero contiene espressioni-chiave, come “in 70 anni”, “da sempre”, “un’esperienza di decenni”. In tal modo si crea un senso di affidabilità, di estrema importanza per l’immagine di un’industria e vi contribuisce pure l’occorrenza per tre volte della parola “qualità”.
Già nel titolo si trova un vero e proprio luogo comune, che, nonostante il suo frequente impiego in pubblicità, conserva sempre la sua forza persuasiva: quello dell’ordine, basato sulla “superiorità dell’anteriore sul posteriore” (4) (“Da 70 anni […]”). Evidentemente nessuno fra i concorrenti può vantare un simile primato.
Ed eccoci passati pertanto allo strumento retorico di carattere razionale, il logos, contraddistinto dalla “attitudine a convincere grazie alla sua apparenza di logicità e al fascino del suo stile” e che “concerne l’argomentazione propriamente detta del discorso” (5).
Il primo messaggio è incentrato sulla relazione causa (“da sempre abbiamo a cuore la stessa cosa: la qualità”) – effetto (“siamo diventati un grande successo italiano nel mondo”).
Si segue lo stesso schema nel terzo messaggio. Infatti, a sostegno della tesi (“il nostro olio di palma è sicuro”), si porta una prova, si fa un ragionamento, cioè si ricorre ad un argomento: quello che deriva, appunto, come ha scritto Olivier Reboul, dal “mostrare il valore dell’effetto a partire da quello della causa” (6), nella fattispecie costituita da “frutti spremuti freschi”, “fonti sostenibili”, lavorazione “a temperature controllate”.
Non a caso la creativa Annamaria Testa dà agli aspiranti copywriter il seguente consiglio: “Mettete in evidenza i nessi causali: le affermazioni pubblicitarie suonano sempre così vaghe e sfumate… Per questo conviene, non appena è possibile, avvitarle l’una all’altra con un bel legame causa-effetto, in modo che il risultato finale abbia un aspetto abbastanza solido” (7).
Inoltre l’opinione, espressa da quello che nel telecomunicato appare come un tecnico, viene rafforzata con l’argomento che consiste in “un’azione reciproca fra i fini che si perseguono e i mezzi messi in opera per attuarli” (8). Difatti l’ingrediente di cui si parla, è considerato “perfetto per esaltare il gusto dei nostri prodotti e renderli così cremosi”.
L’aggettivo possessivo di prima persona plurale, ripetuto due volte (“nostro olio di palma” e “nostriprodotti”), svolge un’importante funzione, perché, attraverso di esso, si sottolinea una differenza rispetto alle altre aziende.
Secondo Perelman e Olbrechts-Tyteca, “l’argomentazione non potrebbe procedere di molto senza ricorrere a paragoni, nei quali diversi oggetti siano posti a confronto per essere valutati l’uno in rapporto all’altro” (9).
Tuttavia, in concreto, il raffronto non si attua direttamente, esplicitamente, come avviene nella pubblicità comparativa, ma indirettamente, implicitamente, per mezzo dell’allusione, che viene classificata fra le tecniche d’attenuazione, le quali “dànno un’impressione favorevole di ponderatezza, di sincerità e concorrono a distogliere dall’idea che l’argomentazione sia un espediente, un artificio” (10).
Invero tale figura retorica consiste nel dire una cosa (“il nostro olio di palma è sicuro”) per farne intendere anche un’altra più profonda e nascosta, che non si vuole dichiarare apertamente e quindi si sottintende e comunque si evoca: i competitor evidentemente non possono offrire la stessa garanzia, in quanto si sono affrettati a stampare sulle loro confezioni la dicitura “senza olio di palma”.
Ma è difficile dimenticare in un attimo che quella sostanza entrava nella composizione dei loro dolci fino a poco tempo prima. E dunque, in qualche modo, la loro decisione di rinunciarvi si configura come il riconoscimento di un errore, l’ammissione di una colpa, con un danno alla propria reputazione e una perdita di credibilità. Per di più si avvia un altro meccanismo argomentativo, quello del precedente, che consiste nel presumere come possibile la persistenza in avvenire di ciò che si è verificato in precedenza: nel nostro caso, chi ha sbagliato in passato, potrebbe farlo pure in futuro. Tutto ciò è in relazione con il pathos, lo strumento retorico di ordine affettivo con il quale l’emittente del messaggio tende a provocare vari sentimenti nel ricevente: nella fattispecie, la Ferrero cerca di suscitare sfiducia verso le altre industrie dolciarie.
La distinzione della Ferrero nei riguardi dei concorrenti rimanda ad un tópos. Ne hanno parlato – li citiamo ancora una volta – Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca: “Al limite, il luogo della qualità giunge alla valorizzazione dell’unico che […] è uno dei cardini dell’argomentazione”. Effettivamente “è ciò che ci sembra unico, che diviene per noi prezioso”, giacché il suo valore “può essere espresso contrapponendolo al comune”. Perciò diventa “degno di nota e piace anche alla moltitudine” (11).
Qualcuno si chiederà se, al momento della sua ideazione, gli autori dello spot fossero consapevoli della presenza di simili elementi e del loro legame di complementarità. Ovviamente non siamo in grado di dare una risposta. Tuttavia, come ha ricordato Olivier Reboul, “esiste una retorica spontanea, un’attitudine a persuadere per mezzo della parola che forse non è innata – non entriamo in questa discussione – ma che non è dovuta nemmeno a una formazione specifica; e poi una retorica che si insegna […] e che serve a formare dei venditori o degli uomini politici, a insegnare loro ciò che altri venditori, altri uomini politici sembrano sapere naturalmente” (12).
NOTE
(1) JACOPO GILIBERTO, <Ferrero si schiera in difesa dell’olio di palma>, in Il Sole 24 ore, 28 ottobre 2016 (in sito web).
(2) OLIVIER REBOUL, Introduzione alla retorica, Il Mulino, 1996, pp. 21 e 69.
(3) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, 2013, pp. 318-319.
(4) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., p. 101. La parola “luogo” è la traduzione del termine greco tópos. Il suo plurale, tópoi, indicava originariamente le sedi, dove sono conservati gli argomenti (nel senso di prove, ragionamenti). Ancora oggi si fa dunque riferimento alla loro presenza nella memoria collettiva.
(5) OLIVIER REBOUL, op. cit., pp. 36 e 70.
(6) OLIVIER REBOUL, op. cit., p. 211.
(7) ANNAMARIA TESTA, La parola immaginata, Pratiche, 1992, p. 138.
(8) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., pp. 296-297.
(9) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., p. 262.
(10) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., p. 503.
(11) CHAΪM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., pp. 97-98.
(12) OLIVIER REBOUL, op. cit., p. 20.