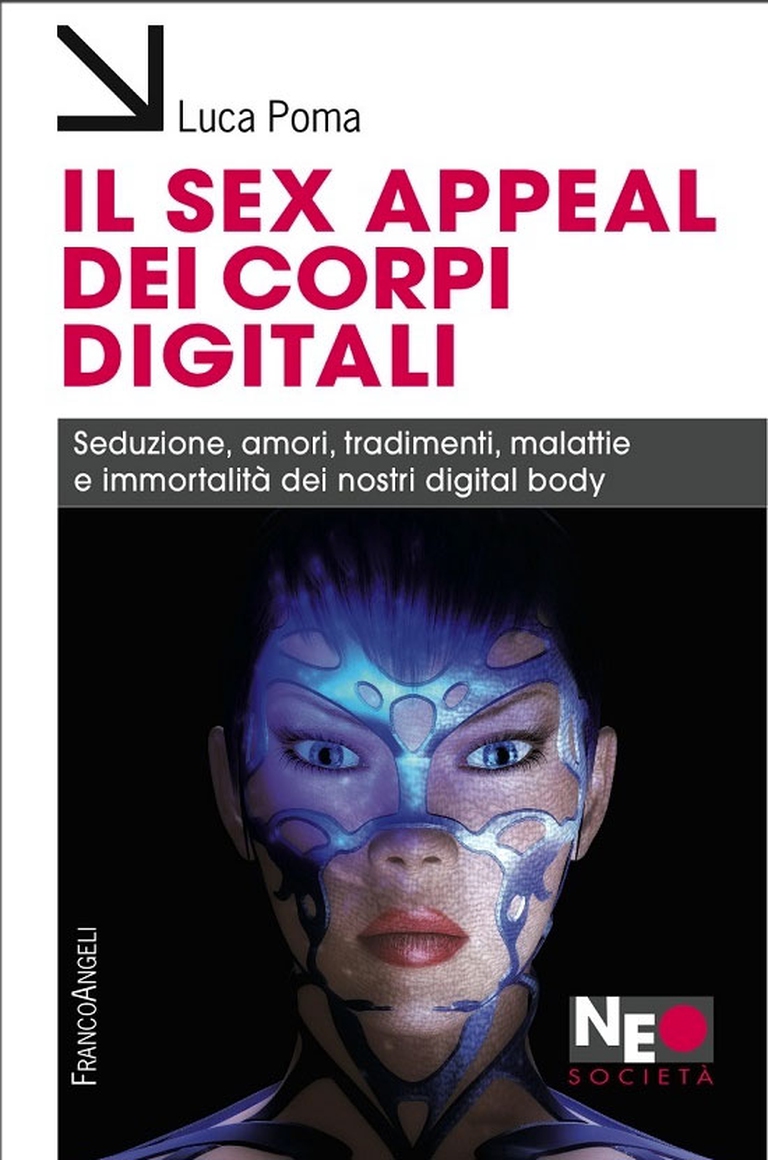Sono Diego, risolvo problemi

Il capo della strategia digitale del governo è a metà mandato e ci spiega come si fa una riforma impossibile
“Sto cercando di non dire ‘politica’. La parola politica è come la parola ‘cosa’, la puoi usare un po’ dappertutto. Io preferisco essere più specifico”. Diego Piacentini, vicepresidente di Amazon, nell’ultimo anno ha vissuto sulla sua pelle una contraddizione in termini. Nominato un anno fa Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale per via squisitamente politica, uomo di punta della fase più dinamica e rottamatrice del governo Renzi, ha capito che per avere qualche remota possibilità di successo deve volare sempre più alto di ogni possibile attribuzione di tipo, appunto, politico. Numero due di una delle più innovative aziende private del mondo, si è trovato per sua volontà a mettere le mani nella realtà più farraginosa del sistema nostrano, l’amministrazione pubblica. Dotato della carica altisonante di Commissario Straordinario, il suo compito principale è quello di portare l’Italia il più possibile vicino a una normalità europea. Giunto dall’America per essere il mister Wolf del sistema Italia, l’uomo che risolve i problemi, da mesi nuota controcorrente per non farsi trascinare nella melma, e, dice lui, “per non abituarmi al sistema, perché per fare la disruption, per cambiare le regole, non puoi essere abituato alle cose che non funzionano, non puoi pensare che siano inamovibili e non possano cambiare”.
Diego Piacentini parla con accento del nord e con una erre arrotatissima. Fa molte brevi pause tra una frase e l’altra. A volte per essere sicuro di quello che sta dicendo, a volte perché non ha sulle labbra il corrispettivo italiano della parola inglese che gli passa per la testa. Allora si gira verso uno dei venti-trentenni del suo team. “Questo si dice in italiano?”. Gli rispondono di sì, perché nonostante i dubbi non fa un errore e quando i dubbi sono troppi usa direttamente l’inglese, ma si vede che dopo tanti decenni passati in America parte del suo cervello è rimasta a Seattle da Amazon.
Per fare la disruption, per cambiare le regole, non abituarti alle cose che non funzionano, non pensare che siano inamovibili
È per questa sua natura marziana, per il suo venire da fuori, che Piacentini è stato scelto, simbolo di un governo capace di richiamare in patria le eccellenze di livello mondiale, anche se solo in aspettativa e con un mandato di un paio d’anni, e di metterle in condizione di cambiare le cose. Al momento della sua nomina, Piacentini è stato sventolato come una bandiera, ha avuto qualche mese di intensissima esposizione mediatica. C’è stata anche qualche dose di immancabili polemiche, qualcuno disse avrebbe aiutato Amazon a conquistare l’Italia, poi si è capito che Amazon fa attività di conquista abbastanza bene anche da sé, senza bisogno di aiuto. Piacentini per allora si era già allontanato dai riflettori e inabissato nel lavoro, si è messo a “montare i tubi”, come dice lui. Il governo è caduto, ne è subentrato un altro, e lui riemerge raramente, rimane sottotraccia, a preparare le fondamenta. E intanto ha avuto modo di capire molte cose sul sistema Italia e sul suo futuro digitale, sul ruolo della tecnologia nella PA e sulle possibilità di riformare ciò che sembra refrattario a ogni cambiamento, fino allo spauracchio della democrazia diretta.
Oggi Piacentini è a metà del suo mandato e sa che lascerà tutti i cantieri aperti – lo sapeva fin dall’inizio: non si realizza in due anni un progetto che richiede un’intera generazione –, ma lavora come se il suo progetto dovesse durare vent’anni dopo di lui. “Tempo tempo tempo, ci vuole tempo”, ripete più volte, tempo per radunare le competenze e le eccellenze, tempo per creare le infrastrutture, tempo per cambiare la testa della classe politica.
“Il rischio che il nostro lavoro sia eliminato completamente quando ce ne andremo c’è, guarda cosa sta facendo Trump”, dice. “Ma qualunque nuova leadership arriverà potrà valutare ciò che abbiamo fatto – dal Piano triennale per la trasformazione digitale della PA alle altre iniziative –, avrà delle nostre proposte scritte ben chiare e potrà decidere cosa fare. Questo sarà il nostro lascito, un modello che poi potrà essere sviluppato. Comunque vada c’è bisogno di un’Agenzia digitale centrale, forte, competente, con budget, con capacità d’intervento. L’Italia ne ha bisogno”.
Stiamo montando i tubi, prepariamo il lavoro sotterraneo, ma ci piace far vedere alcuni progetti di punta
Qui bisogna usare un trucco trito, e dire a Piacentini: se dovessi spiegare a mia madre cosa fa l’Agenzia digitale, cosa le dovrei dire? Lui sta al gioco e dice: “Ho avuto lo stesso problema con mia madre, e ho deciso di usare la metafora dell’idraulico. Stiamo lavorando a quelle componenti della costruzione della casa che sono assolutamente necessarie perché la casa funzioni ma non sono immediatamente visibili da chi ci abita. Montare i tubi vuole dire lavorare duro per creare piattaforme abilitanti che restino, per cambiare le norme, le regole”. Piattaforma abilitante è un termine che Piacentini usa spesso, e indica piattaforme realizzate centralmente per consentire che un servizio sia usato da un intero ecosistema. Dal lavoro sulle norme e sulle regole è disceso il già citato Piano triennale, che è il grande manuale della digitalizzazione della PA in Italia e contiene le regole da seguire e le pratiche a cui ispirarsi per qualsiasi amministratore che voglia iniziare a cambiare le cose. L’ha scritto l’Agid, Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con il team digitale di Piacentini. E’ un lavoro mastodontico ma chiaro e dettagliato, e sarà aggiornato ogni anno da un team apposito perché, appunto, l’innovazione non si ferma mai. Piacentini continua parlando delle nostre madri: “Visto che non siamo solo idraulici ma vogliamo fare anche gli artisti, ci sono due-tre cose che ci fa piacere che si vedano”. Facciamole vedere. “Quella che secondo me è più evidente di tutte anche nel breve periodo sono i pagamenti digitali”. Il progetto di Piacentini in quest’ambito si chiama PagoPA, che è una piattaforma abilitante (vedi sopra) che consente di pagare tutti i servizi della Pubblica amministrazione (tasse, imposte, bollette) tramite un unico sistema sia online sia fisico. PagoPA esisteva già prima dell’arrivo di Piacentini, ma giaceva praticamente inutilizzato. Il team digitale l’ha ripreso in mano e lo ha reso graficamente gradevole e usabile, l’ha integrato con tecnologie di facile accesso come PayPal, sta sostenendo la sua crescita e la sua diffusione. “PagoPA è importante perché oltre ad aiutare il cittadino nei pagamenti rende più efficiente lo stato, che con i pagamenti attraverso questo sistema ha la riconciliazione automatica dei conti, con risparmi notevoli”.
Un altro progetto visibile che porterà benefici nel medio-breve periodo, dice Piacentini, è l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, Anpr, un lavoro enorme perché significa riunire entro uno stesso sistema digitale tutte le anagrafi disparate degli ottomila comuni italiani. “Quando Anpr sarà eseguita completamente avremo creato tutte le condizioni affinché l’amministrazione cambi i processi con cui lavora, non ci sarà più bisogno che tre uffici diversi richiedano i dati anagrafici allo stesso utente per tre volte”. Collegato ad Anpr c’è Spid, il sistema di identità digitale (un altro progetto che già esisteva e che il team Piacentini ha rivitalizzato) il cui obiettivo finale è quello di dare a ogni cittadino un set unico di credenziali per accedere a tutti i siti della PA. “Stiamo parlando con Inps per fare in modo che Spid diventi il sistema di riconoscimento unico per entrare nel loro sito, e man mano che i servizi aumenteranno Spid diventerà sempre più conveniente”.
Già così i miglioramenti tangibili non sono niente male. Poter pagare la PA con un solo sistema digitale e poter accedere ai servizi della PA con credenziali uniche e semplici (niente Pec, niente password mandate mezze via mail e mezze via posta, niente code agli uffici con file di identificazioni stampati) è un assaggio di normalità europea apprezzabile.
A questo punto però viene da fare a Piacentini una domanda strana: “Perché sei qui?”. “Qui” è Palazzo Chigi, un ufficio poco lontano da quello del premier Gentiloni, ed è anche la carica di Commissario straordinario. Il “perché” che non riusciamo a comprendere è: sul serio per dare all’Italia un assaggio di normalità europea come pagare le tasse online serve il vicepresidente di Amazon? Sul serio per fare quello che altrove hanno già fatto degli onesti burocrati bisogna andare a prendere un’eccellenza dall’America e conferirle la carica altisonante di Commissario straordinario? Rispondere a questa domanda significa entrare davvero in profondità nella filosofia di Piacentini.
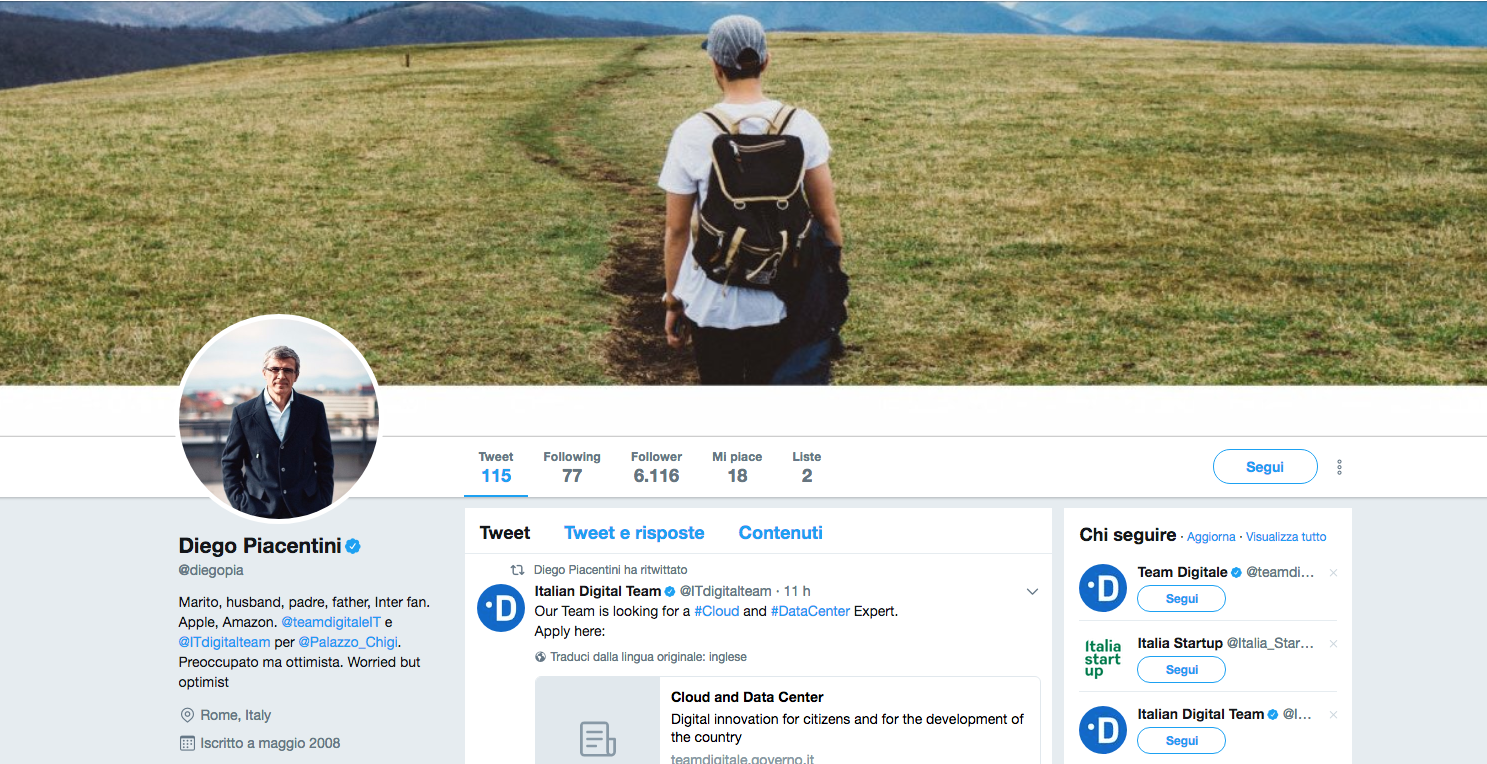 |
Il profilo Twitter di Diego Piacentini
Su Twitter e su Medium, i due social che usa di più per raccontare l’attività del suo team, Piacentini si definisce “preoccupato ma ottimista”. E’ lo stato d’animo praticamente perfetto, da far applaudire un filosofo stoico. Sarebbe comprensibile, però, che dopo un anno trascorso intento nella trasformazione digitale della PA la preoccupazione abbia preso il sopravvento sull’ottimismo. “L’ottimismo rimane ma è di un grado diverso, nel senso che mentre pensavo prima che alcune cose potessero essere fatte in un certo modo adesso conosco di più l’essenza degli ostacoli”. Il punto centrale però è la preoccupazione. “Devi essere sempre preoccupato per affrontare la complessità dei problemi. Non riesco a misurare se la complessità che avevo in mente quando ho iniziato era più o meno elevata di quella di adesso. Ora capisco molto di più quali sono i singoli ostacoli, i singoli blocchi, i singoli difetti di processo”. Per esempio? “Prima di venire in questo ruolo non avevo considerato, perché semplicemente non le conoscevo, le complessità derivate dal procurement, quindi dall’acquisto delle soluzioni tecnologiche – che non è un problema dell’Amministrazione italiana ma di tutte le PA del mondo. Come compri? Non solo devi rifinire la tecnologia e disegnare l’architettura, ma si aggiunge la complessità di fare l’acquisto. Questo è uno degli ostacoli più grossi”. Il problema di come lo stato acquista tecnologia aiuta a capire quanto lavoro c’è da fare. “L’Italia, rispetto ad altri paesi, ha una complessità superiore determinata dal fatto che le regole di acquisto sono governate da Anac, l’anticorruzione. Questo fattore è meno rilevante in altri paesi europei, e quindi è più facile semplificare – anche se qui non sto dando giudizi di valore sul fatto che esistono complessità determinate dall’Anac”. Poi ci sono le metodologie d’acquisto. In Italia e pochissimi altri paesi del mondo si usa il sistema dei “punti funzione”, vale a dire: quando un progetto parte, deve aver aggiunto l’obiettivo x entro un anno, l’obiettivo y entro due anni e l’obiettivo z entro cinque anni. “Ma non è così che funziona l’innovazione tecnologica”, dice Piacentini. “Già è complicato stabilire gli obiettivi di un progetto quando si costruisce un’autostrada, figuriamoci in una realtà tecnologica in cui tutto cambia nel giro di pochi mesi”.
Il problema sono i governi. I governi sono statici e fanno fatica a evolvere. Per questo c’è bisogno di un cambiamento profondo
Qui esce il primo di quelli che Piacentini chiama “colli di bottiglia”: l’eccesso di formalismo. “Per valutare la riuscita di un progetto in Italia non si valuta il risultato, ma l’aderenza ai ‘punti funzione’. Prendiamo l’esempio di Anpr. L’azienda che aveva avuto l’incarico di crearla, Sogei, dopo aver creato il prodotto e aver soddisfatto tutti i requisiti del contratto ha considerato il lavoro completo. Avevano ragione. Ma nessun comune stava usando il prodotto! Questa è la differenza tra agire in base a formalismi e valutare il risultato. Le aziende tecnologiche realizzano un prodotto e poi lo fanno crescere, c’è un’evoluzione continua. Nella PA un progetto finisce quando sono soddisfatti i requisiti del contratto, ma questo è l’anti tecnologia”.
“C’è una certa tendenza ad abituarsi a condizioni che apparentemente non si possono cambiare e finire per assecondarle. Prendiamo per esempio il blocco della assunzioni nella PA. Come fai a trasformare digitalmente l’amministrazione se non puoi assumere le persone competenti che servono per farlo? Però da tutti sento dire: la finanziaria è così, non ci possiamo fare niente. Invece no. Il presidente del Consiglio è in questo corridoio, ovviamente non fa tutto quello che gli diciamo ma abbiamo la possibilità quanto meno di descrivere i colli di bottiglia, i difetti di processo. Dobbiamo creare le condizioni per portare nella PA eccellenze anche dal privato, magari per uno-due anni, come abbiamo fatto noi, fornendo la possibilità di incidere e di cambiare le cose”.
Altra complessità inizialmente non prevista sono i personalismi. “Molta gente non ha il coraggio di concordare su un’opinione anche quando è giusta. Molti vogliono far valere le proprie idee anche quando sanno che sono sbagliate pur di affermare la propria posizione. Sono poche le persone con cui lavoriamo che dicono: ok, questa è la strada giusta, seguiamola. Molti invece devono imporre la loro presenza perché altrimenti perdono il loro ruolo, perdono il loro valore. Questa cosa è molto forte in Italia. Lavorando per Amazon sono stato esposto a decine di paesi, sono stato in Cina cinquanta volte, trenta in India, e tra i paesi a cui sono stato esposto l’Italia è quello che ha il minor senso del bene comune, della cosa comune, di fare qualche cosa per il bene del paese o per il bene della comunità. Non è istintivo, non è nel nostro dna”.
E qui torniamo al discorso dell’inizio, e a quella parola terribile e troppo generica: politica. Perché tutto quello che abbiamo raccontato finora potrebbe tranquillamente essere catalogato nel calderone troppo grande di ciò che è politico, gestione della polis. Tra le complessità c’è anche quella di avere a che fare con una classe politica che considera Uber una minaccia, Flixbus un’aberrazione, Amazon una compagnia troppo grande e pericolosa da attaccare con l’antitrust – una classe politica che, insomma, ha seri problemi con l’innovazione?
“La questione va oltre la classe politica, e riguarda quanto la politica in generale abbia la capacità di adeguarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici. Prendiamo l’intelligenza artificiale: per la classe politica si tratta di qualcosa che porterà soltanto via posti di lavoro, mentre il focus dovrebbe essere posto su come l’intelligenza artificiale può essere usata per migliorare i rapporti tra noi e il cittadino. Ovviamente in Italia ci sono tante persone ragionevoli, penso per esempio al ministro Calenda, che sulle startup sta facendo un’operazione moderna ed efficace. E poi appunto: la ritrosia nei confronti dell’innovazione non è solo italiana. Le web taxesistono in tutti i paesi occidentali, e tempo fa il consulente tecnologico di Michael Bloomberg, allora sindaco di New York, mi raccontava che tra i requisiti per entrare nel team tecnologico del comune di New York avevano trovato la conoscenza di Ms-dos (un sistema obsoleto e non più usato da almeno vent’anni, ndr): gli ufficiali del comune ancora pretendevano questo requisito”. Piacentini fa una pausa. “Il problema sono i governi. I governi sono statici e fanno fatica a evolvere. Per questo c’è bisogno di un cambiamento della classe politica, di un nuovo sistema educativo. Ci vorranno tanti, tanti anni”.
“Paradossalmente, potrebbero essere i paesi in via di sviluppo quelli che riusciranno a cambiare la classe politica più rapidamente”. Forse perché hanno meno lacciuoli democratici? “Anche. Ho visto in India progetti tecnologici eccezionali realizzati con facilità che in occidente non sarebbero mai accettati per ragioni di privacy – e certo non lo contesto. Ma nei paesi in via di sviluppo è anche molto più forte il concetto di problem solving. I politici devono mettersi in testa che sono lì per risolvere i problemi” mentre, si capisce dal discorso di Piacentini, da noi ciò che è politico rischia spesso di trasformarsi in ostacolo.
Vogliamo comunicare che bisogna uscire dalla mentalità di chi dice che in Italia non funziona niente
Dunque come si fa ad attuare sistemi di decisionismo non democratici rimanendo democratici? Andrebbe digitalizzata anche la politica? “La tecnologia aiuta a trovare soluzioni non complesse per risolvere problemi complessi. Prendiamo il nostro Piano triennale. E’ aggiornato ogni anno per mantenerlo sempre al passo. Ma questo non sarebbe possibile con i normalissimi metodi della democrazia, con i tavoli, le consultazioni, parlare con la conferenza delle regioni, con la conferenza dei comuni, con dodicimila persone che devono avere un’opinione. Così abbiamo installato un forum diretto che ci consente di avere immediatamente tutte le osservazioni della PA, dei comuni grandi e piccoli, dei responsabili tecnologici. Non tutti i consigli sono poi assorbiti, ma grazie alla tecnologia possiamo aggiornare molto più velocemente il nostro Piano. Questo può essere un nuovo modo di fare democrazia, cioè la possibilità di parlare direttamente e di ricevere input senza gli intermediari. La tecnologia ti permette di eliminare i broker, i layer. Peccato che i broker e i layer esistano e non sanno cos’altro fare nella vita, ed è difficile eliminarli. Però la tecnologia ti permette di farlo”.
Non stiamo entrando forse nel terreno scivoloso della democrazia diretta? “La democrazia diretta è un’astrazione. La tecnologia può fornire piattaforme che consentono di raccogliere le opinioni e di comunicare direttamente con il maggior numero di cittadini possibili. Ma poi sono le regole di questo colloquio che determinano il modello. La tecnologia può aiutare la democrazia rappresentativa a evolvere, ma non la sostituisce”.
Sei un fautore del small government à la Thatcher? “No, perché alla fine gli stati servono. Certo, digitalizzare uno stato piccolo è più facile, guarda all’Estonia, a Singapore, alla Norvegia. Ma solo per una questione di popolazione”. Piacentini sorride al nostro tentativo e dice: “Non è facile etichettarmi. L’unica etichetta che mi si può dare è quella di interista”.
E quindi iniziamo a capire perché questa eccellenza interista è dovuta volare fin da Seattle per fare qualcosa che negli altri paesi già esiste. Per impiantare una cultura. Piacentini si ribella a questa definizione che rischia di trasformarlo non in un tecnico, ma in un simbolo: “Non voglio essere solo un simbolo, altrimenti duro niente, appena vado via dicono: è stato lì un anno e non ha fatto un… non ha fatto niente”. E’ ossessiva in lui l’attenzione al problem solving, alla necessità di applicare un attento project management. Piacentini parla di “eccellenza operativa” per spiegare come il suo lavoro sia quello di prendere dei progetti morti e trasformarli in avanguardia europea. E certo i progetti ci sono, si toccano. Ma il lavoro di Piacentini è generazionale, e lui ha solo due anni di tempo. Dunque è chiaro che oltre alle cose, il suo lascito sarà anche fatto di culture. “Noi siamo qui a risolvere problemi, ma vogliamo comunicare che bisogna uscire dalla mentalità di chi dice che in Italia non funziona niente”.