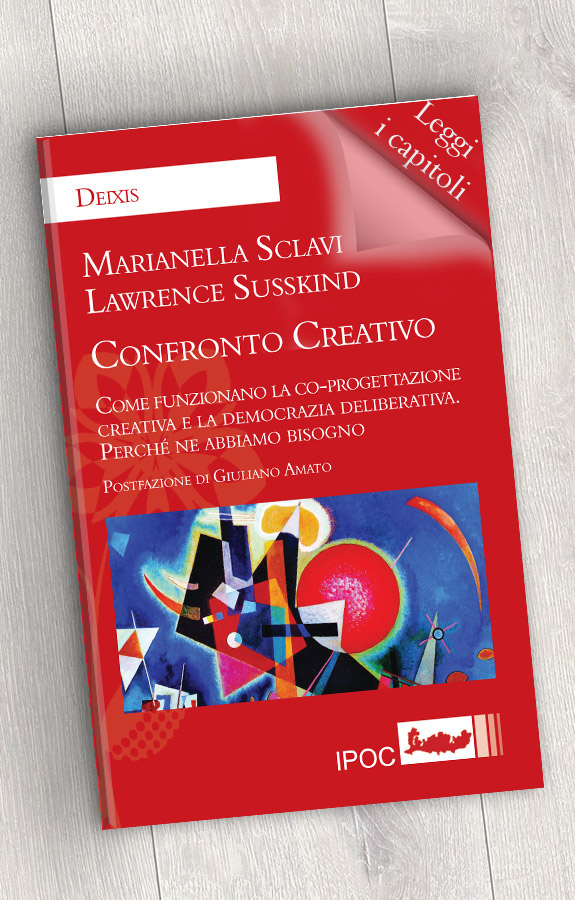E’ stato da poco ristampato da IPOC il saggio Confronto creativo di Marianella Sclavi e Lawrence Susskind. Marianella Sclavi ha insegnato etnografia urbana al Politecnico di Milano ed è un’esperta di “ascolto attivo” e “gestione creativa dei conflitti”. Si è interessata sia di buona comunicazione interculturale che degli ingredienti delle ‘scuole felici’, mostrando come l’ascolto attivo sia un elemento virtuoso fondamentale in entrambi i campi.
L’abbiamo intervistata perché con “Confronto creativo” esplora le dinamiche della vita pubblica e riesce a descrivere in modo originale ed efficace non solo gli aspetti negativi, ma, cosa rara, anche e soprattutto quelli positivi del confronto. E, in un’epoca in cui sembra che la conflittualità sia il registro dominante di tanti rapporti, può esser una strategia a cui fare riferimento.
Lei ha viaggiato molto, e ha esplorato diverse aree culturali in America, Europa, ecc. Ha appreso molto ed è diventata maieuta di molte esperte ed esperti di processi partecipativi. Chi è dunque Marianella Sclavi? Quali sono stati i suoi “incontri” decisivi per mettere a punto e offrire all’attenzione del pubblico il metodo del “confronto creativo”?
Incomincio dalla parte finale della domanda. Un incontro decisivo, anche se preceduto da parecchi altri, è stato quello con Lawrence Susskind del MIT. Susskind è stato fra i fondatori nella prima metà degli anni ’80 delProgram on Negotiation (Pon) della Harvard Law School, che è un prestigioso e attivissimo laboratorio internazionale di Alternative Dispute Resolution (ADR). La mia impressione, frequentandolo, è che tutti gli attivisti e innovatori più interessanti del mondo, prima o poi passano di lì. Nel 1987 Susskind ha pubblicato un libro intitolato Breaking the Impasse. Consensual approaches to resolving Public Disputes (scritto con Jeffrey Cruikshank) che sostanzialmente applica la ADR alle Dispute Pubbliche e sostiene che la crisi delle decisioni pubbliche e della governance dopo gli anni ‘70 è legata, da un lato, alla necessità di ampliare l’arco dei soggetti che vi partecipano e, dall’altro, al non saper valorizzare i conflitti di cui i diversi soggetti sono portatori, al fine di praticare progettualità creative, trasparenti, e muovere verso soluzioni di mutuo gradimento. In altre parole: non è sufficiente ampliare gli attori coinvolti nelle decisioni e le informazioni di cui ognuno dispone in partenza; sono assolutamente necessarie le dinamiche inter-individuali e di gruppo dell’ADR. E’ una tesi molto radicale che io condivido ed è quella che ci ha fatto incontrare e collaborare.
Come ha scoperto la ADR e in che cosa consiste?
Ho scoperto l’esistenza dell’ADR grazie ai pionieri urbani che avevano risanato un quartiere del Sud Bronx. All’inizio degli anni ’90 stavo svolgendo una ricerca sul campo per carpire i segreti di questo successo quasi incredibile. Uno dei segreti riguardava il trattare le situazioni di conflitto con metodi innovativi, come l’ADR. L’ADR nasce da una serie di studi sulle differenze fra le dinamiche messe in atto nei conflitti che hanno avuto un esito positivo, di mutuo gradimento, e gli altri dove il conflitto si perpetua o va in escalation. Nei casi positivi, le parti in gioco adottano reciprocamente un atteggiamento esplorativo senza fretta di giudicare e di arrivare a delle conclusioni. E’ un percorso con passaggi precisi: prima si cerca di capire quali sono gli interessi e le preoccupazioni al di là delle posizioni e rivendicazioni reciproche, poi ci si dedica assieme alla moltiplicazione delle opzioni (buone pratiche, combinazioni precedentemente escluse, ecc) e solo alla fine ci si impegna a inventare soluzioni di mutuo gradimento. Si tratta di uscire dalla logica “io vinco tu perdi” e viceversa e da un atteggiamento giudicante, di urgenza classificatoria. Si tratta di diventare “esploratori di mondi possibili”. Poi questa ricerca è stata pubblicata col titolo “La Signora va nel Bronx”.
Il contatto con Susskind, concretamente, da cosa nasce?
Nel 2005 Susskind, che insegna al MIT, ha organizzato un convegno di tre giorni per far incontrare due circuiti che operavano (e ancor oggi non di rado operano) per compartimenti stagni: i principali teorici della Democrazia Deliberativa (DD) e i “practitioners” della Alternative Dispute Resolution (ADR), la trasformazione creativa dei conflitti. Erano presenti fra gli altri Jane Mansbridge, James Fishkin, Susan Potziba, Carolyn Lukensmeyer e molti altri, e solo due europei, un giovane olandese e io. Io c’ero arrivata con la presentazione di John Forester della Cornell University che conosceva i lavori che avevo fatto a Torino con Avventura Urbana negli anni ’90, in cui avevo operato come esperta di arte di ascoltare e di gestione creativa dei conflitti nei processi partecipativi. Da lì ho ottenuto un invito come visiting scholar al MIT e al Program on Negotiation della Harvard Law School, nel 2006. Poi con Susskind abbiamo scritto il libro “Confronto Creativo “ che presenta quest’approccio e queste problematiche in Italia.
In Confronto creativo, parla di una cittadina fittizia ma in cui tutti noi vorremmo vivere: Dolceriviera. Lei parla di come in questo paese alcuni cittadini abbiamo realizzato il metodo del confronto creativo per raggiungere l’obiettivo di presentare il 150° dell’Unità d’Italia ai più giovani. Quali sono le Dolceriviera reali che ha trovato nel suo cammino, magari anche solo parzialemente?
Nel libro sono raccontate una serie di esperienze fondative, negli Usa, in Sud Africa e anche in Italia nelle quali questo approccio ha preso corpo. Aver conosciuto personalmente alcune persone, come Carolyn Lukensmeyer e Susan Potziba che hanno diretto e gestito processi partecipativi estremamente complessi con esiti molto positivi, per me è stato fondamentale perché mi ha dato il coraggio di provarci anche io. Fra le esperienze italiane che ho diretto e facilitato quella più affine a Dolceriviera è il processo partecipativo del 2007 a Livorno, dove su incarico del sindaco sono state coinvolte parecchie decine di giovani nella stesura delle linee guida per il riuso di un edificio di 750mq nel cuore della città, il “Cisternino”, ex Casa della Cultura, da destinare a spazio ideativo e culturale per i giovani. Però la simulazione di Dolceriviera, alla quale è dedicata tutta la parte centrale del libro, serve fondamentalmente a mostrare i vari trucchi, ingredienti, passaggi di un processo deliberativo che poggia sull’ascolto attivo e la gestione creativa dei conflitti (che sono le mie declinazioni della ADR). In particolare questo è un caso che parte dal coinvolgimento di varie categorie di giovani per progettare le iniziative dei 150 anni di Unità d’Italia, e diventa un programma di risanamento economico/culturale della intera città. Ascoltando i singoli partecipanti e aiutandoli ad ascoltarsi fra loro, viene fuori, infatti, che “qui c’è poco da festeggiare”, non solo i giovani non trovano lavoro, ma gli albergatori e i commercianti sono preoccupati, le scuole fanno fatica a mettersi in sintonia con le nuove generazioni, e così via. E quindi man mano che la “cabina di regia” allarga i contatti, le idee che nascono non riguardano solo i festeggiamenti, ma iniziative che potrebbero creare posti di lavoro in un ripensamento generale del modo con il quale la città si vede e si presenta. Questo non è ottenibile con un approccio “alla Habermas” o di semplice “dibattito allargato” come è – per esempio – il Dibattito Pubblico francese, che stiamo importando in Italia. Confronto Creativo implica il passaggio del contesto di incontro dal “dibattito e argomentazione” al “dialogo e ADR”.
Quindi lei ritiene che il Dibattito Pubblico e comunque l’ampliamento di spazi di confronto che nel libro lei e Susskind chiamate “parlamentari”, basati sulla argomentazione aperta e trasparente, siano manipolatori o comunque insufficienti?
Non necessariamente manipolatori (anche se i politici di solito li vedono come funzionali al consenso e non alla elaborazione di diagnosi diverse dalle loro), ma quasi sempre insufficienti. Il Debat Public come procedura obbligatoria di coinvolgimento dei territori interessati alle decisioni è un aggiustamento, un voler supportare la democrazia rappresentativa con un supplemento di informazioni, di punti di vista. Richiede che vengano sviluppati scenari alternativi, e questo è positivo, e anche che il progetto iniziale possa essere cassato del tutto, come in effetti è successo in Francia più di una volta, e anche questo è positivo. Ma tutto ciò non tiene conto che la crisi della comunicazione ormai è tale da richiedere, anche solo per ottenere per davvero questi esiti, una rottura epistemologica molto più chiara e radicale. Non credo si possano fare dei veri passi in avanti rimanendo nella ambiguità. Un dialogo non è un dibattito cortese in cui gli interlocutori si fanno a vicenda presenti i pro e contro delle rispettive posizioni, come in un balletto. Degli spazi dialogici, come quelli richiesti da processi di democrazia, che funzionano per davvero sono rigorosamente basati su altre regole.
Il suo libro più famoso è Arte di ascoltare e mondi possibili. Da cosa nasce e come si collega a questo suo impegno nel campo della progettazione partecipata?
E’ un libro originariamente rivolto agli studenti di architettura e urbanistica del Politecnico di Milano dove insegnavo, ed è tutto incentrato sul concetto di “cornici”, di assunti impliciti che dobbiamo mettere in discussione per ampliare le opzioni al di là degli archi di possibilità dati per scontati nel mondo sociale di cui siamo parte. Sono lezioni che procedono a colpi di esercizi di fenomenologia sperimentale e di etnometodologia (i “patafisici delle scienze sociali”) per provocare esperienze di auto-riflessività. Quali sono le emozioni che accompagnano un’uscita dalle cornici date per scontate? Come possiamo interpretarle per favorire l’innovazione? Che rapporto c’è fra le dinamiche dell’umorismo, quelle della buona comunicazione interculturale e la progettazione creativa? E così via. Gli studenti di solito venivano a dirmi: “E’ stato molto utile con la mia ragazza”. Ed è un buon inizio. L’incontro fondamentale che sta alla base di tutto questo è con Gregory Bateson e la sua “Ecologia della mente”. Poi si sono aggiunti Michail Bachtin, Arthur Koestler, Wittgenstein e molti altri.
Che rapporto c’è fra umorismo e progettazione creativa?
Per tutti i miei autori prediletti, Bateson, Wittgenstein, Bachtin, Koestler, Von Foerster, De Bono, e i maestri del pensiero Zen, le dinamiche dell’umorismo e quelle della buona conoscenza praticamente coincidono. Per loro l’umorismo è una palestra nella quale ci si può allenare in modo non traumatico a uscire dai luoghi comuni del linguaggio e del pensiero che altrimenti ci tengono prigionieri e ottundono la nostra intelligenza. L’umorismo è un campo del sapere specializzato nelle tecniche e nei trucchi per produrre momenti di spiazzamento, defamiliarizzazione, spaesamento: tutti stati d’animo fondamentali per perserguire l’auto-riflessività, il distacco e il coinvolgimento necessari alla buona conoscenza e a un’ecologia della mente. Perché nel lavoro di gruppo la smentita non ci induca a irritarci e offenderci, ma a ridere di noi stessi, e perchè l’assurdità e il non senso non siano stupidi ma illuminanti, sono necessarie alcune condizioni di contesto, alcune “premesse implicite” che sono fondamentalmente le stesse (con poche varianti) di quelle operanti in una buona storiella umoristica, in un motto di spirito ben riuscito. In effetti se dovessi dire di cosa mi occupo, la risposta in cui più mi riconosco sarebbe: di “salto al di là dell’ovvio”, come facilitarlo, con quali stratagemmi.
Nel Suo libro L’arte di ascoltare, ripropone un decalogo scritto da Alexander Langer (ne Il viaggiatore leggero, Sellerio 1996). Può dirci cosa ha significato per lei Langer?
Vi è tutta una serie di persone sagge che applicano questi principi perché a loro appaiono ovvi, puro buon senso. E in effetti è “buon senso” che però si conquista mettendo in discussione molte abitudini di pensiero che diamo per scontate. Richiede che si capiscano i limiti del senso comune. Alex Langer era un “natural” della uscita dalle cornici soporifere che ci soffocano. Come del resto lo è Papa Francesco o lo era il Cardinal Martini; in particolare gli incontri organizzati da Martini e pubblicati col titolo La Cattedra dei non credenti spesso mi hanno fatto venire in mente il pensiero e specialmente il modo di vivere di Alex Langer. Invece, tanto per concludere drammaticamente, il pensiero e la pratica della “lotta armata” (Brigate rosse e altri) era tutta interna alle cornici date per scontate ed è molto interessante su questo Il libro dell’incontro (Il Saggiatore 2015), recentemente uscito, che narra i dialoghi segreti avvenuti dal 2007 in poi fra vittime o parenti delle vittime e responsabili della lotta armata. Non a caso la cornice che ha reso possibili questi incontri è garantita da esperti di “giustizia riparativa”, una modalità di giustizia basata sull’arte di ascoltare e la gestione creativa dei conflitti. Senza questa cornice, questo livello di parola e di ascolto non sarebbe stato possibile.
Lei si è occupata anche del conflitto nella ex Jugoslavia e in Israele-Palestina
Riporto una testimonianza dal libro che ho appena citato: “Noi pensavamo che la violenza dello Stato e la violenza della rivoluzione fossero distinte. In realtà, se scegli il terreno della violenza, diventi simmetrico a chi ha il monopolio della violenza, nel caso specifico lo Stato. Non fai altro che riprodurre ciò che tu vorresti combattere. E’ un discorso di simmetria: pensi di essere il nemico di quell’altro, in realtà ne stai diventando il figlio” (p. 83). Occupandomi di conflitti insanabili (e di umorismo) mi è parso chiaro che l’epistemologia dominante è priva di difese e di cure nei riguardi della violenza. La nostra cultura dominante è al fondo violenza edulcorata. E’ dimostrabile che la gestione creativa dei conflitti è assente dal nostro repertorio di possibilità. Possiamo provare a mettere un freno alla violenza, ad argomentare in modo educato invece che a suon di insulti, ma ormai questo non è più sufficiente. Basta guardarsi attorno. La cosa più sensata è cambiare radicalmente epistemologia.
PS: trovate qui il saggio introduttivo di Marianella Sclavi a Confronto creativo: “I tre know-how della gestione costruttiva dei conflitti”.