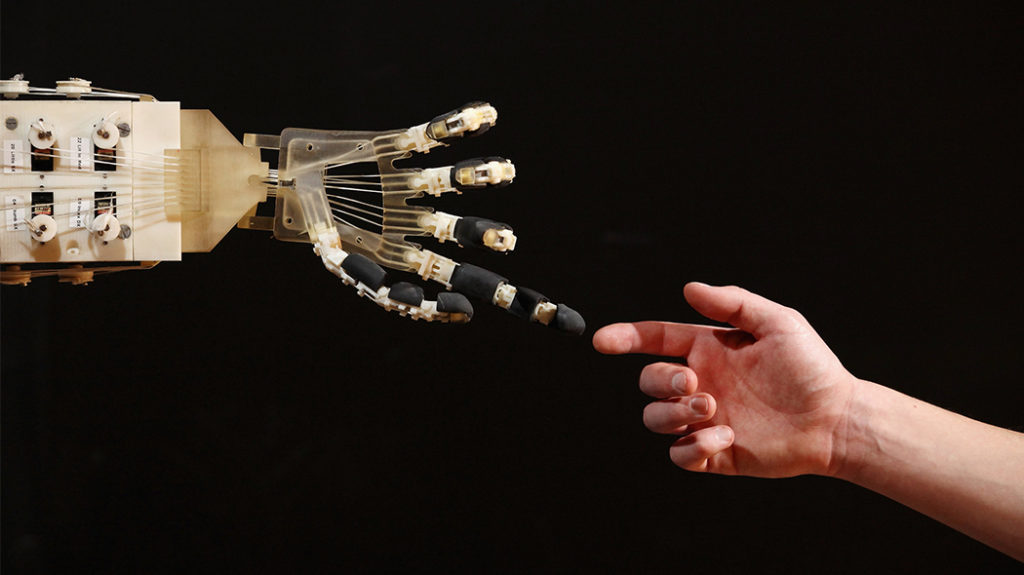Matcha Pink Drink di Starbucks: quasi #Epicfail Instagram

Mentre in Italia si sta spegnendo (forse) la polemica circa l’arrivo di Starbucks a Milano con relativa discussione aggiuntiva sulle palme in Piazza Duomo, il colosso statunitense delle caffetterie è stato protagonista – suo malgrado – di una débâcle su Instagram che nelle ultime settimane ha tenuto impegnato mezzo web.
Sappiamo che, dopo i gattini, uno dei soggetti di maggior successo sui social network fotografici è proprio il cibo, specialmente se colorato, accattivante e dall’aspetto esotico. Sappiamo anche che a Starbucks sono particolarmente bravi a confezionare immagini di bevande e dolcetti che riscuotono regolarmente centinaia di migliaia di like da utenti di tutto il mondo. E, quando ti chiami Starbucks e ti sei costruito una certa reputazione sul web, non di rado sono gli altri a parlare per te, innescando conversazioni globali in grado di creare veri e propri trend.
Qualsiasi brand piangerebbe di gioia al pensiero di essere protagonisti di un processo tanto virtuoso, se non fosse che i risultati possono essere decisamente altalenanti e addirittura trasformarsi in pubblicità negativa.
Ed è quello che è successo a Starbucks da quando DailyFoodFeed, popolare account Instagram specializzato in immagini di cibi particolarmente colorati e appetitosi – insomma, il famoso food porn -, ha pubblicato la foto di una curiosa bevanda colorata, in un bicchiere Starbucks.

La bevanda in questione è stata ribattezzata Matcha Pink Drink e non fa parte del menù ufficiale di Starbucks: chi frequenta abitualmente le caffetterie della catena sa però che è possibile farsi preparare delle bevande personalizzate, realizzate al momento dagli addetti di Starbucks su precise indicazioni del cliente. Insomma, il Matcha Pink Drink è la nuova moda delle bevande Starbucks dell’estate 2017 e con il suo colore sfumato e gli ingredienti dal nome esotico si appresta a diventare un tormentone un po’ in tutto il mondo. Non è la prima volta che questo accade: la scorsa estate era stata la volta del Pink Drink, un beverone alle fragole di un delicato color rosa che era diventato virale perfino laddove Starbucks non è presente. A guidare, anche in questo caso, sono i famosi “influencer” che dettano i trend andando oltre le proposte ufficiali del brand creando un cosiddetto “Menù Segreto” che nasce e si sviluppa sul web.
Insomma: il Matcha Pink Drink diventa virale e in molti cominciano a recarsi da Starbucks chiedendo al “barista” di prepararlo con gli ingredienti riportati da DailyFoodFeed per poi fotografare il proprio bicchierone e pubblicare orgogliosi la foto su Instagram. Solo che i risultati sono lontani anni luce dalla foto originale di DailyFoodFeed…
- Foto via BuzzFeed
- Foto via BuzzFeed
- Foto via BuzzFeed
- Foto via BuzzFeed
- Foto via BuzzFeed
È evidente che per preparare una bevanda come quella della foto di DailyFoodFeed occorrono non solo i giusti ingredienti nelle giuste dosi e alla giusta temperatura ma anche una certa dimestichezza da parte di chi la prepara. Non basta entrare da Starbucks e dire a chi sta dietro il bancone di mixare latte di cocco e fragole con il latte aromatizzato al tè matcha per ottenere quel risultato. Sopratutto se si ha idea dell’affollamento medio di una caffetteria Starbucks in qualsiasi angolo del pianeta (e non si ha Photoshop a disposizione, nonostante DailyFoodFeed sostenga che si tratti di una preparazione reale al 100%).
Però le foto pubblicate dagli utenti non sono particolarmente invitanti: e nonostante questo fantomatico Matcha Pink Drink non faccia parte del menù ufficiale di Starbucks è evidente che il brand non ne esce particolarmente bene. Anche perché tra i commenti cominciano ad emergere le voci dei dipendenti di Starbucks che raccontano esasperati di clienti che chiedono una bevanda di cui non solo non esiste una ricetta precisa, ma per la quale non hanno nemmeno ricevuto alcun tipo di formazione su come prepararla.
Da un lato, quindi, ci sono i dipendenti Starbucks che devono vedersela con orde di clienti vogliosi di bevande arcobaleno, e che se ne lamentano sul web. Dall’altro c’è un brand che, pur godendo di un’improvvisa ondata di viralità, non può sapere con quale stranezza si sveglieranno i propriaficionados domattina. Nel mentre ci sono foto di bevande decisamente poco invitanti che circolano in ogni dove con il logo di Starbucks in bella vista, accompagnate da commenti sarcastici di utenti delusi.
L’unica cosa da fare, per Starbucks, è cercare di sistemare la questione dando un colpo al cerchio e uno alla botte: se da una parte è impensabile far passare il messaggio che le “trovate” degli utenti non sono gradite, dall’altra è importante cercare di non mandare nel caos le caffetterie di mezzo mondo inseguendo il mito della bevanda arcobaleno. Così, interpellato da BuzzFeed, un portavoce di Starbucks dichiara:
Se un cliente vuole ordinare una bevanda che non è sul menù, ci raccomandiamo che sappiano la ricetta in modo che il loro barista possa prepararla. Per esempio, non offriamo un Matcha Pink Drink ufficiale – la bevanda a strati verde e rosa – ma se un cliente vuole ordinarla, la cosa più semplice è chiedere uno Strawberry Acai Refresher con latte di cocco al posto dell’acqua, e stratificarlo con latte di cocco e matcha.
Essere social, per un brand, non significa soltanto progettare e lanciare campagne sui social ma anche essere al centro di conversazioni nate dagli utenti che possono dare vita a nuove esperienze di fruizione e di consumo dei prodotti del brand. Situazioni che, tuttavia, il brand deve saper gestire: un po’ come ha fatto Starbucks che, seppure con un certo ritardo, ha saputo fornire una soluzione per non deludere i propri clienti né far impazzire i propri dipendenti. E chissà che il Matcha Pink Drink non finisca per entrare nel menù ufficiale…
Lesson Learned: Quando sei famoso e hai una buona reputazione, fai sempre molta attenzione alle discussioni che avvengono intorno al tuo brand. Anche se il sentiment è positivo, non è detto che non possa nascere una crisi d’immagine indipendentemente dal tuo operato, ma che sarai comunque tu a dover gestire.