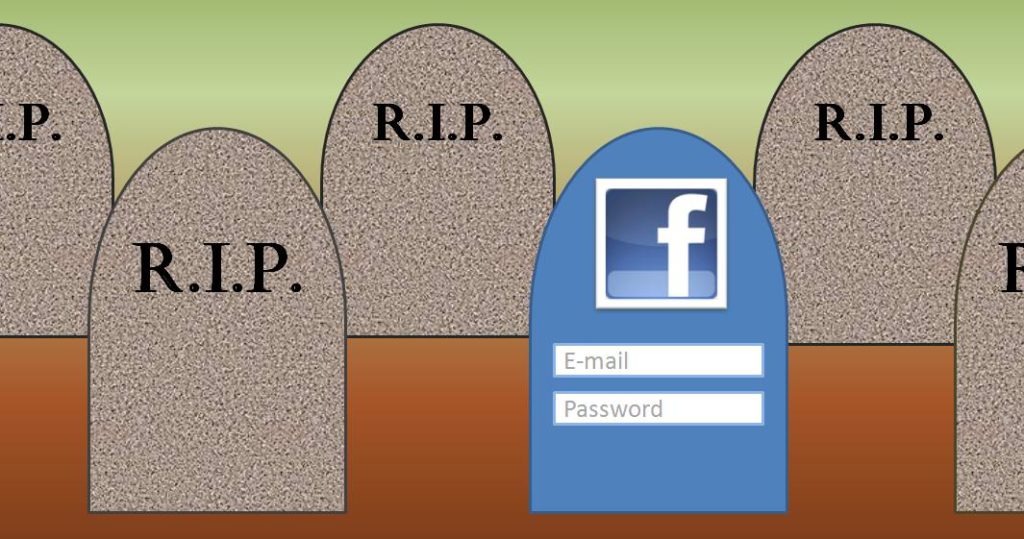Gli esseri umani hanno alle spalle un’esperienza di 200.000 anni nel rapportarsi con la morte, eppure mai come ora sembriamo incapaci di farlo. La tecnologia del 2016 ha trasformato l’idea di “passare all’altro mondo” quasi una violazione—qualcosa di non naturale. Non è che la morte sia mai stata una cosa bella, ma ad un certo punto della storia della specie, forse, era una faccenda più normale di quanto non sia ora.
Grossa parte della sua anormalità è data dall’esistenza delle identità digitali. Come persone, siamo in grado di diffondere il nostro io ovunque: abbiamo l’illusione dell’immaterialità; e ciò che resta è l’ansia di un aldilà digitale. Dove una volta l’esistenza materiale del defunto poteva essere racchiusa in un triste pomeriggio di ricordi e pulizie, ora persiste e indugia.
Non è un bene? Forse no, stando a quanto scritto in una ricerca pubblicata questo mese su ACM Transactions on Computer-Human Interaction da un trio di ricercatori che lavorano rispettivamente alla University of Lancaster, alla University of California, e alla Carnegie Mellon University. Per quanto possiamo voler tenere i morti vicino a noi, e per quanto possa essere semplice, forse non è ciò che ci serve per superare un lutto.
Cancellare qualcosa non ha assolutamente lo stesso potere catartico che ha, per esempio, il fatto di bruciare o dare via degli oggetti materiali
“Le persone vivono sempre di più la propria vita online, accumulando grandi quantità di averi digitali,” scrivono gli autori. “Molti di questi averi digitali rappresentano simbolicamente le relazioni, gli eventi e le attività importanti. Il campo di studi [che si occupa di relazioni tra esseri umani e computer] ha iniziato a esaminare questi averi digitali nel contesto della perdita e della separazione. Ad ogni modo, gran parte del lavoro esplora la conservazione e la celebrazione, nello specifico come gli averi possono avere una funzione positiva nel ricordare una relazione e nell’onorare una persona scomparsa.”
Una parte più contenuta del lavoro riguarda invece come liberarsi di questi oggetti, e il fatto che sia spesso un problema. Gli autori hanno cercato di capire meglio il fenomeno intervistando 10 psicoterapeuti—tutti specializzati nel facilitare i pazienti in lutto nella disposizione delle proprietà fisiche—da cui hanno poi sviluppato un quadro di lavoro teorico per distaccarsi dagli averi digitali dei morti.
“Durante i momenti di transizione della vita, le persone vogliono spesso allontanarsi dai ricordi più dolorosi, ma la natura disorganizzata delle collezioni digitali delle persone rende più difficile identificare quegli oggetti simbolici che è funzionale conservare o abbandonare,” prosegue il paper. “Questa mancanza di organizzazione significa anche che le persone possono imbattersi per caso in promemoria dolorosi senza preavviso alcuno. Le persone che cercano attivamente di disfarsi del materiale digitale relativo alla loro ultima rottura sentimentale, si trovano a fare i conti con l’inflessibilità della cancellazione.”
Cancellare qualcosa è un atto freddo, brutale. Le informazioni binarie organizzate che si traducono in un’immagine o in una email o in un video vengono improvvisamente scombinate, e la rappresentazione digitale è perduta come se fosse stata incastrata in una bomba nucleare e scaraventata nel vuoto dal portellone di un aereo. I terapisti intervistati hanno insistito nel dire che cancellare qualcosa non ha assolutamente lo stesso potere catartico che ha, per esempio, il fatto di bruciare o dare via degli oggetti materiali. È un attimo e poi è tutto finito (e così è la vita, per carità, ma avete capito il punto).
“Potremmo immaginare tecnologie future che fanno uso di componenti elettroniche transitorie auto-dissolventi o biodegradabili per contenere gli oggetti digitali di valore simbolico.”
La conclusione del paper, insomma, è che cancellare brutalmente un oggetto digitale non favorisce un superamento sano del lutto. Lasciar andare qualcuno o qualcosa è più facile se comprende un processo fisico che si sviluppa nel tempo. Non è un atto, ma un’esperienza. La domanda a questo punto è, come facciamo a rendere esperienziale la cancellazione digitale? Sarà mai possibile?
Gli autori sono fiduciosi. Anzi, la cosa si sposa bene con l’interazione tra esseri umani e computer di terza generazione, in cui le interazioni corporee e le esperienze sensoriali sono enfatizzate—l’interazione digitale oltre schermi, tastiere e mouse. Una delle implicazioni verte sull’idea che i contenitori digitali non siano progettati per conservare contenuti, ma per liberarli.
“Quando aperti, i contenitori potrebbero materializzare/mostrare il patrimonio digitale come testo, immagini, o suoni un pezzo alla volta per l’ultima volta, prima che scompaiano dalla percezione (rappresentando, in modo simbolico, la messa in atto della cancellazione) per non essere mai più ritrovati,” spiega il paper. “La disposizione degli effetti personali digitali, in questo caso, è sia visibile che rapida nel suo svolgersi davanti ai nostri occhi.”
“Potremmo progettare magazzini fragili ed effimeri anziché renderli permanenti e robusti, come sono ora,” prosegue il paper. “Il nostro studio sottolinea il valore degli elementi naturali come la terra e l’acqua e il loro intrinseco aspetto di deperibilità, dissoluzione e rinnovamento. Per esempio, potremmo immaginare tecnologie future che fanno uso di componenti elettroniche transitorie auto-dissolventi o biodegradabili per contenere gli oggetti digitali di valore simbolico. Tecnologie come queste potrebbero essere smaltite fisicamente o attraverso la dissoluzione o la decomposizione.”
C’è tanto altro da dire, ovviamente, ma l’idea è chiara. Quando moriamo, non scompariamo come fanno i dati. Come facciamo, dunque, a far sì che la morte dei dati sia come la nostra?