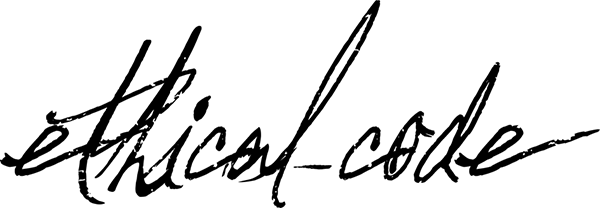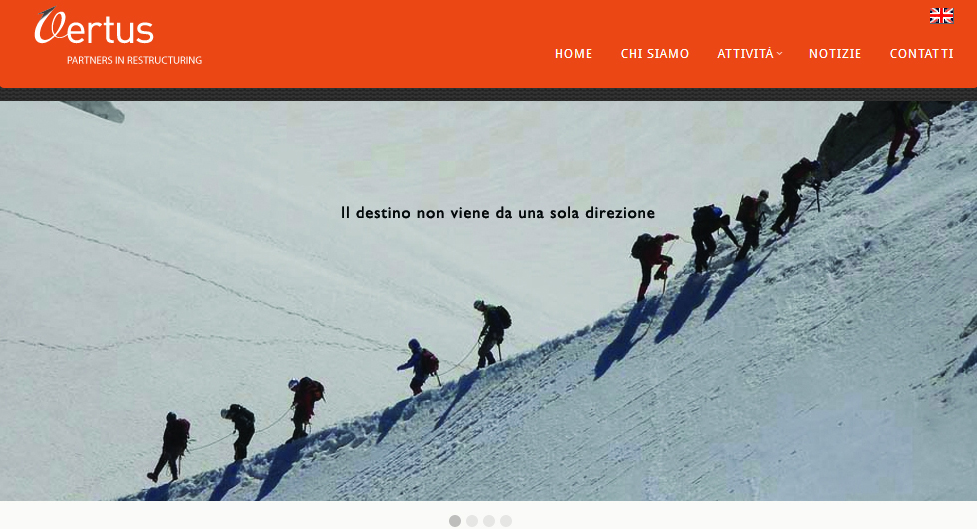Oltre la semplice filantropia, imprenditori e manager devono impegnarsi a fare delle proprie aziende soggetti attivi nell’interazione con la società.
Intervista del Prof. Luca Poma al Prof. Stefano Zamagni, per la Harvard Business Review
Iniziamo con il chiarire un aspetto fondamentale. Cosa non è responsabilità sociale d’impresa, secondo Te?
Non è né mera legalità né la filantropia come la si intende, che è sempre esistita dai primordi dell’economia di mercato. La Toscana e l’Umbria ne sono state la culla, dove già a partire dal 1200 nacquero le prime organizzazioni di tipo filantropico. Quello che hanno fatto gli americani è stato di recuperare questa idea tutta italiana per trasformarla e renderla più efficiente: l’espressione vera e propria del concetto di responsabilità sociale d’impresa, in inglese la Corporate Social Responsibility o CSR, nasce negli Stati Uniti nel 1953, quando un economista americano all’epoca non particolarmente noto, Howard Bowen, scrisse che era giunto il momento per le imprese di farsi carico della responsabilità per ciò che le circondava. L’impresa socialmente responsabile è quindi quella che non si limita a redistribuire parte dei propri profitti, ma che si adopera con i mezzi a sua disposizione per far sì che l’ordine sociale di cui è parte attiva evolva, migliorando tra l’altro l’efficienza dell’organizzazione politica e amministrativa, generando benessere per i cittadini e permettendo così a tanti nuovi soggetti di immettersi nel circuito del mercato.
Un ruolo anche “politico”, quindi?
Diciamo che parlare oggi di responsabilità sociale vuol dire porsi il problema del mutamento delle regole del gioco: l’impresa socialmente responsabile è quella che contribuisce a ciò operando, ad esempio, a stretto contatto con i soggetti politici, con altri colleghi imprenditori e così via. Perché se non cambiamo le regole del gioco, è chiaro che la mia azione filantropica sarà costantemente insufficiente rispetto all’obiettivo finale.
Prendiamo come paradigma una grande azienda multinazionale automobilistica, la quale – best in class nella CSR – a un certo punto dice bugie sulle emissioni nocive, e succede un disastro anche in Borsa. Cosa si è inceppato? Non era “CSR oriented”? Faceva finta? Cosa non ha funzionato?
La risposta è nella matrice etica che sostiene la responsabilità sociale dell’impresa, e tre sono le matrici dominanti. La prima è l’etica utilitaristica, sulla base della quale l’imprenditore ragiona così: ho scoperto che oggi essere socialmente responsabili conviene perché aumenta il capitale reputazionale della mia impresa e, in ogni caso, è il trend dominante; allora lo faccio anch’io, però sono pronto a modificare la strategia in qualunque momento se scoprissi che questo non è più conveniente. Il secondo approccio è invece quello dell’etica deontologica, ovvero l’etica del dovere. La responsabilità sociale va fatta perché è un dovere civile, cioè fa parte della cosiddetta costituzione morale dei soggetti. Da notare che l’etica deontologica ha avuto nel filosofo tedesco Kant la sua massima espressione. Infine, c’è il terzo modello, l’etica delle virtù, nata in Grecia all’epoca di Aristotele e poi perfezionata nel corso dei secoli, la quale sostiene che bisogna agire sulla base del convincimento che il mio benessere deve andare di pari passo con il tuo. Allora capiamo subito che – per stare all’esempio Volkswagen – siamo dinnanzi a ciò che succede quando una impresa basa la CSR sul codice deontologista o peggio su quello utilitaristico. L’errore da parte della governance VW è stato quello di non capire che ciò è rischioso, perché nel momento in cui l’etica dimostra di non essere più conveniente sotto il profilo delle performance, la si abbandona, ed è esattamente ciò che è avvenuto nel loro caso. Quando hanno capito che si potevano fare extra profitti violando quello che loro stessi avevano dichiarato nei loro documenti di rendicontazione sociale e nei codici deontologici, l’hanno fatto. Ora questo errore teorico sta facendo pagare loro un danno enorme nel concreto sia per gli andamenti del titolo in Borsa sia in termini di pregiudizio reputazionale.
Possiamo quindi arrivare a dire che se adesso VW promuovesse un’operazione di recovery reputazionale, pur efficientissima, ma senza modificare il proprio paradigma etico, tra 5 anni saremo punto a capo?
Certamente, e non solo, rimarrà sempre un margine di dubbio e di diffidenza sulle loro azioni. Tutti abbiamo letto le dichiarazioni del CEO di Volkswagen, ma non convincono più, si tratta solo di dichiarazioni strumentali. Devo dire che – rispetto alle tre matrici che ho richiamato – gli italiani hanno mille difetti ma sono però molto più vicini a essa di tutti gli altri popoli. Il nostro imprenditore magari fa meno, dà un po’ meno, però quando dà, è perché è davvero convinto del fatto che deve stare bene lui assieme agli altri. Quando una persona di buon senso dice: “Io devo guardare all’intenzione e non solo il gesto, non solo al fatto che mi dai cento euro, ma voglio anche capire perché me li hai dati”, ebbene, viene sostanzialmente a dirmi: “Se io so che tu sei davvero un virtuoso, semplicemente di te mi posso fidare”. E la fiducia – come sappiamo – è un asset intangibile preziosissimo.
Facciamo del fanta-management. Domani squilla il telefono del tuo studio in Università e il nuovo CEO di Volkswagen la chiama come general advisor su questi temi, per dare un contributo a risolvere il problema. Tu cosa gli consiglieresti, ora, a problema già deflagrato?
Di fare il primo gesto importante, ovvero non tanto di ammettere l’errore – questo è evidente a tutti – bensì di spiegare esattamente qual è la ragione profonda che li ha indotti in errore. Questa sarebbe la prima “prova della verità”, che fino ad oggi non hanno fatto. Perché sono tedeschi, e questa è la matrice culturale tedesca: dovrebbero ammettere che il deontologismo – a cui loro si sono legati mani e piedi sin dall’inizio, e che ha come conseguenza il doverismo – è clamorosamente fallito.
Come un esercito…
Esatto, non per nulla in passato abbiamo avuto certi tipi di esperienze con i tedeschi: gente che dice “io devo obbedire per dovere”. È chiaro che loro probabilmente non ce la faranno mai a cambiare, perché dovrebbero sconfessare una lunga tradizione di pensiero, mentre sono ancora troppo “prussiani”. Se però facessero questo gesto, creerebbero uno shock nel loro Paese e passerebbero alla storia, perché avrebbero il coraggio di dire: “Noi abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto perché aderendo a quella matrice filosofica o culturale siamo stati indotti a commettere un errore di questo tipo, che non è un errore modesto…”. Tenuto conto del fatto che la governance della Volkswagen comprende non soltanto gli azionisti privati ma anche lo Stato, l’Assia, che ha ben il 20% del gruppo, oltre ai sindacati… Allora la domanda è: è mai possibile che in un consiglio di amministrazione, in un consiglio di sorveglianza dove siedono i rappresentanti dei tre vertici, nessuno – perché chi ha scoperto l’inganno è stata una organizzazione non governativa americana – si sia accorto di nulla…?
Secondo te sapevano e sono stati zitti, oppure non sapevano e sono stati inadeguati?
Sapevano benissimo, come peraltro è stato dimostrato da chi ha denunciato il problema. E’ ovvio che i casi sono due: o questi membri del consiglio di amministrazione si disinteressavano ed erano completamente assenti, e questa è un’aggravante, oppure sapevano bene. La verità è che queste decisioni sono filtrate sia dal consiglio di sorveglianza che dal consiglio di amministrazione.
Anche i soci pubblici?
Certo. Tutti pensavano che la presenza del soggetto pubblico – e il 20% è una quota non banale – fosse una garanzia sufficiente per garantire il bene comune, ma non è stato così. Come mai il sindacato è stato zitto? Per difendere certi interessi… Ma allora vuol dire che tu difendi i tuoi lavoratori e non i lavoratori in generale. Ecco perché un gesto di questo tipo, quello che ho appena suggerito, sarebbe l’unico realmente adeguato.
La Harvard Business School ha pubblicato qualche tempo fa una ricerca durata 18 anni, paragonando 90 aziende che facevano CSR integrata realmente nei propri processi di governance e 90 aziende che non la facevano: il risultato è una differenza del 25% nel rendimento di Borsa. Quindi neanche gli imprenditori ormai hanno più la scusa di dire “non so”, “non ho capito”. Perché allora tutti questi ritardi?
Tre i motivi. Il primo è che nel mondo delle imprese nell’ultimo quarto di secolo si è assistito a un processo di crescente managerializzazione, e il manager – anche se dico una cosa che a qualcuno darà fastidio – è una specie molto raffinata di “mercenario”. Nel Medioevo i mercenari combattevano per chi pagava meglio. Ebbene, se qualcuno fa a un manager un’offerta vantaggiosa, questi abbandona quell’impresa e passa a un’altra; l’imprenditore no. Fino agli anni ’50 del secolo scorso c’erano più imprenditori e troppi pochi manager, quindi negli ultimi decenni si sono fatti investimenti nelle Business School. Perché a un manager la CSR interessa poco? Perché il vantaggio competitivo che la CSR conferisce è un vantaggio di medio-lungo termine. E’ chiaro che lo short-termism porta a una sottovalutazione: chi pratica la CSR guadagna in reputazione e ha quel 20% in più di utili, ma a me manager questo non interessa, io intanto ho il mio contratto, è già definito ex ante, ho già il golden parachute, e quindi vado avanti…
Questo è vero anche per Volkswagen.
Esatto. Invece l’Italia non è così; c’è una peculiarità italiana, perché gli imprenditori ci sono e governano le loro aziende. La seconda ragione è legata al fatto che per mettere in pratica la CSR ci vuole una competenza specifica, mentre per fare donazioni di tipo filantropico basta mettere mano al portafoglio e firmare un assegno. Inoltre la CSR ha degli effetti sull’organizzazione interna del lavoro, non soltanto sull’immagine esterna: quindi manca il coraggio – da parte degli imprenditori, in questo caso – di mettersi in gioco. La terza ragione, infine, ha a che vedere con la dominanza che ha ancora il modello così detto ford-taylorista, un modello di tipo gerarchico con struttura di tipo piramidale. Da almeno 30 anni a questa parte è iniziato un distacco dal modello tayloristico verso quello post tayloristico, il “toyotismo” è un esempio di post taylorismo. Però di fatto oggi, per le ragioni di pigrizia e di lentezza del processo di transizione, la gran parte delle imprese ha ancora una struttura mentale di tipo tayloristico. Nella struttura tayloristica è ovvio che la CSR ha difficoltà enormi ad entrare, perché è chi sta al vertice della piramide che pensa, decide e comanda, mentre la CSR presuppone una sorte di orizzontalità, di circolarità, devi avere l’umiltà di ascoltare e di dialogare con i tuoi pubblici, capire che tipo di azienda vogliono. Aggiungo un’appendice: c’è anche un ritardo culturale dovuto al fatto che si fa fatica a comprendere che rendere partecipativo il processo decisionale migliora le performance. Molti lo interpretano appunto in chiave “offensiva”.
Come non era, per citare un esempio noto ai più, per Olivetti…
Si, è un esempio molto citato, ma è bene ricordarlo. Quando nel ’55 Olivetti creò la sua squadra, vi mise a capo un ingegnere che un giorno andò da Adriano e gli disse: “Devi licenziare Natale Capellaro”, che era un operaio, aveva fatto la quinta elementare o giù di lì, ed era del leccese, del Sud. Olivetti gli chiese: “Ma perché?”. E quell’ingegnere rispose: “Perché ho visto che ruba, porta via dei pezzi, la sera”. Olivetti, se fosse stato un taylorista, avrebbe detto: il mio ingegnere capo mi dà l’evidenza, quindi licenzio in tronco il dipendente. Invece no, chiamò Capellaro e gli chiese: “Perché si dice questo di te?” E lui rispose che era vero, e che lo faceva perché l’ingegnere capo era un imbecille che stava sbagliando i piani di produzione. “Io gliel’ho detto e lui mi ha risposto: taci tu che sei un terrone semi analfabeta, vuoi insegnare a me che sono ingegnere?” Quindi Capellaro si portava i pezzi a casa perché aveva trasformato la sua cantina in un piccolo laboratorio dove stava costruendo delle cose per dimostrare all’azienda che aveva ragione, e per fare meglio…mi spiego? Olivetti allora chiamò l’ingegnere capo e lo licenziò in tronco, dicendogli: “Io ti licenzio non perché hai sbagliato il piano di lavoro, tutti possono sbagliare, ma in primo luogo perché hai offeso la dignità di una persona, e in secondo luogo perché non sei stato capace di raccogliere l’intuizione e l’idea creatrice di Capellaro, solo perché lo consideravi inferiore a te”. Cacciò via l’ingegnere tra lo sgomento di alcuni e – qui si vide l’imprenditore illuminato – mise a capo della squadra proprio Capellaro. Dopo due anni viene fuori che quel prodotto ha reso una montagna di profitti alla Olivetti. Poi Olivetti fece conferire dal Politecnico di Bari la laurea honoris causa in ingegneria a Capellaro. Questo è l’esempio che ci fa capire meglio ciò che intendevo dire…
L’assenza di doverismo?
Si. Perché Capellaro faceva ciò che faceva, faticando e rischiando? Non perché era obbligato da qualcuno, o perché si sentiva obbligato lui stesso, bensì perché lì dentro si percepiva l’etica delle virtù, perché Olivetti era una persona che testimoniava con la propria vita l’adesione all’etica delle virtù, e lo dimostrava nel concreto. E Capellaro pensava: “Voglio cooperare con la mia azienda perché la mia azienda produce bene, fa le cose per bene”. La sua motivazione interiore era in linea con quella dell’azienda. Ma se avesse saputo che l’azienda faceva certe cose solo per interessi di parte, o per pura speculazione, non avrebbe mai fatto ciò che fece.
Ti chiedo un parere su un caso di studio, quello di Guna, una PMI italiana che ha introdotto un bilancio integrato che invece di essere fatto dal management a fine anno, come rendicontazione ex post, è costruito da tutti gli stakeholder settimana dopo settimana: le ONG scrivono la propria, i dipendenti la propria e via discorrendo. Il bilancio integrato è online 365 giorni all’anno, costantemente aggiornato, senza “lifting” di fine anno. Cosa ne pensi?
E’ semplicemente geniale, ed è esattamente ciò verso cui dovremmo andare. Aggiungo che molte imprese purtroppo non sanno ancora cos’è il bilancio integrato, e quindi si limitano a interpretare il bilancio sociale come una mera descrizione narrativa ex post di quello che hanno fatto, redigendo quello che al massimo è una “relazione”. Un bilancio non deve solo raccontare quello che è stato fatto, ma deve misurare l’impatto di quello che è stato fatto, e questo è il punto. Spesso non si è in grado di distinguere la valutazione in base all’outcome, e si guarda solo l’output: io organizzo un corso di formazione e impiego certi input che hanno determinati costi; l’output è di 100 giovani in cerca di lavoro che hanno seguito il corso di formazione, e nel rendiconto io dico che 100 hanno partecipato, ma qual è l’outcome? Quanti hanno poi trovato lavoro? Il vero bilancio integrato è quello che riesce ad arrivare a valutare l’impatto sociale dei progetti dell’azienda.
Ti chiedo di essere politicamente scorretto e di dirmi: cosa non ti piace, ti dà più fastidio, condividi di meno nel mondo della CSR, lato imprese.
La letteratura sulla CSR fino ad oggi è in grado di riempire intere biblioteche ed è valsa a far penetrare nella testa di tutti – non solo delle imprese, ma anche dei cittadini – l’idea dell’utilità della responsabilità sociale per l’intera società. Ormai è difficile trovare un’azienda che parlando di responsabilità sociale d’impresa sorrida, com’era fino agli anni ’70 in America, quando Milton Friedman spiegava che l’unica cosa da fare era massimizzare i profitti ad ogni costo. Ma dopo aver perfezionato le tecniche, ci si è un po’ fermati: abbiamo interi volumi che ti dicono che il bilancio sociale va fatto in un certo modo, altri che la mettono in modo del tutto diverso. Si parla molto delle tecniche, ma se noi prendiamo questi bilanci in carta patinata e con bellissime fotografie ci rendiamo conto che ormai è diventata una sorta di moda. È questo è pericoloso, perché noi sappiamo che le mode hanno vita breve. Io allora sarei per rilanciare il dibattito pubblico su questo tema, partendo soprattutto dalla considerazione che oggi le imprese, perlomeno quelle medie e medio-grandi, stanno sempre più diventando “attori politici”, in senso alto. Cioè l’impresa non è solo un attore economico, bensì ha a che fare con la polis, la città-stato greca dove viveva la comunità. Quando – agli imprenditori, più che ai manager – si spiega tutto ciò, loro capiscono e rimangono abbacinati, perché quando si dice a un imprenditore “guarda che tu sei un soggetto, un attore anche politico, e devi e puoi farti carico secondo le tue possibilità del bene comune della comunità”, lui va al settimo cielo, perché questo gli fa recuperare il suo sogno iniziale. Spesso si dice che gli imprenditori sono tirchi, ma non è vero; quando sono abbottonati o bloccati è solo perché non viene loro offerta una vera prospettiva. Certo che se l’imprenditore viene svillaneggiato dal sindaco di turno e viene deriso dal sindacato, alla fine si richiude come un riccio, come nella tana di Kafka; ma se invece lo si rende davvero partecipe del bene comune della sua comunità, reagisce, e il bello è che torna a divertirsi davvero.
Un messaggio finale sulla CSR indirizzato ai giovani?
Di non pensare che quanto hanno ricevuto o letto, con riferimento al passato, possa essere replicato continuando sempre allo stesso modo in futuro. Un giovane deve convincersi che il progresso è contraddistinto da “salti”, quelli che nel gergo dell’economia industriale si chiamano le “disruptive innovations”, perché quando un giovane è cosciente di questo, si mette in moto, si attiva, vede la possibilità di cambiare le cose. Se invece a un giovane diamo l’idea che più o meno tutto andrà sempre come nel passato, che non cambierà nulla e che l’unica cosa che può accadere è una mera “ripulitura” o un miglioramento marginale, il giovane si affloscia e perde in potenza. A un giovane bisogna dare un motivo di speranza. Per questo vorrei concludere con le parole di un poeta inglese, John Dryden, quando diceva: “Chi cerca perle, deve tuffarsi in profondità”.
Stefano Zamagni è un economista e un teorico della CSR, Professore ordinario di Economia all’Università di Bologna e di International Political Economy alla Johns Hopkins University.
Luca Poma è scrittore, e Professore di reputation management all’Università LUMSA di Roma e specialista in Crisis communication. “Public Affairs Awards” per l’eccellenza nella comunicazione, è stato Consigliere per le strategie digitali del Ministro degli Esteri e membro del team per le policy di comunicazione strategica del Ministero della Difesa. Il suo blog è Creatoridifuturo.it. Ha lavorato a progetti di comunicazione in 23 Paesi, e a gennaio 2016 è uscito il suo decimo libro, per Franco Angeli, dal titolo “Il sex-appeal dei corpi digitali” www.corpidigitali.it . Si ringrazia Daniele Tigli per la collaborazione alla realizzazione dell’intervista.