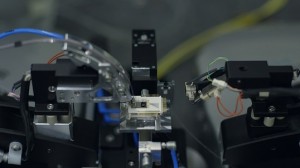Conflitto su Wikipedia: la British Petroleum si auto-descrive

L’azienda responsabile dell’incidente nel Golfo del Messico ha redatto metà dell’articolo che la riguarda, «rispettando le regole»
Storie di conflitti di interesse: protagonista, per una volta, non l’Italia ma Wikipedia e la British Petroleum. L’azienda petrolifera è tristemente nota per l’incidente nel Golfo del Messico, un disastro ambientale di vaste proporzioni costato ai responsabili miliardi di dollari di danni .
Sull’enciclopedia online c’è ovviamente una voce dedicata all’episodio e alla BP, ma secondo alcuni editor indignati sarebbe stata riscritta al 44% dalla società stessa, in particolare per quanto riguarda le politiche di riparazione ambientale. La polemica si infiamma proprio mentre la BP si appresta, il 5 aprile, ad affrontare in udienza una class action miliardaria per rivendicazioni che l’azienda definisce “fittizie o gonfiate”.
Ma il dubbio avanzato da alcuni redattori della Wikipedia è che “gonfiate” o comunque faziose siano le informazioni che l’enciclopedia ospita attualmente sulla vicenda. Il danno d’immagine per la BP è stato quasi inquantificabile e non stupisce che il marketing stia lavorando alacremente per darle una ripulita, su Internet prima di tutto.
La BP non avrebbe mai messo mano direttamente alla pagina che la riguarda, ma avrebbe inserito un suo rappresentante nella comunità di collaboratori di Wikipedia. Il testo sarebbe poi copiato “così com’è” nella pagina dai redattori, all’insaputa dei lettori che pensano di leggere informazioni imparziali.
Le sezioni sotto accusa sono state curate dall’”Utente: Arturo presso BP ”, e includerebbero le voci “Energia Alternativa”, “Le accuse di greenwashing” (termine che indica attività di pr che tendono a dare un’immagine “ecologica” di una particolare azienda), e “risultati Ambientali”, tra gli altri.
“Arturo presso BP”, che peraltro si qualifica come un membro dell’ufficio stampa, fornisce il contenuto per la pagina di Wikipedia. Lui stesso dichiara di avere “creato questo account per contribuire a migliorare gli articoli su BP, in linea con gli standard e le linee guida di Wikipedia”. E sulla pagina di discussione dell’enciclopedia aggiunge: “Le informazioni che presento da nuove fonti sono verificate dai vari esperti del tema all’interno della società. Io non sono un esperto su tutti gli argomenti e voglio fare in modo che qualsiasi contenuto proposto dalle fonti adottate sia in realtà preciso”.
In questo modo, il ruolo della BP resta nascosto ai lettori di Wikipedia, ma non ai redattori abilitati, che a quanto pare si dilungano in discussioni e polemiche , senza intervenire.
Polemiche che favoriscono l’attività di marketing della BP, che ha potuto di chiarare a Cnet di non avere mai leso le regole di Wikipedia. “La BP – hanno spiegato al sito – opera all’interno delle linee guida di Wikipedia su come rappresentanti delle società devono interagire con i redattori del sito. Per quasi un anno, siamo stati completamente trasparenti, senza mai operare direttamente le modifiche” e “rivelando quando abbiamo offerto suggerimenti ai redattori di Wikipedia che provenivano da un nostro rappresentante”. “La nostra partecipazione al processo editoriale – sostiene l’azienda petrolifera – ha senza dubbio portato a una maggiore precisione, che in fondo dovrebbe essere la principale preoccupazione di tutti coloro che si basano su questa risorsa per le informazioni”.
La polemica non cade in un momento troppo favorevole per la grande enciclopedia aperta del web. Il sito cerca fondi ed è stato investito da accuse e sospetti di articoli comprati e commissionati.
Le informazioni offerte dalla British Petroleum potrebbero anche essere le più precise e corrette, non vorremmo negarlo a priori, ma di fronte ai sostenitori dell’idea e del progetto Wikipedia, una compagnia petrolifera responsabile di uno dei più gravi disastri ecologici degli ultimi anni che redige da sé gli articoli che la riguardano è il peggiore degli spot possibili. Anche questo è un danno di immagine.