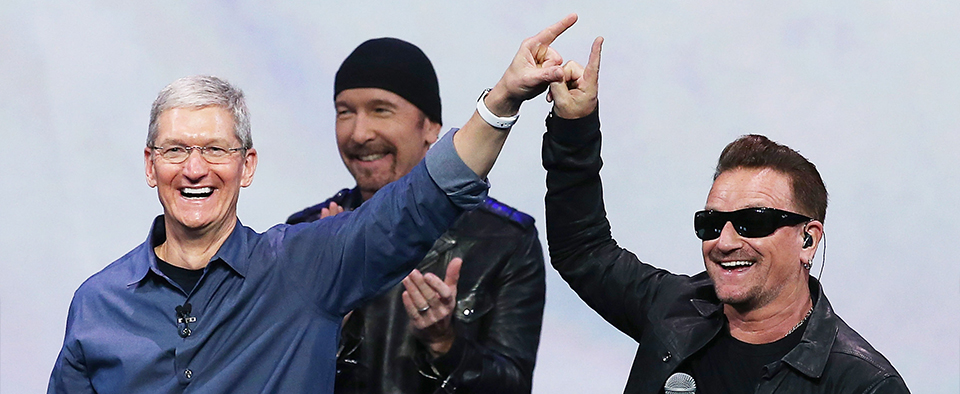Responsabilità sociale, primi passi dentro i cda
Che la responsabilità sociale sia un asset strategico per lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese lo si ripete comunemente da più parti. Studi, analisi e indagini demoscopiche, corsi accademici, meeting e conferenze convergono da tempo su questa affermazione. Ma c’è una domanda che sorge spontanea, pur rimanendo generalmente nell’ombra: al dire segue anche il fare? In parole povere, la moneta della Csr (Corporate social responsibility) si spende principalmente per interesse reputazionale o si traduce anche in concrete strategie di business e in risultati tangibili?
Una (lodevole) ricerca ha elevato questo dubbio da cinica curiosità a quesito scientifico, indagando come sostenibilità e Csr entrino effettivamente nell’agenda dei board delle società quotate italiane. Promossa dal Csr manager network, l’associazione dei dirigenti della responsabilità sociale, in collaborazione con Assonime e Nedcommunity, e condotta con un gruppo di ricercatori di Altis, l’Alta scuola impresa e società dell’università Cattolica diretta da Mario Molteni, la ricerca fornisce un’inedita fotografia dell’attuale livello di coinvolgimento dei consigli d’amministrazione intorno ai temi della Csr. Ma c’è di più: i risultati vengono messi a confronto con i dati delle società quotate sul Ftse di Londra, l’indice principale del mercato azionario britannico.
«Qualche anno fa avremmo avuto paura delle risposte», confessa Fulvio Rossi, responsabile dell’area sviluppo e integrazione progetti di Terna e presidente del Csr manager network, da poco rieletto per il triennio 2014-17. «Il fatto stesso che per la prima volta ci siamo avventurati su questo terreno racconta di una maturazione in atto intorno al tema della responsabilità sociale». I risultati, in effetti, hanno premiato il coraggio: «Sono emersi dati buoni, addirittura impensabili fino a poco tempo fa», dichiara Rossi. Che però precisa subito: «Se ci fossimo aspettati di riscontrare l’ordinarietà della materia nell’agenda dei vertici aziendali saremmo però rimasti delusi, perché questa risposta ancora non c’è».
Ecco dunque, in sintesi, che cosa emerge dalla ricerca, che in particolare ha preso in esame le imprese quotate comprese nell’Indice Ftse Mib (di queste il 77,5% ha risposto al questionario). Il 90% delle società quotate sull’indice principale italiano ha adottato un codice etico, con relativi impegni, soprattutto in materia ambientale. Nel 64% dei casi il cda ha definito e comunicato erga omnes gli impegni. Il 77% pubblica un report di sostenibilità, che è passato per l’approvazione direttamente in consiglio. Il 38,7% dei membri del cda sono destinatari di formazione periodica in tema di responsabilità sociale. Due su tre sono aggiornati su base sistematica riguardo ai rischi socio-ambientali connessi all’attività dell’impresa. Solo il 42% delle società intervistate, tuttavia, ha integrato le tematiche socio-ambientali nel piano industriale, mentre il 25% ha adottato pratiche per agganciare parte del compenso dei consiglieri esecutivi a indicatori di performance anche ambientali. «Questo dimostra che siamo all’inizio della storia, non alla fine», chiosa Rossi. «Quando scatta la volontà di misurare un determinato fenomeno è più facile che partano le iniziative concrete».
Esigenza, quest’ultima, resa evidente anche dal confronto con la realtà britannica: nel 53% delle prime cento aziende quotate a Londra il cda è impegnato direttamente nelle politiche di Csr, mentre nel nostro Paese (con riferimento alle società intervistate nella ricerca) solo per il 15% dei casi i temi di sostenibilità sono assegnati esplicitamente al livello più alto della struttura gerarchica. Un folto gruppo (27,5%) delega a un comitato manageriale, che risponde al cda. Nei restanti casi (ossia oltre la metà) il coinvolgimento avviene attraverso organismi esterni al cda (ad esempio comitato rischi o audit). «Non si è ancora del tutto capito – spiega Rossi – che è normale occuparsi di questi temi per una buona conduzione del proprio business. A volte si fa Csr solo per cautela, per esempio quando si osservano i problemi unicamente nell’ottica della tutela dai rischi».
Va però aggiunto che, in un Paese come il nostro, caratterizzato da una diffusa rete di piccole e medie imprese, molte pratiche e iniziative che potrebbero a buon diritto essere classificate nell’ambito della Csr non emergono. Le ragioni sono diverse, in gran parte riconducibili alla storia e alla natura stessa del nostro sistema imprenditoriale. Ad esempio, come ricorda Rossi, «molte realtà hanno la caratteristica di essere fornitori, quindi curano al massimo la qualità e il prezzo, ma non beneficiano di alcuna spendibilità di brand e non hanno dunque interesse a comunicare le proprie pratiche di sostenibilità». La prossima sfida, pertanto, può diventare quella di mettere in evidenza questo «sommerso» di responsabilità sociale che, senza ombra di dubbio, esiste e che, una volta tanto, farebbe guadagnare note di merito al nostro Paese