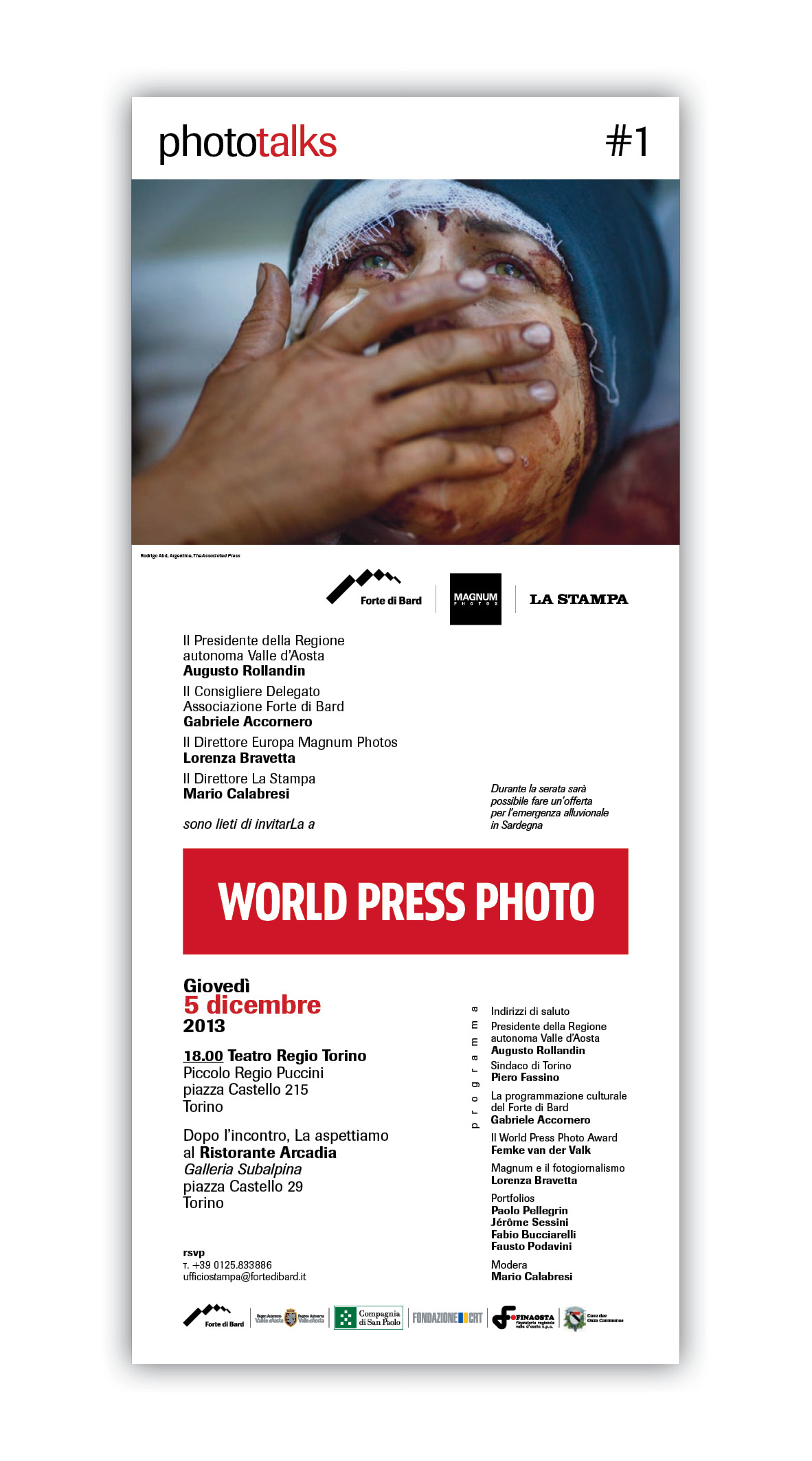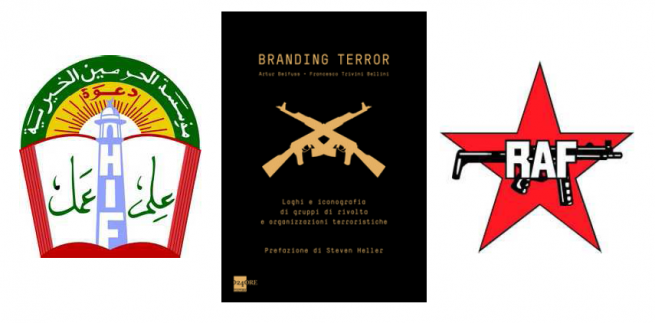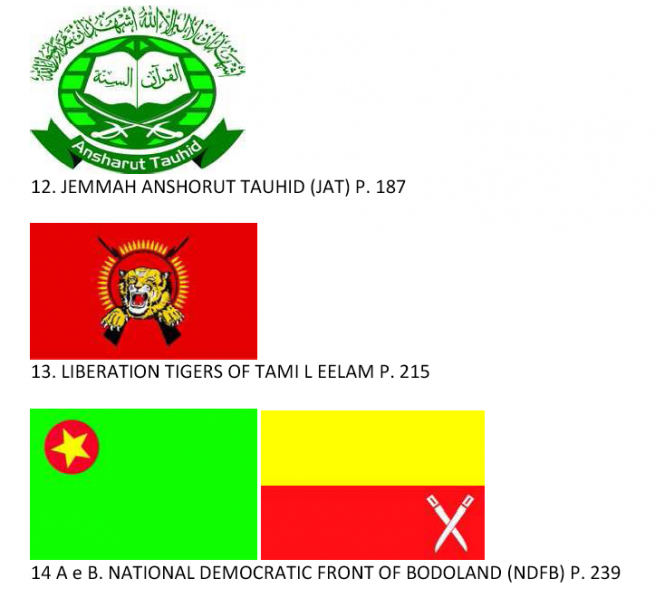Violazione copyright, chi ci rimette? "In fondo è tutto marketing gratuito"
Studio indipendente commissionato dall’Agcom inglese va controcorrente. E prova ad anticipare le soluzioni utili a un giusto equilibrio tra offerta legale dei contenuti e l’ampliamento della libertà di scelta dei consumatori. Per evitare la criminalizzazione dei comportamenti quotidiani
OGNI VOLTA che rigiriamo una email, pubblichiamo un poster pubblicitario su Facebook o una clip musicale su Youtube violiamo il copyright di qualcuno. Ogni volta che facciamo lo schizzo di un quadro durante la riunione aziendale violiamo un copyright, ogni volta che incolliamo la copertina di un libro su Twitter o pubblichiamo un articolo di giornale sul nostro blog violiamo un copyright. Ogni volta che fotografiamo i nostri bambini dentro un museo violiamo un copyright. Siamo tutti trasgressori. Ma chi ci rimette? Secondo i pubblicitari nessuno, è tutto marketing gratuito; secondo le associazioni di categoria a rimetterci sono gli autori delle opere. Un professore americano, John Tehranian, nel suo libro “Infringment Nation” ha calcolato l’ammontare delle potenziali richieste di risarcimento per ognuno di questi innocui atti quotidiani stimandolo su circa un milione di dollari al giorno.
Tutti criminali allora? Per l’industria del copyright sì. Le associazioni di categoria in tutto il mondo – gli editori belgi, l’associazione cinematografica americana, la Siae italiana, la Business Software Alliance e molte altre – lamentano quotidianamente perdite di miliardi di dollari o di euro di mancati introiti, tasse inevase e perdita di posti di lavoro, dovuti alla diffusione illegale di opere creative. I numeri che danno sono stratosferici e qualche dubbio su come vengono calcolati rimane.
Di recente l’Autorità inglese per le telecomunicazioni, Ofcom equivalentealla nostra AGCOM, ha pubblicato uno studio esteso sulla violazione del diritto d’autore in Inghilterra. Condotto su un campione di alcune migliaia di persone con un metodo inedito, questionari online e interviste faccia a faccia, lo studio di Kantar Media incaricata da Ofcom e pagata dall’Intellectual property office (Ipo) inglese ha fatto un po’ di chiarezza sull’allarme copyright.
La ricerca ha stimato che nei tre mesi di monitoraggio dei comportamenti del campione su Internet solo 1l 16% dei soggetti considerati, dai 12 anni in su, aveva scaricato o “strimmato” o “acceduto” a materiale “illegale”, cioè materiale di cui non si posseggono i diritti relativi all’acquisto. I livelli di violazione di questi diritti sono piuttosto variabili: l’8% ha consumato musica senza pagare, il 6% lo ha fatto coi film, il 2% con software e videogames. La maggior parte dei trasgressori sono maschi tra i sedici e i trentaquattro anni. Ma l’analisi ha anche registrato che questi consumatori scorretti consumano più contenuti digitali di tutti gli altri, anche pagandoli. Di questo 16% la metà ha dichiarato di farlo illegalmente perché i contenuti sono “gratuiti”, e perché è comodo e veloce. Un quarto dei trasgressori dice di farlo per provare i “prodotti” e decidere se comprarli oppure no.
Il problema senza dubbio esiste e pone un questione centrale dell’era della riproducibilità tecnica di ogni oggetto e opera dell’ingegno umano, quello della giusta retribuzione degli autori e del mantenimento della filiera industriale grazie alla quale le loro opere arrivano confezionate al grande pubblico. Ma l’irrigidimento delle norme per tutelare il copyright non è l’unica strada per farlo. Nello studio di Ofcom il 39% dei trasgressori intervistati ha dichiarato che se i prodotti costassero meno non li scaricherebbero illegalmente, il 32% non lo farebbe se quello che cercano fosse disponibile legalmente, il 26% non lo farebbe se fosse finalmente chiaro cosa sia sotto copyright e cosa no.
Non a caso la Commissione Europea ha dichiarato di voler avviare un dialogo strutturato con tutti gli stakeholder per adattare il copyright all’era digitale e affrontare il tema della portabilità transfrontaliera dei contenuti, la questione degli user generated contents (contenuti generati dagli utenti) e del data mining (analisi di una grande mole di dati), come pure i prelievi sulle copie private. Un dialogo necessario per evitare che capiti ancora di poter sequestrare il computer a una bambina finlandese di nove anni che aveva scaricato la canzone di una pop star nazionale, molto popolare tra le adolescenti e le ragazzine.
Tutto qui? No. Le proposte alternative a riequilibrare i diritti degli autori e dei consumatori sono molteplici. A cominciare da quella del Centro Nexa del Politecnico di Torino di dare la facoltà a tutti gli autori di rilasciare le proprie opere nel pubblico dominio e di indicare di volta in volta le opere che non debbono starci. Una proposta simile a quella del dual licensing lanciata da Creative commons e molti gruppi di artisti e attivisti di poter distribuire le proprie opere con full-copyright o con un copyright attenuato secondo le convenienze e gli scopi del proprio lavoro. Il meccansimo potrebbe funzionare. Creative Commons ha festeggiato proprio questo mese i 10 anni dalla nascita del set di licenze libere che oggi campeggiano su moltissimi contenuti di Flickr o Tumblr, giornali, settimanali e televisioni come Al Jazeera e che ci dicono che tutto quello che non è vietato è permesso. Permesso d’autore.