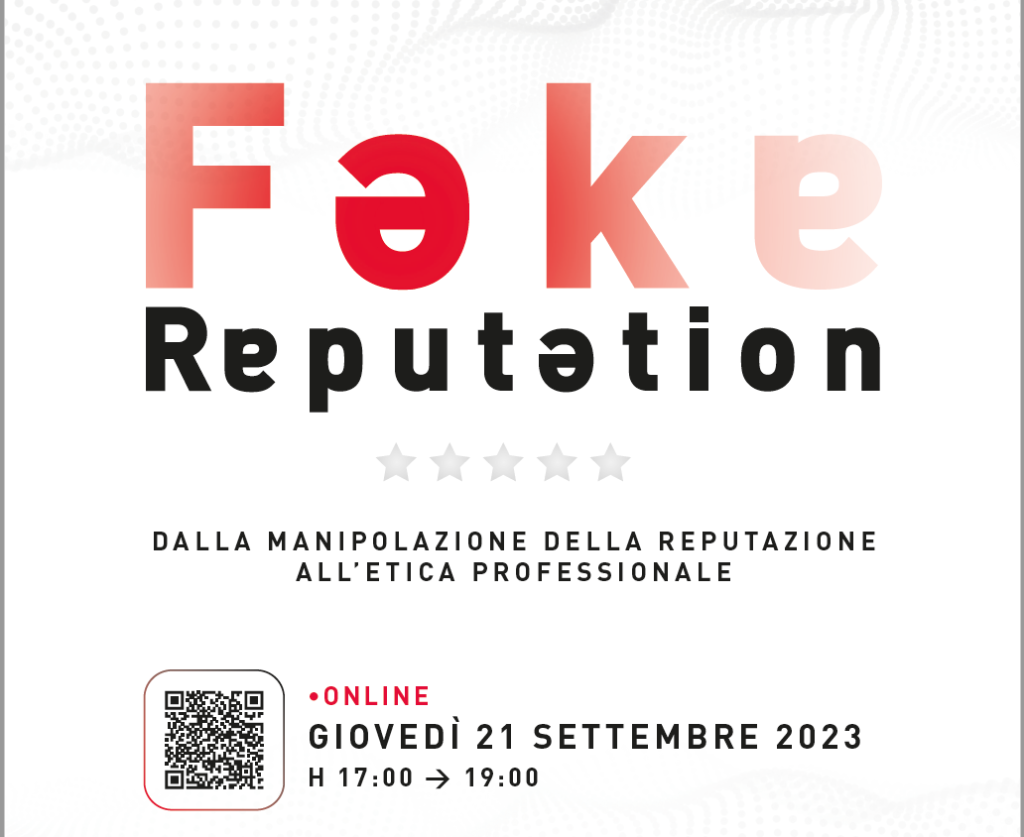Debutto da record per il film Barbie con un incasso di 2,178 milioni di euro nel suo primo giorno di programmazione in Italia. Risultato che rappresenta la miglior apertura al box office del 2023 oltre a numerosi primati nel giorno di esordio nel nostro Paese, tra cui quelli di quarta miglior apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures, secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia, terzo miglior debutto di sempre per un film uscito nel mese di luglio, miglior debutto per un film con Margot Robbie e miglior debutto per un film con Ryan Gosling.
In visione da ieri, giovedì 20 luglio, su oltre 600 schermi cinematografici della penisola, Barbie ha richiamato nelle sale più di 284.000 spettatori.
Un fenomeno che deve questi risultati ad attività di promozione ben pianificate e ad una distribuzione attenta, spiega Andrea Roselli, Director of Theatrical Distribution di Warner Bros. Discovery Italia, raggiunto da e-duesse.it: “Warner Bros. Discovery Italia è oltremodo entusiasta di aver creduto fermamente nella data di uscita di Barbie ‘day and date’ al 20 luglio, dimostrando che il cinema può prosperare anche durante la stagione estiva. Il successo travolgente del film è il frutto di attività straordinarie ed uniche di ‘publicity’ e di una strategia di marketing ben pianificata, di una promozione incisiva e di una distribuzione attenta, capillare e minuziosa che ha saputo raggiungere e coinvolgere il pubblico in un momento in cui le attività estive sono molteplici e variegate”.https://www.youtube.com/embed/WaOn1q0PHoE
BARBIE, IL LANCIO DEL FILM
Una delle strategie usate per pubblicizzare il film è stata quella di metterlo al centro dell’attenzione per mesi, creando molta attesa. Le attività hanno coinvolto numerosi settori, dai social, con speciali filtri Instagram, al digital, con le stelline rosa su Google che compaiono digitando query relative al film, dalla moda ai videogame.
Restando in ambito social network, ecco la campagna in AR realizzata da Warner Bros. Discovery con Snapchat, con la nuova lente dedicata al film con protagonista il brand di Mattel, grazie a cui ragazzi e ragazze possono indossare il look degli attori Margot Robbie e Ryan Gosling, ispirati agli abiti del film. Warner Bros. Discovery si avvale della tecnologia di Snapchat anche per trasformare alcuni dei monumenti in giro per il mondo e tingerli con i colori di Barbie. In Italia è il Colosseo a tingersi di rosa grazie alla nuova funzione del social.
Tra gli eventi è stato coinvolto il quartiere Porta Nuova di Milano, dove dal 14 al 23 luglio una serie di attività offriranno alle persone l’opportunità di immergersi nel magico mondo di Barbie. Tra le iniziative, una “Barbie Doll box” a tema, riproducente in grande l’iconica scatola di Barbie, dove sarà possibile farsi delle foto ascoltando i brani della colonna sonora del film. Qui si possono creare dei video e condividerli su TikTok, utilizzando il brano “Dance The Night” di Dua Lipa. Inoltre sarà lanciato un concorso, in cui una giuria tecnica selezionerà le 30 migliori foto pubblicate su Instagram.
Concorso anche per Uci Cinemas, che ha messo in palio un viaggio a Malibù: acquistando tramite i canali online del circuito il biglietto per assistere alle proiezioni fino al 28 luglio. e registrandolo entro il 2 agosto sul sito barbie.ucicinemas.it, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione e visitare i luoghi che hanno ispirato il mondo dell’iconica bambola.
Per il lancio si è attivato anche il mondo dei videogiochi, grazie a Xbox: i fan di Barbie potranno seguire le sue orme con una rosa di novità come contenuti esclusivi di Forza Horizon 5 ispirati al film, un video sulle carriere con un tocco di Barbie, le prime bambole Barbie di Xbox e, inoltre, l’hardware Xbox personalizzato. E’ stata lanciata anche una linea di Barbie equipaggiata con accessori Xbox Gear.
Sono state quindi numerose le collaborazioni che hanno coinvolto i brand, da Zara a Primark, per arrivare a Airbnb, NYX, Superga, Crocs, Burger King Brasile con un nuovo panino rosa e Selfridges, così come tante sono state le iniziative messe in campo nei mesi scorsi.
Un debutto che è diventato un vero e proprio fenomeno, già nei mesi scorsi, anche per quanto riguarda la ricerca di accessori e abiti a tema: Stileo, aggregatore fashion con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 marchi e 7 milioni di visite mensili, ha annunciato che le ricerche del termine “Barbie” sono cresciute del 955 % mentre tutti i prodotti di moda con tag “Barbie” hanno registrato una crescita nei click del 450%.
Il trend ha portato la piattaforma di trading e investimenti eToro a realizzare un ricerca sugli utili che il fenomeno è in grado di produrre. Mattel negli ultimi tre mesi ha visto salire il prezzo delle azioni del 22%, nonostante un inizio d’anno incerto.
UN PROGETTO CHE CAMBIA IL MONDO DEL BRANDED CONTENT
Il debutto del film sul grande schermo è il culmine della lunga storia del brand e del suo percorso che inizia a metà del Novecento e in cui non sono mancati momenti di crisi, affrontati con un attento lavoro di riposizionamento, che ha portato Barbie a diventare da giocattolo a lifestyle brand.
La bambola magra e bionda, simbolo di bellezza innarrivabile, che rappresentava un ragazza interessata a moda e vacanze, spesso al centro di critiche per questi motivi, si è evoluta nel tempo fino ad essere proposta come donna indipendente ed è stata affiancata da innumerevoli varianti, con bambole da diversi aspetti e rappresentanti professioni differenti. In questo modo negli ultimi anni Barbie, anche grazie a campagne pubblicitarie come “Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri”, si è presentata come simbolo di empowerment femminile e diversity. Le linee di prodotto oggi sono pensate per stimolare il potenziale illimitato di bambini e bambine, con bambole che presentano differenti colori degli occhi, colori e trame dei capelli, tipi di corporatura, disabilità e stili.
Negli ultimi anni, il brand di Mattel ha dato sempre più peso all’entertainment, con contenuti per tutti e su tv, streaming, YouTube e audio. Citiamo, ad esempio, “Il mondo fatato di Barbie Dreamtopia” su Frisbee e in arrivo dopo le vacanze su Cartoonito, e “Barbie Epic Road Trip” su Netflix, il primo film interattivo di Barbie.
In ottica awarness, sono state inoltre diverse le partnership per prodotti a marchio Barbie, come in Italia le uova di Pasqua di Kinder, i veicoli radiocomandati di Mondo Motors, la fotocamera istantanea Barbie Print Cam con Lisciani, gli snack di San Carlo e ancora le linee realizzate con Tezenis, Original Marines, GAP. Presto saranno annunciate nuove partnership.
Il film si inserisce in questo processo di riposizionamento con l’obiettivo di far conoscere il giocattolo alle nuove generazioni e farlo ricordare a quelle precedenti. Tra i temi trattati nel film e al centro dei dibattiti sulla stampa e sui social, ci sono, infatti la sfida agli stereotipi di genere e al patriarcato.
Ma la pellicola potrebbe segnare l’avvento di un nuovo modo in cui i brand pubblicizzano i loro prodotti. Ormai lontano dal tradizionale spot che interrompe la visione dei contenuti, il progetto di Barbie sembra anche andare oltre il branded content: in questo caso, il marchio ha prodotto il film (con Mattel Films) mantenendolo in linea con i suoi valori, per connettere consumatori e investitori in una maniera innovativa. Tra i brand presenti nel film con attività di vero e proprio product placement figurano Chevrolet, Birkenstock e Chanel, protagonisti in diverse scene.
In quest’ottica Mattel ha anticipato di essere al lavoro su altri numerosi film basati su altri marchi, come ad esempio Hot Wheels.