Lione “spegne” i cartelloni pubblicitari, soprattutto quelli luminosi

Lione sarà presto la prima città senza cartelloni pubblicitari, o quasi. Il consiglio municipale della città francese infatti martedì scorso ha adottato un nuovo regolamento sulla cartellonistica locale, che contiene numeri importanti: entro il 2026, nell’area di Lione, sparirà ben il 90 per cento dei cartelloni pubblicitari, soprattutto quelli luminosi.
Una scelta fortemente voluta da Bruno Bernard, presidente ecologista della Metropoli di Lione, entità che comprende la vecchia comunità urbana di Lione con tutti i suoi 59 comuni e la parte del dipartimento del Rodano rientrante in tale comunità, che non ha mai mancato di sottolineare il dato che “ogni giorno ciascuno cittadino di Lione è bombardato da una mole di messaggi pubblicitari stimata tra 1.200 e 2.200”. Ma anche Gregory Doucet, sindaco di Lione (capoluogo dell’omonoma città metropolitana) ha accolto con grande favore la novità: “Basta con i maxi-teloni sulle facciate dei palazzi, con le insegne illuminate di notte, con le pubblicità invadenti vicino alle scuole: il nostro spazio pubblico merita di meglio”.
Inquinamento visivo e consumo di energia
Una scelta etica, dunque, ma legata anche e soprattutto al tema dell’inquinamento visivo e di consumo di energia: il regolamento prevede infatti lo spegnimento obbligatorio delle insegne luminose alle ore 19 per le zone a bassa attività economica e alle ore 23 per le zone ad alta attività economica. Vietati anche i maxi cartelloni pubblicitari che coprono quasi per intero i palazzi, “ad eccezione dei teloni sui monumenti storici gestiti dallo Stato”, la pubblicità privata intorno a oltre il 95 per cento delle scuole, le pubblicità digitali.

Il regolamento entrerà in vigore il 4 luglio, ma ci vorranno due anni perché scatti effettivamente il divieto, dal momento che i gestori degli spazi pubblicitari “avranno due anni per essere messi a norma”, estendibili fino a sei anni “per dare a professionisti e commercianti il tempo di familiarizzare con le normative e adeguarsi ad esse”. In discussione da molti anni ma votata per la prima volta nel dicembre 2021, il nuovo regolamento aveva provocato il malcontento di molti imprenditori, prima di essere anche contestata lo scorso gennaio dalla commissione d’inchiesta pubblica.

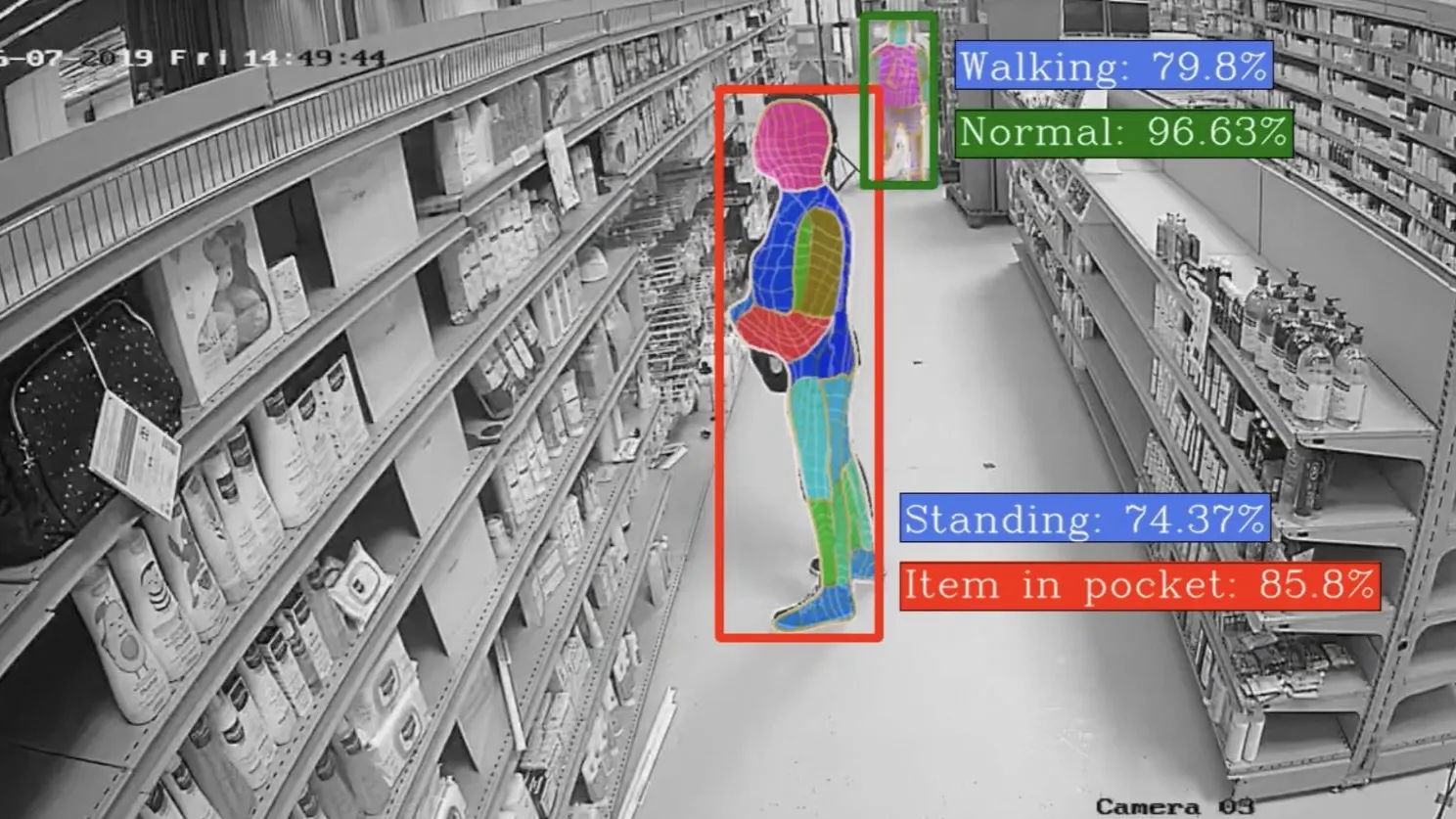
.jpg)

