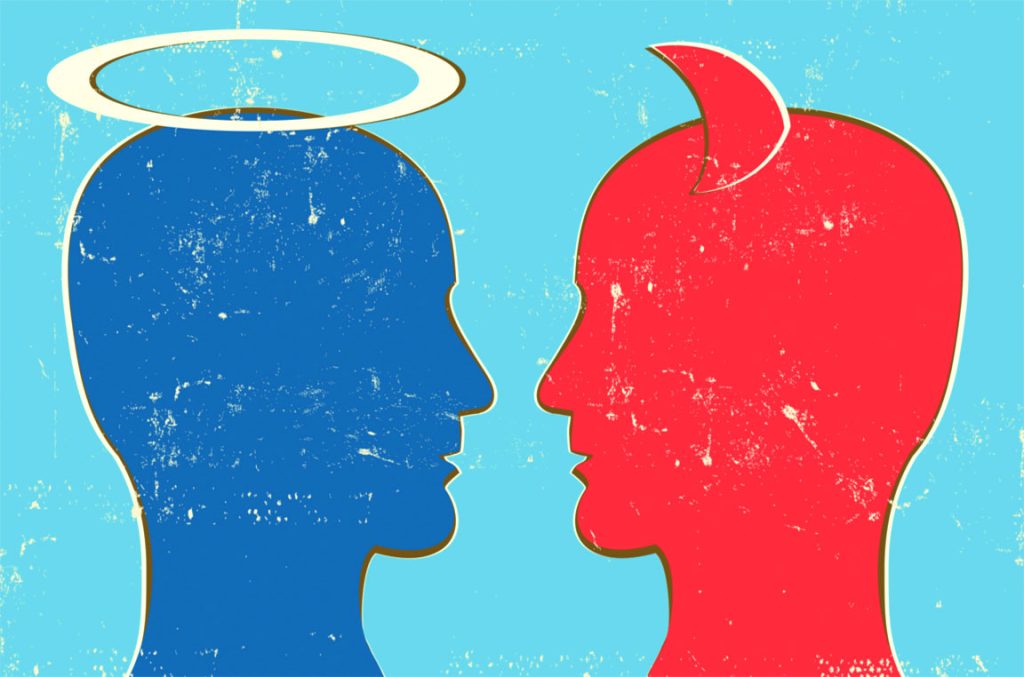Un’intervista choc rilasciata da Massimo Guastini sta facendo discutere – fin qui dietro le quinte, e vedremo perché – l’intero mondo della pubblicità italiana, e non solo: esiste oggi, post #Metoo, un tema relativo agli abusi e violenze sessuali nel mondo glamour dei creativi pubblicitari italiani? E ancora: come reagire, se le stesse interessate non denunciano? E più nello specifico: c’è qualche noto protagonista del settore che si è reso impunemente “colpevole” di questo genere di abusi, tacitati da parte delle stesse vittime per paura di ritorsioni? Il terreno – come mi ha ben rappresentato un amico e stimato collega – è assai sdrucciolevole, quindi andiamo per passi, e vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I protagonisti
Massimo Guastini è un pubblicitario dal 1983, ed è l’artefice di moltissime campagne pubblicitarie nazionali di successo, tra cui quelle di eBay, Jaguar, PayPal, EasyJet, Siemens, Il Sole 24 Ore, Badedas, Champion, Abbey National Bank, Yamaha. È stato per due mandati il Presidente dell’Art Directors Club Italiano (ADCI), che è l’associazione che da quasi 40 anni riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria in Italia.
Pasquale Diaferia – analogamente – è un altrettanto famoso pubblicitario, conosciuto nell’ambiente e in generale dal pubblico per la famosa campagna “Toglietemi tutto, ma non il mio Breil”, ma anche per essere l’ideatore di altre campagne nazionali per noti marchi come Barilla, Moschino, Olivetti, Panorama: insomma, che esista il presupposto dell’esistenza di un interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti, allo scrivente pare assodato.
Perché secondo Guastini, Diaferia – che, è bene subito specificarlo, non è stato mai condannato per un reato del genere, e pare, per quanto pubblicamente noto, neppure indagato o denunciato – sarebbe un molestatore e abusatore seriale di giovani e meno giovani colleghe pubblicitarie o tirocinanti. E Guastini questo non lo confida nel silenzio delle sacre stanze delle agenzie dei creativi, ma lo dice forte e chiaro, in un’intervista pubblicata online ieri sui Social, a firma di Monica Rossi, nom de plume di un personaggio noto nel mondo dell’editoria che intervista scrittori, giornalisti e persone di un certo spessore intellettuale.
I fatti, per come sono raccontati
L’autrice dell’intervista a un certo punto chiede a Guastini (riporto verbatim): “Veniamo alla domanda personale. Io ho intuito che nel Vostro mondo, il mondo della pubblicità, attualmente ci sia un problema di molestie sessuali. È così?”
E Guastini risponde convinto: “Sì, è proprio così” . Ma aggiunge, sorprendentemente:
E di uno di questi molestatori seriali conosciamo bene il nome e il cognome: Pasquale Diaferia. E la questione è tornata d’attualità recentemente visto che è stato nuovamente invitato dall’ADCI (il Club dei pubblicitari, ndr) a fare il mentore, vale a dire incontrare giovani professioniste del settore pubblicitario per valutarne il talento ed eventualmente favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.Ruolo e funzione per i quali servirebbero, secondo me, requisiti morali estranei a Diaferia. Perché nel ruolo di mentore dovremmo mostrare il meglio del nostro lavoro e non il peggio dell’essere umano.
L’intervistatrice aggiunge: “Ma è un caso isolato?”
“No, non lo è”, dice Guastini, che precisa a sua volta:
Potrei parlarti di una famosa chat in cui diversi uomini catalogavano e davano i voti chi al culo, chi alle tette, chi alle gambe di queste giovani stagiste che potevano essere le loro figlie. Agenzia di pubblicità molto famosa, molto potente, molto importante. Una sera a cena con due colleghi che sono divenuti anche amici, le due ragazze scoprono di una chat tra maschi e chiedono di cosa parlino. Uno dei due ragazzi mostra loro la chat. Comprende almeno 80 uomini. Quasi tutti quelli che lavorano nell’agenzia, dagli stagisti ai capi reparti. Manca solo il grande capo. Restano agghiacciate. Decine e decine di messaggi ogni giorno. Un solo argomento: quanto sono scopabili, fighe, ribaltabili o cesse le colleghe. Una chat che si svolge in ambiente di lavoro, durante l’orario di ufficio, con una sfilza infinita di messaggi espliciti, degradanti e umilianti. Si va da un capo Team che parlando di una sua sottoposta (con il suo nome e cognome) scrive: “glielo infilerei così tanto nel culo da farle uscire le palle dalla gola” a un nuovo arrivato nel Team, nemmeno da due settimane, che parla così di una collega: “è talmente cessa e grassa che le infilerei un sacchetto in testa e me la scoperei comunque, di prepotenza.” Il tutto in una chat, vale la pena ricordarlo, lavorativa in cui i membri più attivi sono i capi dei vari Team di lavoro. Arrivano a scoprire anche l’esistenza di foglio Excel che non contiene numeri e voti ma i nomi delle proprietarie dei più bei culi femminili in azienda.
“Tu credi veramente che Pasquale Diaferia sia un molestatore?”, incalza a quel punto l’intervistatrice… E Guastini:
Cercherò di essere chiaro. Io non so se Pasquale Diaferia sia attualmente un molestatore sessuale. So per certo che lo è stato tra il 2007 e il 2016. Perché me l’hanno raccontato una dozzina di ragazze (…) Io sino al 2011 ignoravo questo suo “vizietto”. Le cose cambiarono appunto quando una stagista che lavorava nella mia agenzia mi raccontò la sua esperienza diretta. Ed era letteralmente scioccata. Si erano incontrati in un’occasione pubblica e avevano cominciato a parlare della professione comune: la scrittura per la pubblicità. Lei aveva 20 anni e lui 50. Si offrì di accompagnarla a casa. Invece parcheggiò in una zona isolata e tentò approcci sessuali inopportuni dal momento che lei continuava a respingerlo. Non ci fu stupro, ma decisamente quelle furono molestie sessuali.
L’intervistatrice pressa Guastini, gli chiede come fa lui a sostenere questa accusa, e lui risponde convinto:
Temendo che non le credessi, mi mostrò una lunga chat avvenuta su Skype, tra le 22 e le 23 dell’otto gennaio. Anche quella conversazione era una molestia sessuale reiterata. Lei alla fine decise di rinunciare alla denuncia perché sarebbe stata la sua parola contro quella di lui nonostante quell’aberrante conversazione telematica.
E ancora: “Ti risulta solo quest’episodio?”. Risposta di Guastini:
Solo quell’episodio? Purtroppo quella è solo una delle storie ignobili in cui mi sono imbattuto. Ad esempio verso la fine del 2016 due socie dell’ADCI mi segnalarono la storia di una ragazza che aveva subito molestie sessuali chiedendomi se potessi dare visibilità alla vicenda anche senza fornirmi il nome della ragazza. Lessi la testimonianza della vittima. Feci una domanda alle due socie ADCI: “le iniziali di questo professionista sono P.D.?” Sì, mi risposero è Pasquale Diaferia. Poi il 27 settembre pubblicai un post e il giorno dopo mi arrivarono tre testimonianze da delle ragazze che l’avevano riconosciuto dal modus operandi. E mi contattò anche un uomo, amministratore delegato di un’agenzia, la cui moglie gli aveva raccontato di aver subito un’esperienza analoga sempre con lo stesso soggetto: Pasquale Diaferia. Andiamo avanti. Una sera, che per me fu drammatica, mi contattò una giovane donna, sui 30 anni. La sua è sicuramente la storia peggiore tra quelle di cui ho avuto una testimonianza diretta.
Qui la versione di Guastini si fa disturbante, molto forte:
La incontrai il 30 settembre 2016, in un bistrot. Si era portata dietro anche un block-notes dove aveva annotato tutto. Piangeva e parlava, parlava e piangeva. La sua storia oltre a essere la peggiore era molto recente, e ben lungi dalla prescrizione. Mi raccontò di aver preso un caffè shakerato con Pasquale Diaferia e poi di essersi ritrovata a letto con lui che dormiva, stordita e confusa. Soprattutto non poteva capacitarsi di avere trascorso la notte con un uomo che aveva sempre percepito come viscido e sgradevole. Ricordava benissimo il caffè shakerato ma nebbia totale sul come da quello si fosse arrivati al letto. “È folle pensare che mi abbianarcotizzata e violentata?” mi chiese la donna. Ebbene, tutte queste ragazze sono delle povere pazze? Perchè la storia non è mica finita. In seguito mi contattò una donna, una certa Annita Lucrezia Barberi, che aveva delle informazioni su quella e altre vicende. E questa donna è l’ex moglie (di Diaferia, ndr). A un certo punto della nostra conversazione, dopo che mi raccontò delle cose agghiaccianti, pensò bene di salutarmi con queste parole: “Sono stata la moglie di Pasquale per 34 anni fino ad agosto dello scorso anno. Con lui ho avuto quattro figli e un nipote. Ti dico solo questo: tre su quattro dei suoi figli mi hanno chiesto di non informarli quando lui morirà.
“Eppure sulla sua bacheca sembra che lui continui a scrivere che contro la Sua ex moglie in Tribunale abbia vinto lui tutto quello che c’era da vincere”, richiama l’intervistatrice.
E Guastini:
(…) Vuoi sapere i fatti? Pasquale Diaferia ha perso il processo in primo grado (sentenza del 15 marzo 2020). Poi ha perso anche in appello (sentenza 9 giugno 2021 esattamente due anni fa). È anche importante sapere perché ha perso. Ecco, di seguito riporto pari pari le motivazioni delle due sentenze: “…rilevanti i ripetuti episodi di violenza e di maltrattamento, perpetrati dal Signor Diaferia ai danni della Signora Barberi, come peraltro emerso dalle testimonianze dei tre figli maggiorenni, dai verbali del Pronto Soccorso e dalle innumerevoli denunce sporte” (…). Come vedi, Pasquale Diaferia scrive menzogne su menzogne. Tra l’altro con che coraggio proprio non lo so.
L’ultima domanda dell’intervistatrice a Guastini apre il tema dell’omertà generata dalla paura di ritorsioni, salito agli onori delle cronache mondiali con il #Metoo: “A proposito di denunce: sai dirmi perché a oggi Pasquale Diaferia non è, ad esempio, in galera?” Guastini risponde netto: “
Banalmente? Perché tutte le vittime hanno avuto e hanno paura di denunciare. Uno, perché non vogliono rivivere quel trauma, due perché hanno bisogno di lavorare e gravitano nel medesimo ambiente, tre per la vergogna, quattro per la paura di ritorsioni e cinque per il terrore di non essere credute e tutelate. Tu però Monica puoi dire che ti ho fatto vedere una dozzina di testimonianze firmate con nomi e cognomi? Lo puoi dire per favore?
L’intervista si chiude quindi con l’ammissione dell’intervistatrice: “Si, confermo che ho letto molte di queste testimonianze. Di mio, aggiungo che ho contattato alcune persone per avere una conferma diretta, e tutte hanno confermato. Pasquale Diaferia non è un personaggio moralmente idoneo al ruolo di mentore di giovani pubblicitarie. E chi gli offre visibilità, che sia un ruolo di portfolio reviewer, di speaker, di insegnante o di articolista su testate di settore, alla luce di tutto ciò, dovrebbe – almeno – dichiarare che Pasquale Diaferia è completamente estraneo alle vicende sopra riportate. Altrimenti si chiama complicità”
L’intervistatrice riferisce anche di aver contattato ripetutamente Pasquale Diaferia, via Facebook, per ottenere un commento o una smentita rispetto al contenuto delle dichiarazioni di Guastini, proponendo anche a lui un’intervista con le stesse modalità e dello stesso ingombro, ma che lo stesso ha rifiutato.
La reputazione, al di la del merito
Pasquale Diaferia è colpevole di aver molestato e abusato di giovani donne e colleghe? Secondo Guastini, confortato dalle sue fonti di prima mano, si, ma in realtà l’accusato non solo non è mai stato condannato, ma – come abbiamo premesso in apertura – da ciò che risulta, ad oggi, neppure indagato o denunciato.
Il grado di colpevolezza – vera, presunta, accertata, o per contro completamente inesistente o inventata – di Diaferia, però, non riduce di una piuma il peso della vicenda sotto il profilo squisitamente reputazionale.
Come ben sappiamo – e come abbiamo scritto centinaia di volte nelle nostre analisi, che si intendono qui integralmente richiamate – al giorno d’oggi la reputazione è (quasi) tutto, e va ben oltre il “parlar bene o parlar male”: come insegnano i fondamentali del reputation management, reputazione è eguale a valore, orienta i comportamenti di acquisto e può fare la fortuna (o la distruzione) di un brand. E il personal branding è altresì incluso in questo perimetro: il profilo di ogni singolo professionista, in quest’epoca così fluida e disintermediata, è condizionato pesantemente dalla licenza di operare che gli viene concessa dalla comunità, che è a sua volta condizionata dalla sua (buona o cattiva) reputazione. Anche per questi motivi, le buone prassi di crisis communication suggerirebbero all’accusato una chiara e inequivoca presa di posizione (che non esiteremmo ad ospitare anche in questa rivista, con la giusta enfasi), che trovi nella tempestività uno dei suoi punti di forza: nel XXI secolo il banalizzante “no comment” non trova decisamente più spazio (letteratura pacifica).
Anche se tutte le accuse a Diaferia fossero state completamente inventate di sana pianta, e chi lo accusa fosse solo un “diffamatore”, la querelle Guastini versus Diaferia esce quindi – per entrambi, beninteso – da un perimetro relativo alla “morale”, al giusto e allo sbagliato, allo scontro personale, e diventa fin da ora un caso di studio sotto il profilo reputazionale, del tutto a prescindere da cosa possa essere realmente successo a quelle ragazze e a quelle donne. Nulla, spero, per loro, ma… to be continued.
AGGIORNAMENTO del 11/06/23 h 17:15: a seguito molto probabilmente del pubblico dibattito sollevato negli ultimi giorni sul Suo caso, Pasquale Diaferia è stato espulso – con votazione all’unanimità – dall’ADCI – Art Director Club Italiano.
AGGIORNAMENTO del 15/06/23 h 11:58: pare che l’agenzia pubblicitaria della quale si parla nell’articolo (quella della chat misogina e sessista) sia stata individuata, con conseguente sviluppo di un acceso thread di discussione su Facebook. Crisi reputazionale d’impatto nazionale alle porte…?