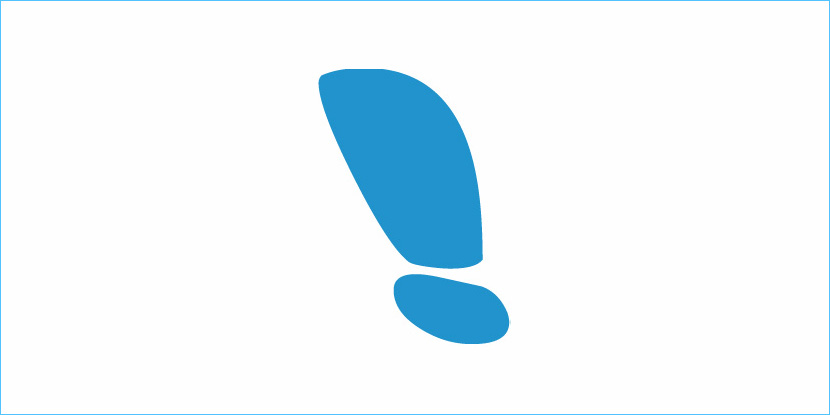Per approfondire il nesso tra sviluppo e greenwashing c’è una premessa doverosa:ognuno desidera che la Sostenibilità sia centrale nel processo di sviluppo.
La ragione è semplice: sono i consumatori, la gente si è accorta che il degrado ambientale e sociale ha raggiunto livelli tali che la vita lasciata andare così è invivibile. Il clima è in rivolta, la siccità conseguente sta impoverendo le culture agricole ed il territorio.
Il Pianeta è fragile: ad esempio gli Stati Uniti stanno avvertendo nella Costa Ovest cambiamenti climatici mai visti con distruzioni del territorio; in Italia, se il Nord è piagato dalla siccità, il Sud è martoriato sempre di più da un clima incerto e di natura tropicale.
In Italia alcune regioni del Nord vedono sparire velocemente le coltivazioni che davano lavoro e prodotti ai cittadini: riso, grano, frutta, verdura, ecc..
Nonostante questi fatti che reclamano profondi cambiamenti non si può negare che il Greenwashing è conveniente:
- Costa meno: investire 100K in pubblicità è più economico che cambiare veramente la catena di produzione e i metodi di smaltimento;
- Il consumatore sensibile alla tematica ambientale generalmente è inattivo nel concreto per migliorare le cose. Spesso gli basta sapere che quel prodotto è green rispetto ad un altro. Non chiede di conoscere le pratiche green: se lo pretendesse il prodotto costerebbe di più: Probabilmente le vere informazioni non sono accessibili al cliente.
- Nessuno indagherà sul prodotto che riporta la scritta: “Naturale al 100%” anche se non è vero, anche se contiene prodotti vietati e pur citati nella griglia dei componenti, come ha recentemente dimostrato Striscia la Notizia.
- Se si teme che la menzogna venga scoperta si fanno “opere di compensazione”: si annunciano investimenti per la crescita di nuovi alberi nell’Amazzonia per la riduzione del CO2 corrispondente all’Anidride Carbonica prodotta nella produzione. Analoga ragione hanno spesso l’iniziativa verso il Terzo Settore per le categorie fragili, forse toccate dall’inquinamento di acque o rifiuti.
Come si riconosce il Greenwashing? :
- Nella pubblicità, nel sito, o direttamente sul prodotto si fa riferimento alla Parola Green;
- Si fa cenno a Eco Bio senza certificazioni;
- La Grafica incentrata su Green o al colore verde senza altre informazioni;
- I testimonial parlano di Bio o Green senza dare notizie;
- L’head Line porta la scritta Sostenibile senza spiegare il perché.
La pratica più comune nella comunicazione che sostiene il greenwashing è aggiungere al Brand l’aggettivo Sostenibile.
Alcuni grandi esempi che hanno fatto notizia sul WEB:
- Ha fatto scalpore la sponsorizzazione di Coca Cola della Conferenza sul Clima delle Nazioni unite. Il Guardian ha scritto: “E’ sconcertante che Coca Cola il più grande inquinatore di plastica del mondo in tutti gli audit Globali di Break Free From Plastic sponsorizzi la Conferenza delle parti in Egitto, (quando è noto) che Coca Cola produce 120 miliardi di bottiglie di plastica usa e getta all’anno.”
Coca Cola ha immediatamente risposto sul Sito italiano:
“Non abbiamo sprecato un giorno e abbiamo trasformato in realtà il nostro desiderio di avere una bottiglia realizzata totalmente in plastica riciclata. I nostri packaging sono già tutti 100% riciclabili e questa nuova bottiglia è solo l’ultimo passo per rendere il nostro impegno ancora più tangibile e sempre più concreto il concetto di economia circolare.”
- Anche la Sponsorizzazione di ENI al Festival di Sanremo ha fatto rumore, infatti Greenpeace alla terza serata ha fatto presente che “Eni inquina anche la musica”
Ha ricordato infatti la sentenza del TAR del Lazio che ha confermato che ENI dovrà pagare la multa di 5 milioni di Euro per pubblicità ingannevole del Diesel+ presentato come “verde” anche se non possiede alcuna caratteristica di reale sostenibilità ambientale.
- Un tempo poteva passare l’idea che il dentifricio COLGATE era il migliore perché conteneva il GARDOL. L’azienda avrebbe dovuto spiegare bene cosa era il Gardol, e quali benefici portava con sé, quale istituto di ricerca aveva rilasciato un certificato che attestava le sue qualità. E’ rimasto un mistero.
Oggi si sa che il Gardol è un fertilizzante.
- Ci sono esempi da ammirare, ne cito uno: lo SPOT SAVIOLA.
E’ evidente nel filmato che non si tagliano gli alberi, anzi che c’è una cura per il verde. E’ detto che i prodotti della azienda sono frutto della applicazione dell’economia circolare attraverso il truciolato di legno dismesso.
Ho portato esempi di cosa dice il mondo web quando racconta di Greenwashing, credo che come per Coca Cola anche in Eni avranno operato per cambiare l’approccio alla sostenibilità.
Il tema della Reputazione è troppo importante.
Si portano avanti iniziative che arrivano ad un certo livello di informazione sulla Sostenibilità, si tralasciano ulteriori passaggi ritenuti inutili che offrirebbero un completo realismo se si offrissero delle garanzie quantificabili.
Ora alcuni esempi:
Nestlé fa cenno al ritiro delle capsule usate; nello Spot non si fa menzione del riuso delle stesse: non si immedesima nel consumatore che per la consegna spesso deve fare lunghi percorsi costosi. Sembra che la Sostenibilità debba diventare un’opera del cliente e non della azienda.
Yamamay ad esempio fa accenni alla linea Sostenibile, alla attenzione alle fibre, alla distribuzione ma non spiega di che si tratta. A nostra opinione sembra più un desiderio di offrire una “sostenibilità” che fa mentalità più che una serie di informazione sulla trasformazione delle linee produttive. Sulla logistica e distribuzione non si sa cosa immaginare. Infine sulle taglie: vi sono prodotti per tutti?
Galbani annuncia con enfasi che “accelera sulla sostenibilità: dal 2022 la confezione della mozzarella Santa Lucia Tris il nuovo packaging conterrà il 15% in meno di plastica. Un importate passo avanti dell’azienda verso l’obiettivo di rendere sempre più rispettoso dell’ambiente gli involucri dei suoi prodotti”. La Galbani stima di risparmiare 100 tonnellate di plastica in un anno. La dichiarazione valoriale è ben descritta. “la nostra strategia è di portare avanti sempre più azioni come questa, con l’obiettivo di fare di Galbani una realtà in prima linea per la salute del pianeta”
Questi tre esempi dimostrano l’attenzione alla Sostenibilità delle aziende, ma nel contempo la fatica per completare tutta la filiera produttiva e distributiva. Il cammino è iniziato e lodevolmente si può immaginare che verrà portato a termine.
Chiediamo che venga comunicato a tutti.
C’è infine un socialwashing che va smascherato:
Rileggiamo ancora il Bilancio di Sostenibilità: normalmente sono una vetrina degli obiettivi raggiunti, vi sono le notizie che dimostrano il legame tra innovazioni prodotte e Goals della Agenda 2030.
Manca qualcosa, una vera trasparenza.
- Non sono segnalati i mancati obiettivi raggiunti.
- Gli insuccessi.
- I progetti per migliorare il proprio cammino verso lo sviluppo sostenibile.
- Le relazioni con gli Stakeholders e le difficoltà.
- Le problematiche relative alle relazioni interne con il personale.
Non è una mancanza di verità anche questa?
La trasparenza è la misura dell’operare. Il consumatore sa stimare le difficoltà per raggiungere obiettivi. I problemi che sorgono.
La comunicazione veritiera è quella sempre vincente.
Siamo convinti che ogni impresa tende a fidelizzare il proprio Brand con il cliente.
Raccontare con sincerità la storia aziendale, i prodotti e i propri obiettivi presenti e futuri, le cose raggiunte e quelle da raggiungere, sia un passaggio decisamente importante.
La sostenibilità è un processo culturale che ha bisogno della cura della tecnologia innovativa per respirare cambiamento, impegna tutta l’azienda (dalla proprietà al management agli operatori finali e la distribuzione), ha del cammino da fare con progetti da realizzarsi in un certo tempo, deve comunicare tutto ciò.
Non è facile.
I media ora sono davvero moltissimi.
E’ indispensabile trattarli per quello che possono offrire.
Non va dimenticato il racconto: quello che spiega la verità di un processo produttivo, la difficoltà e la fatica per raggiungerlo ed infine la linea valoriale che ha guidato l’impegno di tutti
Questa è la garanzia di una buona relazione con gli stakeholders.
Una garanzia di buona Reputazione.