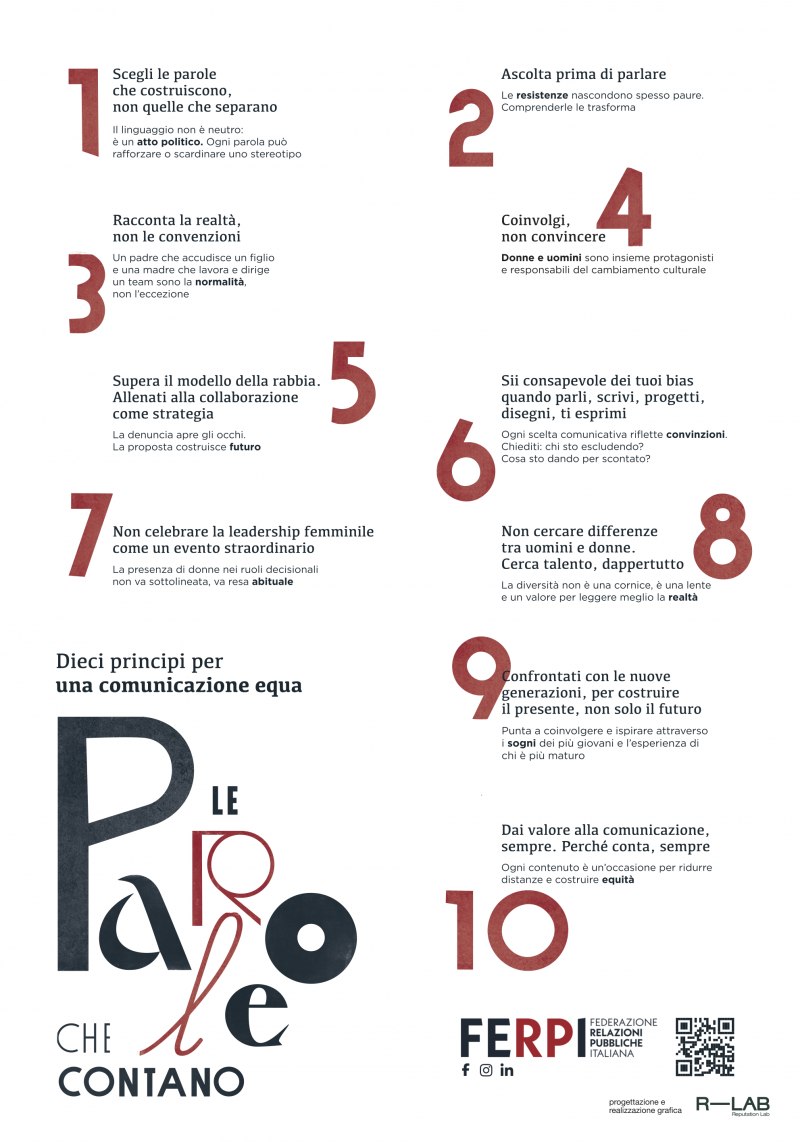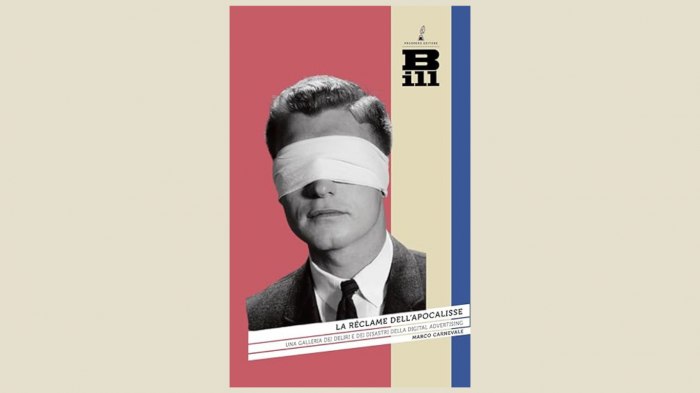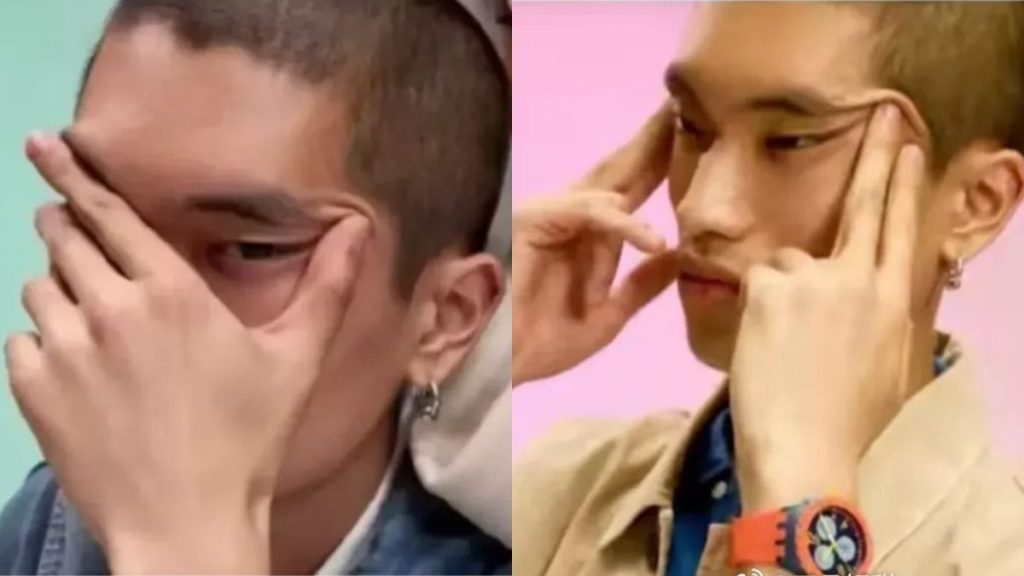Anche oggi nessun miracolo: ancora un’opinionista che parla di cose che non conosce. E, nel mentre, la Strazzer (finalmente) risponde alle critiche

Che disagio rispondere alla Soncini, che critica gli esperti di crisis communication della domenica facendo lei esattamente la figura dell’esperta di crisis communication della domenica. Perché è vero che giornalisti e opinionisti quello fanno: scrivono e parlano, e la Soncini è anche una bella penna; ma ci si aspetterebbe che scrivessero e parlassero di ciò che sanno, non che sproloquiassero a caso.
E invece niente, non ce la possiamo fare: tutti, ma proprio tutti – pubblicitari, esperti di marketing, social media manager, copywriter, e via discorrendo – si sentono in dovere di dire la loro, aumentando il rumore di fondo, su una materia – la gestione delle crisi reputazionali – sulla quale sono state scritte enciclopedie, e che sta alle normali tecniche di comunicazione come la neurochirurgia di precisione sta alla medicina.
Sul caso Strazzer è stato detto tutto e il contrario di tutto; ovviamente, dal momento che la diretta interessata ha deciso che l’opinione pubblica non era sufficientemente degna da meritare che lei sprecasse qualche minuto – nel suo stesso interesse, peraltro – per spiegare dove sta la verità. Con il risultato che, come ci insegna la fisica, dal momento che il vuoto in natura non esiste, è stato colmato dalla qualunque.
Ciò che sappiamo, e che la ragazza oggetto della querelle sollevata da un servizio della giornalista Charlotte Matteini, era stata assunta prima della maternità con grande fiato di trombe, per poi venir licenziata appena rientrata sul posto di lavoro. In quell’azienda – che è pure un bel progetto – “forse la bocca non parla con la testa”, avevo scritto io commentando il caso su un quotidiano qualche giorno fa. Scrivo forse, perché la Strazzer non ci ha illuminato a riguardo; e forse – dice qualcuno – la ragazza ha lavorato anche durante la maternità (cosa vietata dalla legge, peraltro), ma la Strazzer tace anche su questo, quindi non sappiamo cosa pensare; e ancora forse – ha scritto qualcun altro – il lavoro che ha fatto non è piaciuto, e di lì il “benservito”, ma la Strazzer eccetera.
Secondo la Soncini, comunque sia andata, bene ha fatto Strazzer a non prendere la parola: promossa con lode. Ma non funziona così, e si studia nel primo semestre di università: non esiste un solo caso realmente accaduto di problema reputazionale nell’epoca dell’infosfera nel quale tacere abbia risolto più rapidamente la crisi, o abbia aiutato a far scendere la curva gaussiana delle polemiche. Non uno, davvero: il tema non è se parlare o no, ma, casomai, come prendere la parola, quando e cosa dire. Ed è un lavoro di fino, che richiede specifiche sensibilità, e non si improvvisa.
Sempre secondo la Soncini, “viviamo in un tempo che ha creato posti di lavoro inventando gli esperti di crisi reputazionali”. Che se non fosse un’offesa per un’intera categoria professionale, ci starebbe come battuta, anche perché alla Soncini si perdona (quasi) tutto. E invece no, non è una professione “inventata” in questi tempi di Social e di polemiche fatue: ci sono corsi universitari sul tema, ci sono discenti che si laureano con tesi sul reputation management, c’è una bibliografia pressoché sterminata, e anche vagonate di studi scientifici, che mi risulta complesso richiamare ora in una breve replica, ma il lettore è bravo e li troverà consultando AI Overview di Google, che neanche più bisogna fra la fatica di entrare dentro i siti web per imparare le cose.
Soncini sostiene in sintesi che le polemiche reputazionali danno fuoco al web come incendi indomabili, per poi – a volte – sparire nel silenzio, poco dopo: e almeno su questo ha ragione. Peccato che tu non puoi mai sapere se la tua, di crisi reputazionale, sarà quella che finirà dimenticata, oppure se sarà quella che rovinerà per sempre il tuo business. Citofonare Ferragni per sincerarsene, perché proprio a causa delle sue scuse raffazzonate, tardive e inautentiche la regina di Instagram è passata da 80 milioni di euro di previsionale 2023 a 2 milioni di consultivo 2024.
Ed è certamente corretto dire, cara Guia – ne hai azzeccate almeno due – che la qualità del prodotto è il principale acceleratore di reputazione – ne è il “primo pilastro”, amo dire io – ma se fai l’influencer, e la Strazzer anche quello fa, il prodotto sei anche un poco tu, no…? E il pubblico – per mettere a terra termini altrimenti da iperuranio come “autenticità” – ci tiene giustamente a sapere se, come avrebbe detto mio nonno, la stai prendendo per i fondelli.
Vero è che, come disse il poeta e librettista del XVII secolo Iacopo Badoer, meglio un bel tacer che un brutto dir. Ma ti notizio di una cosa, Guia: la scelta non è solo tra tacere e dire cretinate. C’è anche l’opzione di dire la cosa corretta, con la giusta postura, tempestivamente, ancorché con contenuti giustamente precisi, completi e ponderati, e soprattutto in modo schietto e sincero. Scusandosi, se è il caso, perché le scuse sono segno di grande potenza emotiva ed estrema maturità, e non di debolezza, come ancora nel 2025 qualche imprenditore, manager o influencer continua a ritenere. Certo, bisogna sapere esattamente come farlo, e questo è proprio il lavoro dei più seri consulenti reputazionali.
E poi, no, cara Soncini, la reputazione non è vero che “non esiste ed è un cascame del ‘900”, come tu l’hai definita. È vero, di reputazione si parla da secoli, dall’epoca dei greci e dei romani. Ma ne è stato scritto ininterrottamente, continuativamente, fino a giorni nostri. La reputazione è “moneta sonante”, ovvero opportunità di condizionamento dei comportamenti di acquisto, nella quotidianità del nostro pensare e agire, nella vita e nell’impresa, e contribuisce alla formazione di un ordine sociale più complesso e interconnesso. Nonché – lo dimostrano numeri e studi – è il primo asset intangibile per qualunque organizzazione economica, che a Guia Soncini piaccia o no.
Per mutuare le parole di Alberto Pirni, illuminato professore di filosofia morale al Sant’Anna di Pisa, reputazione è un lessema parassitario, ovvero una parola che ha bisogno di altre parole per poter sostanziare il proprio significato, assorbe significato da esse, e lo restituisce trasformato e potenziato: tra quelle, riconoscimento, affidabilità, rispetto, e molte altre ancora. Anche onore, termine per alcuni in disuso, ma che – come ci ricorda Pirni – nella lingua greca ha almeno due lemmi volti a trasmetterne il significato: “timé”, appunto letteralmente tradotto come onore (in guerra, ad esempio), ma anche “eudoxìa”, traducibile come buona opinione o buona fama.
Aristotele, nel Primo Libro dell’Etica Nicomachea, richiamato successivamente da Seneca nel suo bellissimo De otio, scrive che – a parte l’attività teoretico-contemplativa, pure importante per generare sapere – una parte della nostra vita è dedicata giustamente alla massimizzazione del piacere (“come posso essere contento al massimo grado possibile”), ma una seconda è dedicata alla dimensione della polis, intesa come comunità e vita civile, ed è nell’ambito di essa che cerchiamo approvazione e ci impegniamo per costruire reputazione, che – quando buona – non fa che aumentare la nostra “licenza di operare”, ovvero la facilità con la quale raggiungiamo i nostri obiettivi di vita e di lavoro.
Ma non si tratta di “vanagloria”, non è tentativo di “volerci fare belli agli occhi altrui”: per Aristotele – e ancora per noi, ai nostri giorni, sottolinea sempre Pirni in un contributo a un recente volume su questi temi – l’onore, sebbene sia il più grande dei beni esteriori, corre il rischio di essere solo un bene apparente se non accompagnato dalla virtù. L’onore è da considerarsi quindi il premio della virtù di ciascuno di noi. dell’essere un “buon cittadino” (e perché no, un buon manager, un buon influencer, eccetera): in sintesi – e quando chi fa Social lo capirà non sarà mai troppo tardi, vero Strazzer? – non devo limitarmi a focalizzarmi sulla forma, ma devo partire dalla sostanza, ovvero devo centrarmi non solo sull’apparire, ma anche – e innanzitutto – sull’essere, sulla mia identità, perché l’apparire può essere figlio solo di ciò che sono realmente, con buona pace della maggior parte degli Influencer.
E in epoca più recente hanno toccato questi temi Tommaso D’Aquino, Wolff, Kant, e anche Schopenhauer, che in un gustoso libretto intitolato L’arte di farsi rispettare ci ricorda come l’onore – rectius, la buona reputazione – sia “il rappresentante del nostro valore nei pensieri altrui”: perché volente o nolente questo siamo, esseri sociali, e deriviamo dalla relazione con altri una importante porzione del significato di noi stessi, come esseri umani e come parte del sistema produttivo della società.
E – concludo – restare immobile come un grumo di molecole, per citare Soncini, non risolve le crisi reputazionali, anzi. Dimostra solo una cosa, molto banalmente: totale assenza di rispetto per il pubblico, come quando qualcuno ti parla e tu guardi per aria e ti chiudi nel più assoluto mutismo. Perché le regole che fanno funzionare le organizzazioni sociali complesse come quelle economiche, non sono molto diverse da quelle che fanno funzionare i rapporti di coppia e di amicizia. Ce l’hanno insegnato papà e mamma, da piccoli, che si risponde quando interpellati; diversamente, cara Guia, non è molto complicato, è solo cattiva educazione.
To be continued: a tarda sera, mentre correggevo i typo di quest’articolo, prima di inviarlo al direttore della rivista per la pubblicazione, finalmente, dopo tanti, troppi giorni, Strazzer è uscita con una dichiarazione ufficiale. Contraddicendo coloro che sostenevano che non doveva prendere parola, e nel contempo facendo la cosa sbagliata agli occhi di coloro che sottolineavano la necessità di uscire ben più tempestivamente, il post della Strazzer – pubblicato schermandosi dietro il profilo Instagram del brand, invece che “metterci la faccia” come le buone prassi di crisis communication avrebbero suggerito, è tardivo, piuttosto algido, e zeppo di numeri ridondanti che paiono voler spostare la querelle su un altro piano, invece che affrontarla di petto.
E dire che sarebbe bastato un po’ di buon senso fin dal primo giorno: studiare sollecitamente l’anatomia dell’errore, rilasciare un’intervista a Charlotte Matteini dimostrando disponibilità al confronto, dialogare in modo franco con la dipendente licenziata, e poi con la propria community e con l’opinione pubblica, chiedendo scusa in modo sincero per il disagio arrecato, intervenire sulla cultura aziendale e sui meccanismi decisionali e organizzativi delle risorse umane affinché la problematica non si ripetesse mai più, traendo dalla crisi un prezioso e costruttivo insegnamento. È così bello sbagliare, quanto riconoscerlo ci permette di migliorare. Ma per fare tutto ciò, sarebbe servito un buon consulente di gestione della reputazione…
*Luca Poma è professore di Reputation management all’Università LUMSA di Roma e all’Università della Repubblica di San Marino, ha scritto 17 volumi e oltre 200 tra saggi e articoli sulla gestione della reputazione e sulla risoluzione delle crisi reputazionali, e ha gestito alcune delle più note problematiche di reputazione deflagrate negli ultimi 25 anni, per conto di noti brand, banche, uomini politici, influencer e sportivi.