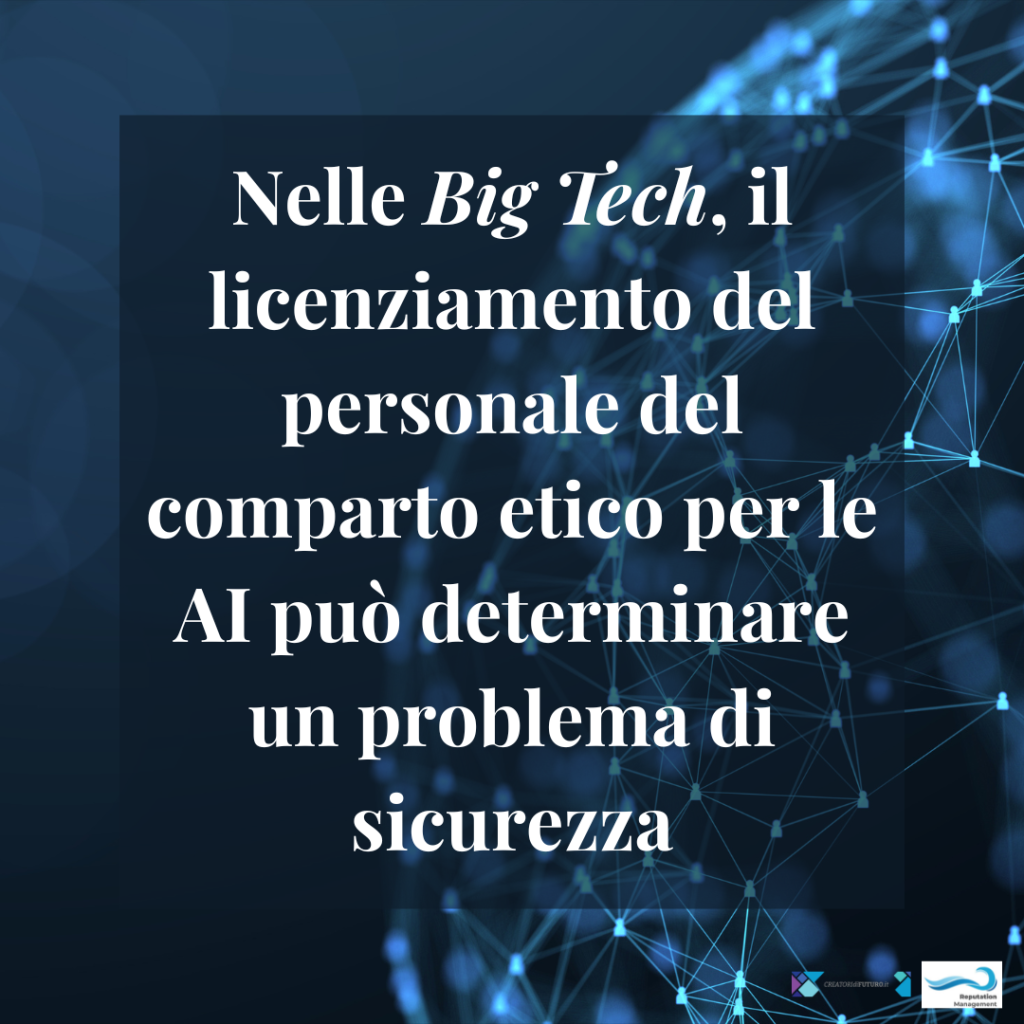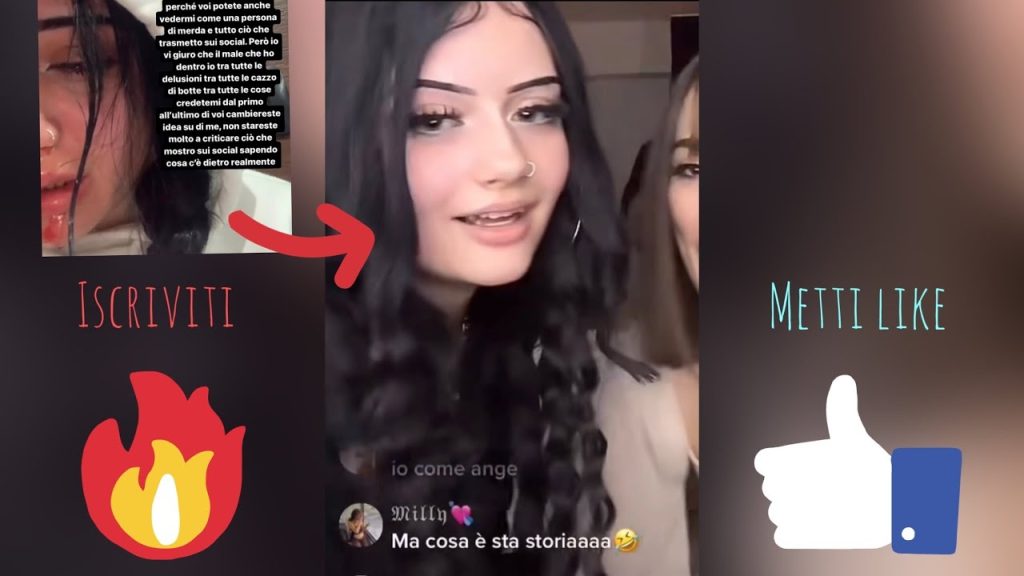Basta temporeggiare con l’IA

Se chiedete a qualcuno di farvi il nome di un’azienda che mette l’intelligenza artificiale (IA) al centro della sua attività, probabilmente sentirete sciorinare il prevedibile elenco delle superpotenze tecnologiche: Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Tencent e Alibaba. Nelle aziende consolidate di altri settori, però, molti dirigenti hanno la sensazione che trasformare l’organizzazione usando l’IA sia qualcosa al di sopra delle loro capacità. Eppure questa tecnologia è relativamente nuova e un decennio fa non esisteva nessuna azienda che facesse affidamento sull’IA, il che significa che quelle dove ora l’IA gioca un ruolo centrale hanno superato con successo una serie di tappe fondamentali: incaricare qualcuno di creare l’IA, mettere insieme i dati, i talenti e gli investimenti necessari e muoversi con tutta la determinazione possibile per dotarsi delle capacità indispensabili.
Più facile a dirsi che a farsi? Sì. In tante organizzazioni le iniziative in materia di IA mancano di ambizione e di convinzione e non arrivano mai all’unico passaggio in grado di aggiungere valore economico: prendere un modello e applicarlo su larga scala. In un’inchiesta realizzata nel 2019 dalla MIT Sloan Management Review e dal Boston Consulting Group, sette aziende su dieci hanno riferito che le loro iniziative di IA avevano avuto un impatto minimo o addirittura nullo. Dalla stessa inchiesta emergeva che, all’interno di quel 90% di aziende che avevano fatto investimenti sull’IA, meno del 40% aveva registrato miglioramenti nell’andamento degli affari nei tre anni precedenti. Non è sorprendente: un programma pilota o un esperimento più di tanto non possano fare.
Nelle nostre ricerche degli ultimi anni abbiamo individuato 30 aziende private e organismi pubblici (non sempre famosi per la loro perizia tecnologica) che hanno deciso di puntare con forza sull’IA e ne hanno raccolto i benefici. Molte di queste aziende competono in settori come le banche, il commercio al dettaglio e i prodotti di consumo. Abbiamo studiato il loro percorso e identificato 10 azioni intraprese da queste 30 organizzazioni per diventare esempi di successo nell’adozione dell’IA.
Per ricavare un valore significativo dall’IA, la vostra organizzazione deve ripensare alla radice il modo in cui esseri umani e macchine interagiscono nei contesti lavorativi. Bisogna concentrarsi su applicazioni in grado di cambiare il rendimento dei dipendenti e sul modo in cui i clienti interagiscono con l’azienda. Bisogna prendere in considerazione in modo sistematico l’applicazione dell’IA in ognuna delle funzioni e delle attività operative fondamentali per supportare nuovi processi e un percorso decisionale alimentato dai dati. Allo stesso modo, l’IA deve stimolare nuove offerte di prodotti e servizi e nuovi modelli d’impresa. In altre parole, la tecnologia deve arrivare a trasformare ogni aspetto della vostra azienda.
Ognuna delle 10 azioni che elenchiamo in questo articolo avvicineranno la vostra impresa all’obiettivo della trasformazione: ma se non volete che questa trasformazione rimanga a metà, dovete evitare iniziative frammentarie e affrontare con decisione tutti e 10 questi compiti. Gli esempi che accompagnano ognuno di essi descrivono nel dettaglio che cosa hanno fatto alcune organizzazioni per portare a termine il compito con successo. La vostra impresa può scegliere di gestire i vari compiti in modo diverso o affrontarli seguendo un altro ordine.
1 SAPERE CHE COSA VOLETE REALIZZARE
Le aziende ambiziose hanno una percezione specifica di come applicare l’IA. L’obiettivo di fondo è guadagnare di più, naturalmente, ma se si vuole individuare e sviluppare sistemi di IA capaci di trasformare l’organizzazione serve un obiettivo più chiaro. Alcune imprese cominciano a usare la tecnologia per migliorare la velocità dei processi, ridurre i costi operativi o vendere meglio. Qualunque sia il motivo per cui volete usare l’IA, noi consigliamo di individuare un obiettivo generale ben definito e usarlo come principio guida.
Quando, nel 2014, la divisione audit e assicurazioni di Deloitte cominciò a sviluppare Omnia, una piattaforma di IA brevettata, il principio guida era migliorare la qualità del servizio a livello globale. Creare uno strumento globale in quest’ambito non è semplice come tradurre i dati in più lingue. Esistono importanti differenze nel modo in cui i diversi Paesi regolamentano i dati, inclusi gli standard di riservatezza, i processi di auditing e la gestione dei rischi.
Una parte importante nella revisione dei conti di un’azienda consiste nel raccogliere dati finanziari e operativi in un formato che possa essere facilmente analizzato. Dal momento che la strutturazione dei dati è diversa da un’azienda all’altra, estrarre dati rilevanti e caricarli su una piattaforma di auditing è un’operazione che può richiedere una gran quantità di manodopera. La piattaforma Omnia era stata sperimentata con un cliente statunitense, ma l’obiettivo era farne uno strumento utilizzabile in tutto il mondo: questo presentava diversi problemi specifici già in partenza, come sviluppare un unico modello dati che funzionasse con tutti i clienti e in tutte le regioni.
Il fatto di aver immaginato Omnia come uno strumento globale ancora prima di crearla ha consentito agli sviluppatori di Deloitte di focalizzarsi sulla standardizzazione delle informazioni provenienti da aziende diverse in Paesi diversi: un’impresa enorme, ma che sarebbe stata ancora più impegnativa nelle fasi successive del processo di sviluppo.
2 LAVORARE CON UN ECOSISTEMA DI PARTNER
Per costruire Omnia, la divisione auditing e assicurazioni di Deloitte dovette tenere sotto osservazione le start-up tecnologiche di tutto il mondo per trovare soluzioni adatte alle necessità dell’azienda. Senza questi partner, Deloitte avrebbe dovuto sviluppare le tecnologie al proprio interno, cosa che sarebbe stata possibile, ma a un costo molto più alto e con tempi ben più lunghi. Un’azienda ha bisogno di partner solidi se vuole avere successo con l’IA.
Deloitte lavorò con Kira Systems, una start-up canadese che ha un software in grado di estrarre le condizioni contrattuali dai documenti legali. Tradizionalmente, i revisori di Deloitte dovevano leggersi un gran numero di contratti ed eseguire questo compito manualmente, ma ora la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale di Kira identifica ed estrae in modo automatico le condizioni contrattuali fondamentali. Un altro partner, la Signal AI, ha costruito una piattaforma che analizza i dati finanziari disponibili pubblicamente per individuare potenziali fattori di rischio nell’attività di un’azienda cliente. Una recente aggiunta alla piattaforma Omnia è Trustworthy AI, un modulo sviluppato in collaborazione con Chatterbox Labs, che valuta i modelli di IA per individuare distorsioni.
3 PADRONEGGIARE L’ANALITICA DEI DATI
La maggior parte delle aziende che hanno adottato con successo l’IA avevano già in piedi importanti iniziative di analitica dati prima di immergersi nell’intelligenza artificiale. Anche se qualsiasi forma di apprendimento automatico può includere altre tecnologie non basate sull’analitica dati, come azioni autonome, robotica e metaverso, questa è il cuore pulsante dell’apprendimento automatico ed è il motivo per cui saper padroneggiarla è fondamentale per riuscire ad adottare l’IA con successo.
Ma cosa significa esattamente “padroneggiare l’analitica dati”? In questo contesto comporta l’impegno a usare i dati e l’analytics per la maggior parte delle decisioni: questo significa cambiare il modo di trattare con i clienti, rendere l’IA parte integrante di prodotti e servizi e realizzare molti compiti – anche interi processi aziendali – in modo più automatizzato e intelligente. E per trasformare la loro attività attraverso l’IA, è sempre più importante che le aziende possano contare su dati unici o proprietari: se tutti i loro concorrenti hanno gli stessi dati, tutti avranno modelli di apprendimento automatico e risultati simili.
La Seagate Technology, il più grande produttore mondiale di unità disco, possiede quantità colossali di dati da sensori nelle sue fabbriche e, negli ultimi cinque anni, li sta usando ad ampio raggio per migliorare la qualità e l’efficienza dei suoi processi di produzione. Uno dei punti focali di questo sforzo è stata l’automazione dell’ispezione visiva dei wafer di silicio da cui vengono ricavate le testine delle unità disco e le macchine utensili che le fabbricano. Per tutto il processo di fabbricazione dei wafer di silicio, le varie macchine utensili acquisiscono una gran quantità di immagini al microscopio. Usando i dati ricavati da queste, la fabbrica di Seagate, nel Minnesota, ha creato un sistema automatizzato che consente alle macchine di trovare e classificare in modo diretto i difetti dei wafer di silicio. Altri modelli di classificazione delle immagini individuano i microscopi elettronici fuori fuoco negli strumenti di monitoraggio, per appurare se i difetti esistano veramente. Da quando questi modelli sono stati impiegati per la prima volta, alla fine del 2017, il loro utilizzo si è esteso a tutte le fabbriche di wafer di silicio dell’azienda negli Stati Uniti e in Irlanda del Nord, consentendo di risparmiare milioni di dollari in costi di personale per le ispezioni e in prevenzione degli scarti di lavorazione. L’accuratezza dell’ispezione visiva, che anni fa era del 50%, ora supera il 90%.
I dati sono la base del successo nell’apprendimento automatico e i modelli non sono in grado di fare previsioni accurate se non hanno a disposizione dati di qualità in abbondanza. Si può dire che l’ostacolo più grande per la maggior parte delle organizzazioni che vogliono potenziare i loro sistemi di IA sta proprio nell’acquisire, ripulire e integrare i dati giusti. Un’altra cosa importante è cercare attivamente nuove fonti di dati per nuove iniziative di IA: ne parleremo più avanti.
4 CREARE UN’ARCHITETTURA INFORMATICA MODULARE E FLESSIBILE
È indispensabile avere un modo per estendere facilmente dati, analitica e automazione a tutte le applicazioni della vostra impresa. A questo scopo, c’è bisogno di un’infrastruttura tecnologica che sia in grado di comunicare e comprendere dati provenienti da altri ambienti informatici, sia all’interno che all’esterno della vostra azienda. Il software di un centro dati normalmente è progettato soltanto per comunicare con altri software dello stesso centro dati. Integrarlo con software esterni a quell’infrastruttura è una cosa che può portare via tempo e denaro.
Un’architettura informatica flessibile rende più semplice automatizzare processi complessi, come l’estrazione delle condizioni contrattuali chiave dai documenti legali in Deloitte. Se non siete in grado di sviluppare un’architettura di questo tipo da soli (per le piccole e medie imprese è quasi sempre così), potreste dover collaborare con società come Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud.
Capital One, considerata da decenni una superpotenza nel campo dell’analitica dati, ha usato questa metodologia per comprendere gli schemi di spesa dei consumatori, ridurre il rischio di credito e migliorare il servizio ai clienti. (Avvertenza: uno di noi, Tom, è stato oratore retribuito per Capital One.) Nel 2011 l’azienda ha preso la decisione strategica di reinventare e modernizzare cultura, processi operativi e infrastruttura tecnologica di base. Questa trasformazione è consistita nel passare a un modello agile per la fornitura di software, costruire un’organizzazione ingegneristica su larga scala e assumere migliaia di persone per ricoprire ruoli digitali. Ha anche indotto l’azienda a spostare i suoi dati sul cloud.
Capital One ha costruito la sua architettura cloud in collaborazione con AWS. Prima del passaggio al cloud, però, i dirigenti di Capital One hanno dovuto reimmaginare il futuro dell’industria bancaria. I canali digitali su cui stanno migrando i clienti, come il sito e l’applicazione per cellulari della banca, producevano molti più dati rispetto alle interazioni personali, offrendo alla banca l’opportunità di capire meglio in che modo i clienti interagivano con essa. Il passaggio al cloud aveva senso da un punto di vista strategico anche perché avrebbe fatto calare i costi dell’archiviazione dei dati. Nel 1960, secondo i dati della Marshall School of Business dell’Università della California meridionale, archiviare un gigabyte di informazioni costava 2 milioni di dollari. Questo costo era sceso a 200.000 dollari negli anni Ottanta, a 7,7 dollari nei primi anni Duemila e – grazie all’archiviazione su cloud – ad appena 2 centesimi nel 2017.
La Capital One appurò che AWS poteva fornire un’archiviazione dati e una potenza di calcolo sul cloud, basata su software fortemente scalabile e disponibile all’istante, a un costo molto più basso rispetto all’archiviazione in locale. AWS metteva a disposizione anche strumenti nuovi e innovativi e piattaforme di apprendimento automatico. Non aveva più senso, per l’organizzazione informatica di Capital One, costruire e gestire soluzioni infrastrutturali per tutti questi dati, per cui cominciò a concentrarsi sullo sviluppo di software e capacità. Oggi Capital One analizza un flusso interminabile di dati da transazioni via web e cellulare, sportelli bancomat e transazioni con carta in tempo reale, per soddisfare le esigenze dei clienti e prevenire le frodi. Nel 2020 la banca ha chiuso il suo ultimo centro dati e ha trasferito tutte le sue applicazioni e tutti i suoi dati sul cloud di AWS.
Molte aziende, naturalmente, hanno già trasferito dati e applicazioni sul cloud (o li creano direttamente sul cloud). Per quelle che non l’hanno fatto, adottare con successo sistemi di IA sarà più difficile.
5 INTEGRARE L’IA NEI FLUSSI DI LAVORO ESISTENTI
La presenza di processi aziendali inflessibili può essere altrettanto limitante di un’architettura informatica inflessibile. Le società descritte in questo articolo si sono impegnate a fondo per integrare l’IA nei flussi di lavoro quotidiani di dipendenti e clienti. Per fare la stessa cosa nella vostra organizzazione, stabilite innanzitutto quale dei vostri flussi di lavoro è pronto per accogliere la velocità e l’intelligenza dell’IA e cominciate a integrarli con essa il prima possibile. Bisogna evitare di infilare a forza l’IA in flussi di lavoro che non trarrebbero beneficio dalla velocità e dalla scalabilità delle macchine, come ad esempio processi aziendali usati raramente, che non prevedono né generano quantità enormi di dati e ripetizioni.
L’integrazione dell’IA nel flusso di lavoro richiede un piano d’attacco ancora più specifico di quello del primo compito, “Sapere che cosa volete realizzare”. Immaginiamo che abbiate stabilito che la cosa che volete migliorare è il servizio clienti. Per integrare l’IA a flussi di lavoro già esistenti c’è bisogno di un’ottima conoscenza sul campo di questi processi, rara fra gli alti dirigenti. Ma i dipendenti che lavorano nelle funzioni di linea hanno una prospettiva ideale per capire quali processi possono trarre beneficio dall’IA e come possono essere migliorati esattamente.
Alcune ramificazioni del governo americano hanno individuato mansioni e flussi di lavoro specifici che si prestano ottimamente alla velocità e alla scalabilità dell’IA. La NASA, per esempio, ha lanciato dei progetti pilota nell’ambito della contabilità attiva e passiva, la spesa informatica e le risorse umane. (Grazie al progetto sulle risorse umane, l’86% delle transazioni della NASA in quest’ambito sono state completate senza intervento umano.) La Social Security Administration, l’ente previdenziale pubblico, usa l’IA e l’apprendimento automatico nelle richieste di indennità per affrontare i problemi legati al forte arretrato di pratiche e per garantire accuratezza e uniformità nelle decisioni. All’inizio della pandemia di Covid-19, il dipartimento per gli Affari dei veterani ha implementato chatbot di IA per rispondere a quesiti, aiutare a stabilire la gravità dei casi confermati e trovare possibili strutture per il ricovero dei pazienti. Il Laboratorio per la sicurezza dei trasporti del Direttorato scienza e tecnologia del dipartimento della Sicurezza interna sta studiando modi per incorporare l’IA e l’apprendimento automatico negli screening di sicurezza degli aeroporti, in modo da migliorare la scansione dei passeggeri e dei bagagli. L’Internal Revenue Service, l’agenzia delle entrate, sta usando l’IA per verificare quali combinazioni di notifiche formali hanno le maggiori probabilità di indurre un contribuente in debito con il fisco a pagare.
6 COSTRUIRE SOLUZIONI IN TUTTA L’ORGANIZZAZIONE
Dopo che l’organizzazione ha sperimentato e acquisito dimestichezza con un sistema di IA all’interno di un flusso di lavoro specifico, arriva il momento di estenderlo a tutta l’organizzazione con maggiore aggressività. Invece di disegnare un modello algoritmico per un processo, il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un approccio uniforme, replicabile in tutta l’azienda.
Alla Cleveland Clinic «l’IA spunta fuori da tutte le parti», secondo Chris Donovan, direttore esecutivo per l’analitica d’impresa e la gestione dell’informazione. Il suo gruppo incoraggia le iniziative guidate dai dipendenti per sviluppare e applicare l’IA, fornendo al tempo stesso approcci di governance guidati dalla dirigenza. Finora a fare da traino all’iniziativa è stata una comunità di pratica trasversale all’organizzazione, ancorata nei reparti analitica d’impresa, informatica ed etica.
Come la maggior parte delle organizzazioni che stanno mettendo in moto trasformazioni aggressive fondate sull’IA, la Cleveland Clinic si deve misurare con una sfida enorme relativa a dati e analisi. Secondo Donovan, gli ospedali hanno molti meno dati delle organizzazioni di altri settori ed è meno probabile che questi siano puliti e ben strutturati. I dati della Cleveland Clinic, dice, hanno problemi di qualità, vengono rilevati in modo scadente e inseriti con modalità difformi, e hanno definizioni differenti a seconda dei reparti dell’organizzazione. Perfino un parametro banale come la pressione del sangue può essere preso mentre il paziente è in piedi, seduto oppure sdraiato, normalmente con risultati differenti, e viene archiviato nei modi più vari. Per interpretare in modo accurato i dati sulla pressione sanguigna bisogna conoscere la struttura dei dati di ogni reparto. Invece di lasciare la preparazione dei dati a ogni reparto della clinica per ogni singolo insieme di questi, il gruppo di Donovan la integra in ogni progetto di IA e lavora per fornire insiemi utili a tutti i progetti di IA.
La Cleveland Clinic usa l’IA anche per valutare il rischio nel profilo sanitario della popolazione di riferimento: ha costruito un modello predittivo che aiuta a decidere in base alle priorità l’impiego di risorse limitate per fornire assistenza medica ai pazienti che più ne hanno bisogno. Il punteggio di rischio predittivo ora è il metodo primario per decidere a quali pazienti spedire l’invito a fare un controllo. Un malato di diabete che ha difficoltà a gestire la malattia, per esempio, riceverebbe un punteggio di rischio alto. La Cleveland Clinic ha costruito un altro modello per individuare quei pazienti che corrono il rischio di contrarre una certa malattia, ma non hanno avuto sintomi in tal senso in passato: è usato per programmare attivamente cure preventive per queste persone. La Cleveland Clinic sta lavorando anche per individuare quei pazienti con condizioni di vita o lavorative problematiche, che influenzano la loro salute: potrebbero aver bisogno di un assistente sociale oltre che di un medico, o di una tessera dell’autobus per andare alle visite mediche.
7 CREARE UNA GOVERNANCE E UNA STRUTTURA DI COMANDO DELL’IA
Assegnare a qualcuno l’incarico di decidere come dev’essere implementata l’intelligenza artificiale in tutta l’organizzazione rende più facile la trasformazione. I leader migliori sono consapevoli di quello che può fare l’IA in generale, di quello che può fare per la loro azienda e di quali implicazioni potrebbe avere per strategie, modelli d’impresa, processi e persone. Ma la sfida più grande che deve affrontare un leader è creare una cultura che metta al centro decisioni e azioni fondate sui dati e crei entusiasmo fra i dipendenti per le potenzialità di miglioramento offerte dall’IA. In un’organizzazione in cui non esiste una cultura di questo tipo, i sostenitori dell’IA difficilmente otterranno le risorse necessarie per costruire applicazioni eccellenti e non avranno la possibilità di assumere le persone migliori; e se anche l’azienda dovesse riuscire a costruire delle applicazioni di IA, finirebbe per non usarle nel modo più efficace.
Che tipo di leader serve per promuovere la cultura giusta? Prima di tutto, aiuta avere a capo dell’iniziativa un amministratore delegato o un altro alto dirigente che conosca bene le tecnologie informatiche. Un’iniziativa per l’adozione dell’IA può essere guidata anche da una persona che non ha conoscenze tecniche, ma in tal caso la persona in questione dovrà imparare tante cose e pure in fretta. In secondo luogo, è importante che il leader lavori su più fronti. Le iniziative a cui sceglie di partecipare varieranno a seconda dell’organizzazione, ma la partecipazione di un alto dirigente è particolarmente importante per segnalare che c’è interesse per la tecnologia, per istituire una cultura di decisioni fondate sui dati, per stimolare l’innovazione in tutta l’impresa e per motivare i dipendenti ad adottare nuove competenze. In terzo luogo, i leader sono quelli che hanno in mano i cordoni della borsa. Studiare, sviluppare e implementare l’IA è costoso. I leader devono investire (o convincere altri a investire) somme sufficienti a rendere possibile l’adozione dell’IA a tutti i livelli.
Avere un’unica persona a capo delle iniziative di IA aiuta, ma in prospettiva è indispensabile che tutta l’organizzazione, fino ai livelli più bassi, abbracci con dedizione questi sforzi. Se i manager di alto livello, di livello intermedio e anche quelli in prima linea proclamano un’adesione solo formale all’idea di una trasformazione basata sull’IA, le cose procederanno più lentamente e l’organizzazione, con ogni probabilità, tornerà alle vecchie abitudini. Abbiamo visto casi di aziende dove c’erano leader profondamente convinti dei vantaggi dell’IA, che hanno lanciato numerose iniziative e sono riusciti a fare dell’IA il punto focale dell’organizzazione. Poi, però, quelli che sono venuti dopo di loro non avevano la stessa convinzione e l’IA ha perso di importanza.
8 SVILUPPARE CENTRI DI ECCELLENZA COL PERSONALE NECESSARIO
Nella maggior parte dei casi i responsabili dell’IA e dell’analitica dati continuano a dedicare una gran quantità di tempo agli sforzi per evangelizzare gli altri manager sull’importanza e lo scopo di questa tecnologia. I responsabili di tutte le unità aziendali devono garantire ai progetti di IA i fondi e il tempo di cui c’è bisogno e devono applicare l’IA nei loro processi lavorativi. È importante insegnare a questi manager come funziona l’IA, quando è appropriato usarla e cosa comporta portare avanti un progetto serio in questo ambito. Per la gran parte delle aziende, questo lavoro di aggiornamento e cambiamento delle competenze è ancora agli inizi, e non è necessario che ogni dipendente riceva una formazione sull’IA. Ma è evidente che per una parte dei dipendenti è necessario, e più sono meglio è. Tutte le aziende citate in questo articolo si sono rese conto che per riuscire nel loro intento avevano bisogno di tanti talenti e tanta formazione in IA, ingegneria dei dati e scienza dei dati.
Quando Piyush Gupta entrò in carica come amministratore delegato, nel 2009, la DBS Bank era all’ultimo posto tra le banche di Singapore per qualità del servizio clienti. Gupta investì cifre enormi in sperimentazioni sull’IA (circa 300 milioni di dollari l’anno negli ultimi anni) e diede ai diversi reparti e funzioni dell’azienda la flessibilità necessaria per assumere esperti di dati e capire cos’era possibile fare. Il responsabile delle risorse umane della banca, che non aveva nessuna competenza tecnica pregressa, creò un piccolo gruppo di lavoro per individuare e sperimentare applicazioni di IA, fra cui JIM (Job Intelligence Maestro), un modello in grado di prevedere il logoramento dei dipendenti e aiutare la banca a reclutare i lavoratori più qualificati. La DBS ha usato questo modello per assumere molti dei 1.000 fra esperti di dati e ingegneri dei dati che oggi lavorano nell’organizzazione.
Ora gli ingegneri alla DBS sono il doppio dei banchieri, dice Gupta, e lavorano su tecnologie emergenti come la blockchain e i token asset-backed, oltre che su progetti di IA. Anche la cultura della banca è enormemente migliorata. Per quattro anni, dal 2018 al 2021, la DBS è stata indicata come migliore banca a livello mondiale da Euromoney e la sua situazione patrimoniale e il suo merito di credito ormai sono fra i più floridi di tutta la regione Asia-Pacifico. Nel 2019 la Harvard Business Review ha inserito Gupta all’89ª posizione nella classifica dei migliori amministratori delegati del pianeta.
9 INVESTIRE IN MODO CONTINUATIVO
Scegliere di puntare tutto sull’IA non è una decisione che viene presa alla leggera, dato che produce effetti significativi sull’azienda per decenni, e per una grande impresa può finire per costare centinaia di milioni o addirittura miliardi di dollari. Tutte le aziende che hanno adottato l’IA con successo ci hanno detto che è questo l’ordine di grandezza degli esborsi da mettere in conto, se si vogliono perseguire obiettivi ambiziosi in tema di IA al livello dell’intera organizzazione. All’inizio l’idea di stanziare così tante risorse può fare paura ma, dopo aver visto i benefici che derivavano dai primi progetti, per le aziende oggetto delle nostre ricerche è stato molto più facile decidere di spendere soldi su dati, tecnologie e persone con orientamento sull’IA.
La CCC Intelligent Solutions, per esempio, ha speso e prevede di continuare a spendere più di 100 milioni di dollari l’anno su IA e dati. (Avvertenza: Tom è stato oratore retribuito per la CCC.) L’azienda era nata nel 1980 con il nome di Certified Collateral Corporation e originariamente il suo lavoro consisteva nel fornire alle compagnie assicurative informazioni per la valutazione degli automezzi. Se vi è capitato di avere un incidente automobilistico che ha richiesto lavori di riparazione importanti, probabilmente avete beneficiato dei dati, dell’ecosistema e del processo decisionale fondato sull’IA della CCC. Nei suoi oltre quarant’anni di attività, la CCC si è evoluta raccogliendo e gestendo sempre più dati, allacciando rapporti sempre più stretti con le varie componenti dell’industria delle assicurazioni auto e prendendo sempre più decisioni attraverso dati, analitica e, alla fine, anche l’IA. Negli ultimi 23 anni l’azienda è stata guidata da Githesh Ramamurthy, che prima ricopriva la carica di direttore tecnologico. La CCC gode di una crescita solida e ha ricavi annui che si stanno avvicinando ai 700 milioni di dollari.
I modelli di apprendimento automatico della CCC sono basati su dati storici relativi a denunce di sinistro per un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari, miliardi di immagini storiche e altri dati su componentistica auto, officine di riparazioni, ferite da collisione e normative. La CCC raccoglie anche dati storici, attraverso telematica e sensori installati nei veicoli, per un totale di oltre 80 miliardi di chilometri. Fornisce dati, e sempre di più anche decisioni, a un vasto ecosistema di circa 300 compagnie assicurative, 26.000 officine, 3.500 fornitori di pezzi di ricambio e tutti i principali produttori di componentistica auto originale. L’obiettivo della CCC è collegare tutte queste organizzazioni in un ecosistema uniforme per elaborare in tempi rapidi le denunce di sinistro. Tutte queste transazioni avvengono nel cloud, dove la CCC ha spostato i suoi sistemi dal 2003. Mette in collegamento 30.000 aziende e 500.000 utenti individuali e lavora transazioni commerciali per un valore di 100 miliardi di dollari. Come potete immaginare, arrivare a questo punto ha richiesto tempo e denaro.
10 RICERCARE SEMPRE NUOVE FONTI DI DATI
Raccogliere dati di solito non è un problema per le grandi aziende, ma le strategie in materia di IA sono determinate in gran parte dai dati che si riesce a mettere insieme. Avere più dati è bene. Avere dati più accurati è meglio. Avere dati più accurati e strutturati che possano essere applicati immediatamente ai modelli di IA è l’ideale. Integrare i dati provenienti dai sistemi dei clienti forse è stata la cosa più complicata nel percorso seguito da Deloitte. Capital One ha sempre potuto contare su un’abbondanza di dati, ma aveva bisogno di un modo per archiviarli e utilizzarli all’interno di un’architettura informatica flessibile. La CCC ha cominciato ad accumulare dati già col modello d’impresa iniziale, e quindi si trovava nelle condizioni migliori per il passaggio a un modello fondato sull’IA: ma la transizione da impresa orientata ai dati a impresa orientata all’IA si è concretizzata quando ha imparato come usare un tesoro di dati enorme che fino a cinque anni prima non esisteva.
Quando si pensa ai dati, non bisogna dare per scontato che si tratti solo di parole e numeri. Per la CCC, le immagini dei veicoli rappresentano dati che possono essere applicati a diversi processi fondamentali. Aveva accumulato miliardi di immagini nel corso della sua storia, ma erano foto scattate da periti sul luogo dell’incidente o da meccanici nelle officine, usando macchine professionali dotate di speciali schede grafiche per immagazzinare e spedire le immagini.
Intorno al 2012 i dirigenti della CCC osservarono che le macchine fotografiche amatoriali diventavano sempre più avanzate e venivano incorporate negli smartphone, e immaginarono un futuro in cui i proprietari di veicoli danneggiati avrebbero potuto scattare da soli le foto per i preventivi degli assicuratori e inviarle direttamente dai loro telefoni. Senza più bisogno di fotografi e macchine fotografiche professionali, il processo sarebbe stato più rapido ed economico, pensarono i dirigenti della CCC. Decisero quindi di coinvolgere diversi professori di importanti università per studiarne le potenzialità. Contemporaneamente, iniziarono a leggere di un nuovo approccio all’analisi delle immagini, le reti neurali in apprendimento profondo, che avendo a disposizione una quantità di dati sufficiente per allenarsi avrebbero potuto prima o poi eguagliare o superare l’analisi umana.
La CCC mise insieme un pool di data scientist di talento, che scoprirono come sovrapporre le foto alla struttura di vari veicoli e come annotare o etichettare le immagini per addestrare il software. A metà del 2021 il sistema era pronto per essere applicato e uno dei primi clienti fu la USAA, una grande compagnia assicurativa americana. Il circolo virtuoso di aumento della quantità di dati, miglioramento dei modelli, aumento del giro d’affari e aumento della quantità di dati è il grande punto di forza della scelta della CCC di usare le immagini ricavate dagli smartphone. Nuovi dati continueranno ad affluire all’azienda e verranno usati per migliorare le previsioni dei preventivi e altre funzioni. Questo aiuterà i clienti della CCC a prendere decisioni migliori, che con ogni probabilità porteranno alla CCC più affari e più dati.
Noi siamo convinti che le aziende che adottano con più decisione l’IA, che riescono a integrarla meglio nella strategia e nell’attività operativa, saranno quelle che riusciranno a creare più valore. Sapere quello che stanno facendo le aziende migliori da questo punto di vista può aiutarne altre a valutare quanto questa tecnologia sia in grado di trasformare la loro attività. La vostra organizzazione può prendere le 10 azioni che abbiamo delineato in questo articolo per muoversi nella stessa direzione.
Noi siamo convinti anche che in futuro l’IA, applicata in modo strategico e in dosi massicce, sarà decisiva per il successo di quasi tutte le imprese. I dati stanno aumentando a ritmo sostenuto e questa è una tendenza destinata a proseguire. L’IA è un mezzo per ricavare un senso da grandi quantità di dati e garantire decisioni intelligenti al livello dell’intera organizzazione, e anche questa è una tendenza destinata a proseguire. L’intelligenza artificiale è qui per restare. Le aziende che la applicheranno con decisione conquisteranno una posizione dominante nel loro settore nei prossimi decenni.
Thomas H. Davenport è professore emerito di Tecnologie dell’informazione e Management presso il Babson College, visiting scholar presso l’Iniziativa del MIT sull’economia digitale e consulente senior presso il reparto IA della Deloitte. Carol Kauffman è dirigente, responsabile dell’offerta analitica e cognitiva e corresponsabile della practice per la crescita strategica dell’IA in Deloitte Consulting. Insieme, hanno scritto All In on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence (Harvard Business Review Press, 2023), da cui è stato ricavato questo articolo.