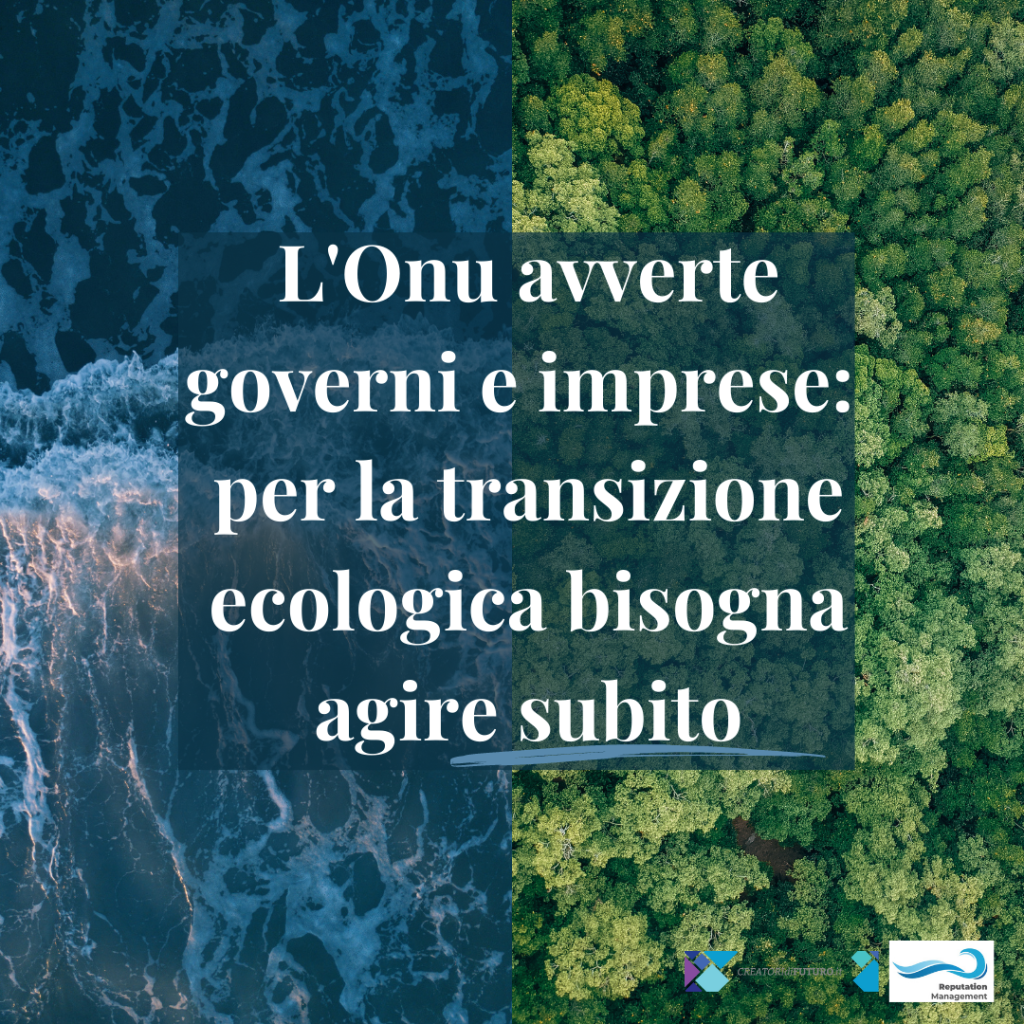Il 19 marzo è stata presentata la sesta edizione del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), il rapporto più grande e completo di sempre sul cambiamento climatico, in grado di fornire una valutazione aggiornata e approfondita dello stato attuale del clima della Terra e delle sue proiezioni future.
La valutazione del rapporto è chiara: il clima sta cambiando a un ritmo incredibile e senza ombra di dubbio tra le principali cause c’è l’attività umana. L’aumento delle temperature globali è causato da emissioni di gas serra antropogeniche, principalmente la combustione dei fossili, come il carbone, il petrolio e il gas naturale.
Il rapporto evidenzia come l’aumento della temperatura media del pianeta abbia già causato impatti su scala globale, come l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione degli oceani, l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, la riduzione della quantità e qualità dell’acqua e l’erosione del suolo.
Inoltre, il rapporto mette in evidenza che l’aumento della temperatura globale può superare il limite di 1,5°C, che è stato stabilito nell’Accordo di Parigi del 2015 come il massimo accettabile per limitare gli impatti del cambiamento climatico. Questo limite potrebbe essere superato già entro i prossimi 10-20 anni se le emissioni di gas serra non saranno drasticamente ridotte.
Il Segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha accolto con preoccupazione il sesto rapporto del IPCC, definendolo “un codice rosso per l’umanità” e ha annunciato la presentazione di un piano chiamato “Acceleration Agend”, che coinvolgerà i leader dei Paesi sviluppati impegnati a raggiungere l’obiettivo di net zero entro il 2040 e i Paesi in via di sviluppo entro il 2050. Tale Agenda richiederà la cessazione dell’utilizzo del carbone, la produzione di elettricità net zero, nonché la sospensione di tutte le autorizzazioni e finanziamenti per nuovi progetti di petrolio e gas e qualsiasi espansione dalle riserve esistenti. Queste misure dovranno essere accompagnate da salvaguardie per le comunità più vulnerabili, finanziamenti e capacità di adattamento, prevenzione di perdite e promozione di riforme per garantire che le banche multilaterali di sviluppo forniscano maggiori sovvenzioni e mobilitino completamente la finanza privata.
Sul tema è intervenuto anche il Segretario esecutivo dell’United Nations framework convention on climate change Simon Stiell, dichiarando:
Il tempo sta per scadere, ma non le opzioni per affrontare il cambiamento climatico. Il Synthesis Report del Sixth Assessment Report dell’IPCC aggiunge più chiarezza e dettagli a una semplice verità: dobbiamo fare di più sul cambiamento climatico, adesso. Siamo in un decennio critico per l’azione climatica. Le emissioni globali devono essere ridotte di quasi il 43% entro il 2030 affinché il mondo possa raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi. Il Synthesis Report evidenzia quanto siamo fuori strada. Non è troppo tardi. L’IPCC dimostra chiaramente che è possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius con riduzioni rapide e profonde delle emissioni in tutti i settori dell’economia globale. Ci ha fornito molte opzioni di mitigazione e adattamento fattibili, efficaci e a basso costo da poter attuare in tutti i settori e Paesi.
Stiell si è poi concentrato sulle possibilità che abbiamo per dimezzare le emissioni entro la fine del decennio, sostenendo che questo è il momento di agire in modo efficace e preciso. “Il cosiddetto Global Stocktake di quest’anno, un processo in base al quale i Paesi valutano i progressi verso gli obiettivi di Parigi, è per i Paesi un momento per concordare le pietre miliari concrete che ci porteranno ai nostri obiettivi per il 2030. Questa roadmap deve includere passaggi dettagliati per tutti i settori e i temi, compresi l’adattamento climatico, le perdite e i danni, la finanza, la tecnologia e il capacity building. Fornendoci non solo un piano basato sulle opzioni disponibili, ma anche riforme finanziarie e un rinnovato senso di responsabilità politica e imprenditoriale sul cambiamento climatico, la COP28 – che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre – può essere il momento in cui iniziare a seguire la rotta per raggiungere collettivamente gli obiettivi di Parigi».
Tra poche settimane, la Wmo (Organizzazione Meteorologica Mondiale) pubblicherà un rapporto sullo stato del clima globale. Secondo il Segretario generale Petteri Taalas, che ha anticipato alcune delle sue conclusioni, tutti i parametri climatici stanno andando nella direzione sbagliata. Ci sono numerosi problemi che includono il riscaldamento degli oceani, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare, le inondazioni e gli eventi di siccità, oltre all’aumento di anidride carbonica, metano e protossido di azoto nell’atmosfera. Il messaggio chiave dell’IPCC è che è molto più logico limitare il cambiamento climatico rispetto ad affrontare le conseguenze inevitabili della nostra inazione. Fortunatamente, ci sono mezzi economicamente e tecnicamente attraenti per limitare il livello di riscaldamento a 1,5°C, e la transizione rappresenta anche una grande opportunità per nuove imprese e risparmi finanziari. Oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dobbiamo anche accelerare l’adattamento ai cambiamenti climatici. I sistemi di allerta precoce sono uno strumento di adattamento efficace ed efficiente, e la Wmo ha dato la priorità agli allarmi precoci per tutti entro il 2027.
Possiamo quindi affermare che il rapporto IPCC dimostra ancora una volta, se non fosse già abbastanza chiaro, che non possiamo più perdere tempo. Governi, imprese e organizzazioni dovrebbero seriamente cambiare visione e modificare il proprio operato, senza nascondersi dietro menzogne e greenwashing. Come sottolineato da Achim Steiner, amministratore dell’United Nations Development Programme (UNDP). «Mentre le condizioni meteorologiche estreme colpiscono con crescente ferocia – tra cui devastanti siccità, inondazioni e ondate di caldo – l’impronta digitale del cambiamento climatico è evidente in ogni angolo del globo. Non c’è dubbio che la salute delle persone e del pianeta dipende ora da un’azione politica decisiva. Questo è il duro messaggio alla base dell’ultimo rapporto IPCC dell’Onu per la valutazione della scienza relativa al cambiamento climatico, che ha fornito la valutazione più completa del cambiamento climatico negli ultimi 9 anni».
La COP27 e la perdita di foreste. Le imprese proseguono con il greenwashing
Durante i negoziati dell’ONU sul clima (COP27), i capi di 26 paesi e l’Unione Europea hanno creato la partnership Forests and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) con l’obiettivo di fermare e invertire la perdita di foreste e il degrado dei territori entro il 2030, in linea con l’impegno preso alla COP26 di Glasgow. Nel corso degli ultimi 60 anni, le foreste del pianeta sono diminuite dal 1,4 all’0,5 ettari per persona. La perdita di foreste non solo mette a rischio la vita di numerose specie animali e disturba gli ecosistemi, ma riduce anche la capacità di ripresa delle foreste stesse dopo eventi come siccità e disboscamento. La FCLP, presieduta dagli Stati Uniti e dal Ghana, mira a collaborare per realizzare gli impegni di Glasgow, aumentare l’ambizione e trovare soluzioni innovative ai problemi in corso. I governi hanno promesso di spendere 12 miliardi di dollari nell’arco di 5 anni per proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste, di cui 2,67 miliardi di dollari sono stati già spesi dai donatori pubblici. Inoltre, i donatori pubblici e privati si sono impegnati a mobilitare altri 4,5 miliardi di dollari per sostenere questi sforzi. La FCLP si concentra su sei aree d’intervento, tra cui il controllo degli impegni finanziari e la fermata dei progetti distruttivi per le foreste, l’aumento dei finanziamenti con impatto positivo sull’ambiente, il supporto alle popolazioni indigene, e il rafforzamento dei mercati del carbonio per consentire ai Paesi “polmone verde” di raggiungere i propri obiettivi climatici. Alcuni paesi hanno annunciato impegni ancora più ambiziosi, come la Germania che raddoppierà i fondi per la protezione delle foreste nei prossimi tre anni e il Regno Unito che dedicherà 1,5 miliardi di sterline alla protezione delle foreste nei prossimi 5 anni, di cui un quarto andrà alla protezione della foresta in Indonesia e un altro quarto all’Amazzonia. La nuova leadership del Brasile ha ricevuto un’approvazione positiva dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz e l’inviato speciale del clima degli Stati Uniti John Kerry.
Molte grandi aziende in tutto il mondo dicono di aver preso posizione per proteggere le foreste, ma la loro comunicazione corrisponde ad azioni concrete? Due colossi del mercato globale come Uniliver e Ikea sono stati coinvolti in inchieste che le accusavano di greenwashing. Secondo un report condotto da Reuters, Unilever, che affermava di voler raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo “deforestazione zero” per quattro materie prime: olio di palma, soia, carne, carta e cartone, ha poi invece promosso l’utilizzo di bustine monouso di plastica per i suoi prodotti in paesi in via di sviluppo. Queste bustine hanno avuto un impatto devastante sull’ambiente, causando la distruzione di corsi d’acqua e vari ecosistemi. L’azienda sostiene di avere un impianto di riciclaggio in Indonesia, ma sembra che sia stato abbandonato. Per quanto riguarda Ikea, la vicenda appare più complessa. La foresta rumena, che è considerata il polmone dell’Europa, è a rischio di scomparsa a causa del disboscamento illegale, e secondo un reportage pubblicato su The New Republic, Ikea sarebbe complice di questo fenomeno. Nonostante il paese abbia resistito alla deforestazione dell’era industriale, Ikea sta contribuendo alla sua scomparsa con i suoi mobili low cost. L’organizzazione ambientalista rumena Agent Green ha denunciato Ikea per aver commesso irregolarità nella gestione delle foreste rumene e ottenuto vantaggi dal mercato illegale di legname. Sono state mostrate prove fotografiche che l’azienda stava tagliando illegalmente le foreste secolari senza autorizzazione. Ikea ha risposto alle accuse dichiarando che oltre il 98% del suo legname viene raccolto in modo sostenibile, riciclato o certificato dal Forest Stewardship Council. L’azienda afferma che non accetta legno tagliato illegalmente e ha implementato un sistema completo di due diligence che prevede requisiti rigorosi per la documentazione dell’origine del legno, un team di specialisti dell’approvvigionamento e della silvicoltura che esegue più di 200 audit all’anno e revisori terzi che controllano la catena di approvvigionamento con particolare attenzione ai paesi ad alto rischio. Inoltre, l’azienda utilizza anche la certificazione Fsc come ulteriore misura di sicurezza. Chi invece sembra essere sicuramente in grado di ottenere risultati concreti sembra essere Patagonia: un’azienda americana di abbigliamento outdoor che si è impegnata a utilizzare solo fibre di origine sostenibile nei propri prodotti, incluse fibre provenienti da foreste certificate FSC (Forest Stewardship Council). Inoltre, l’azienda ha anche lanciato il suo programma di “Footprint Chronicles”, che traccia l’impatto ambientale di ogni prodotto dal punto di vista delle emissioni di CO2, del consumo di acqua e della sostenibilità delle fibre utilizzate. Patagonia è stata una delle prime aziende a utilizzare fibre riciclate e di origine sostenibile nei suoi prodotti e questo le ha permesso di differenziarsi dalla concorrenza, attirando una clientela sempre più attenta all’impatto ambientale delle proprie scelte di acquisto.
La Conferenza delle Nazioni Unite e le crisi legate all’acqua
L’acqua è una risorsa naturale preziosa e vitale per la vita sulla Terra. Tuttavia, il suo utilizzo eccessivo e non sostenibile da parte dell’uomo stanno mettendo a rischio la disponibilità di acqua dolce per le generazioni future.
Sul tema interverrà La Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua (UN 2023 Water Conference) che si terrà a New York dal 22 al 24 marzo, in occasione della 31a Giornata Mondiale dell’Acqua. In vista dell’evento, le maggiori organizzazioni sovranazionali hanno espresso preoccupazioni riguardo alle crisi legate all’acqua. Secondo l’UNICEF, circa 190 milioni di bambini in 10 Paesi africani sono a rischio a causa di tre minacce legate all’acqua, quali la mancanza di acqua per servizi igienici inadeguati, malattie correlate alla scarsità di acqua e rischi climatici legati alla siccità. L’UNICEF ha chiesto investimenti urgenti in servizi idrici e igienici resilienti al clima per proteggere i bambini. L’Africa occidentale e centrale è una delle regioni più colpite dalla scarsità idrica e impatto climatico al mondo, con molti dei Paesi colpiti che sono anche alle prese con instabilità e conflitti armati, aggravando ulteriormente l’accesso dei bambini all’acqua potabile e ai servizi igienici. La FAO ha avvertito che la scarsità d’acqua minaccia la sicurezza alimentare e la nutrizione, poiché significa meno acqua per la produzione agricola e, di conseguenza, meno cibo disponibile. La Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua 2023 è vista come un momento epocale per risolvere la crisi idrica nel mondo. Earth Day Italia, in collaborazione con Impatta e il CREA, organizzerà un digital talk dal titolo “Più cibo con meno acqua” il 22 marzo per discutere di un’agricoltura più resiliente e sostenibile.
È noto che le aziende siano grandi consumatrici di acqua, specialmente in determinati settori come per i prodotti chimici, gomma e materie plastiche, siderurgia e metalli di base. Ma è possibile fare impresa e allo stesso tempo preoccuparsi di non sprecare più del dovuto? Financialounge ha riportato una ricerca di David Smith, senior investment director di abrdn, in cui si individuano le aziende più virtuose che stanno cercando di gestire al meglio le risorse idriche. La gestione efficiente dell’acqua è diventata un vantaggio competitivo nel settore dei semiconduttori, dove si richiedono enormi volumi di acqua ultrapura. David Smith cita la Taiwan Manufactoring Company di Taiwan come azienda virtuosa “capace di riutilizzare ogni goccia d’acqua almeno 3,5 volte nelle sue fabbriche”, e aggiunge che “nel 2020 ha riciclato l’86,4% dell’acqua usata, circa 173,0 milioni di tonnellate metriche di acqua”. Anche le aziende fotovoltaiche stanno cercando di ridurre il consumo di acqua, utilizzando robot per pulire i pannelli solari a secco. L’industria del cemento è una delle maggiori consumatrici di acqua, diventando importante gestirla in modo efficiente per evitare inutili sprechi. Alcune aziende come Ultra Tech Cement stanno cercando di diventare “Net Water Positive” entro il 2024 reintegrando quasi quattro volte l’acqua utilizzata.
Fare impresa ed essere etici conviene, la Harvard Business School lo conferma
È fondamentale evidenziare che inserire nella gestione aziendale preoccupazioni di carattere etico non significa dover fare rinunce in termini di fatturato e valore finanziario. Anzi, sono diversi gli studi che sottolineano come questo tipo di modello possa portare vantaggi tangibili e misurabili per le aziende. All’interno de Il Reputation Management spiegato semplice, di Luca Poma e Giorgia Grandoni, edito da Celid, è riportata una ricerca longitudinale condotta dalla Harvard Business School del 2012 di Robert Eccles, professore di Management Practice nell’Unità di Comportamento organizzativo, coadiuvato da George Serafeim, professore di Business Administration e Management presso la stessa università, ha dimostrato come in realtà possa a tutti gli effetti aumentare la redditività dell’impresa.
I ricercatori hanno esaminato un campione di complessive centottanta aziende, novanta delle quali sono state classificate come imprese “ad alta sostenibilità” – quindi con percorsi e progetti di responsabilità sociale strutturati e attivi – e novanta al contrario come imprese “a bassa sostenibilità”, fortemente marketing-oriented, ovvero senza alcuna particolare sensibilità sotto il profilo etico.
Obiettivo della ricerca era di esaminare le organizzazioni monitorate per quanto concerne la governance, la cultura d’impresa e soprattutto le prestazioni alla luce dell’introduzione di strategie e preoccupazioni di carattere etico nella loro attività.
I risultati di ben diciotto anni di osservazione hanno mostrato un esito precedentemente solo intuito da molti addetti ai lavori: le imprese ad alta sostenibilità sovra-performano – sia sotto il profilo dei risultati contabili che di quelli di borsa – rispetto a quelle prive di questo genere di sensibilità.
Si infrange quindi una volta per tutte contro il muro della ricerca scientifica l’equivoco che ha condizionato i consigli di amministrazione per decenni, ovvero “o dimostriamo sensibilità etica o distribuiamo dividendi”: nulla di più falso, la scienza ci dimostra che per distribuire più dividendi dobbiamo essere etici.
La ricerca suggerisce però – com’è giusto e prevedibile, trattandosi di processi che incidono sul dna stesso delle organizzazioni – che questa “sovra-performance” si verifichi solo nel lungo periodo: i gestori e gli investitori che sperano di ottenere un vantaggio competitivo nel brevissimo o breve periodo hanno quindi scarse probabilità di successo, se pensano di inserire la sostenibilità come keyword nella strategia della propria organizzazione senza però avviare cambiamenti strutturali nell’azienda stessa e poi nel modo che essa ha di raccontarsi. In definitiva, sono le politiche aziendali di alta sostenibilità che devono inevitabilmente riflettere la cultura di fondo dell’organizzazione, e non la cultura dell’organizzazione che deve essere “piegata” al servizio della CSR al fine di darsi una “mano di verde” per apparire più “green” e più appetibili agli occhi di consumatori e investitori.