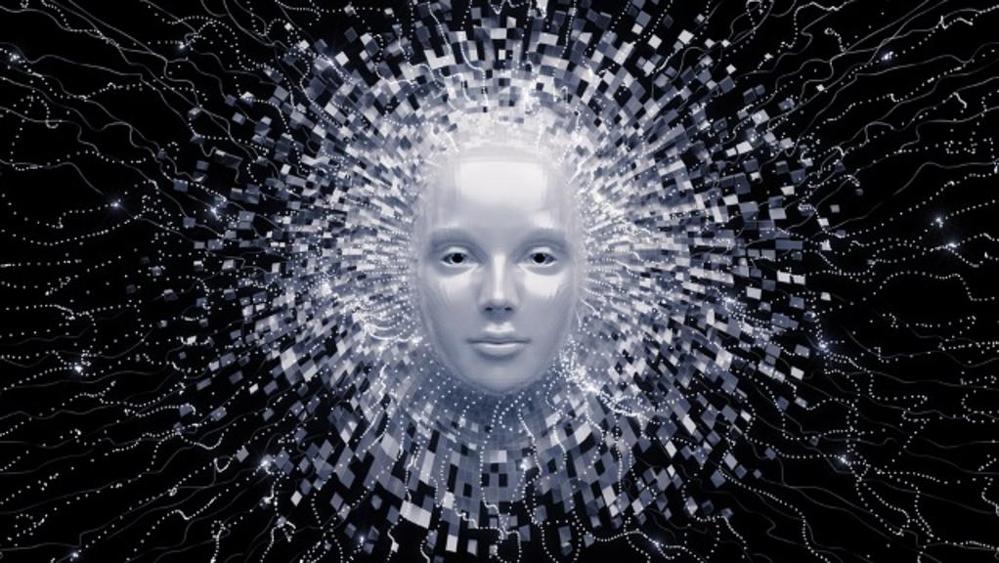La lezione di Shell a chi sottovaluta la Csr

DALLA FIGURACCIA BRENT SPAR A UNO DEI PRIMI IMPEGNI ETICI MESSI PER ISCRITTO DA UNA GRANDE AZIENDA: LA LEZIONE DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI SHELL
Corporate social responsibility: il caso Shell. Incredibile ma vero, il colosso petrolifero Shell è stata un pioniere della Csr nel mondo aziendale, ancor di più nel settore dei combustili fossili. Shell infatti ha sottoscritto uno dei primi impegni scritti di impegno etico per il rispetto dell’ambiente. Ma come nasce questo impegno? Da una figuraccia, che porta il nome di Brent Spar.
Corporate social responsibility: il caso Shell
L’impegno nella corporate social responsibility di Shell è indissolubilmente legato a questa piattaforma petrolifera, la Brent Spar, che ha chiuso il suo ciclo di vita nel 1995. Chissà quanti ricorderanno le proteste che partirono in quel momento, in seguito alla decisione di Shell di affondare la struttura a 150 miglia al largo delle coste delle coste scozzesi, in un fondale di 2.000 metri. Attenzione, quella era ritenuta la scelta non solo più economica, ma anche più sicura dal punto di vista ambientale.
Gli attivisti di Greenpeace non erano d’accordo e iniziarono a protestare tentando anche l’assalto alla piattaforma, dalla quale vennero respinti con i getti dei cannoni d’acqua. La scena, trasmessa dalle tv di tutto il mondo, fece scalpore. Gli ambientalisti proponevano lo smantellamento sulla terraferma, recuperando i residui petroliferi contenuti nelle cisterne e riciclando le struttura metallica per evitare la dispersione di metalli pesanti e carburante (anche se poi si scoprì che i dati erano pesantemente inesatti). Per contro, la Shell sosteneva che la demolizione a terra sarebbe stata più pericolosa, dannosa per l’ambiente e soprattutto molto più costosa.
Le proteste per la Brent Spar
A maggio del 1995, la piattaforma Brent Spar, scortata da una nave da guerra britannica e da tre navi della compagnia petrolifera, comincia ad essere rimorchiata verso il punto definito per l’affondamento. Ma la protesta era partita in tutto il mondo: in Germania e Paesi Bassi gli automobilisti boicottavano le stazioni di servizio della Shell (si perse fino al 20% del giro d’affari), seguite da molte alte aziende. Persino Helmut Kohl fece pressioni per lo smantellamento. Alla fine gli attivisti di Greenpeace riuscirono a salire a bordo e a incatenarsi alla piattaforma.
Nonostante il governo britannico rimanesse fermo sulla propria decisione, alla fine Shell decise che la propria posizione non era più difendibile e rinunciò al proposito di affondare la Brent Spar. «La posizione della Shell come grande impresa europea è diventata insostenibile. La Spar ha acquisito un significato simbolico del tutto sproporzionato al suo impatto ambientale. Per conseguenza, le società del gruppo Shell hanno dovuto affrontare critiche di dominio pubblico sempre più intense, soprattutto nell’Europa continentale settentrionale. Molti politici e ministri sono stati apertamente ostili e molti hanno fatto appello al boicottaggio da parte dei consumatori. C’è stata violenza contro le stazioni di servizio Shell, accompagnato da minacce nei confronti del personale della Shell», fu la nota emessa dalla società.
L’impegno per l’ambiente
Proprio dalle proteste per la Brent Spar è nato l’impegno nella corporate social responsibility di Shell che di lì a poco pubblicò il primo rapporto di sostenibilità nella storia della compagnia anglo-olandese. Nel frattempo, la convenzione OSPAR, ratificata nel 1998, prevede che tutte le piattaforme del mare del Nord debbano essere smantellate sull’esempio della Brent Spar (smantellata poi in Norvegia). «La Brent Spar ha modificato il nostro punto di vista. La Spar non costituisce, come molti ritengono, una minaccia ambientale, ma resterà nella storia come un simbolo dell’incapacità dell’industria di relazionarsi con il mondo esterno», commentò Heinz Rothermund, amministratore delegato della Shell UK exploration).
Rothemund riconobbe che la Shell non aveva preso in considerazione l’effetto delle proprie azioni sull’opinione pubblica, cosa che in futuro avrebbe sempre dovuto fare. Alla Shell conclusero che quanto era avvenuto avrebbe potuto ripetersi e che bisognava prendere decisioni in altro modo. Dovette inoltre accettare che molti non erano disposti a credere alle dichiarazioni che faceva sul proprio modo di agire in campo ambientale. «Vogliamo che in futuro le nostre azioni mostrino che gli interessi fondamentali delle imprese e della società sono del tutto compatibili; che non è necessario scegliere tra profitti e principi», concluse Cor Herckstroter, allora presidente del comitato degli amministratori.
Il principio dell’impegno
Un’altra conseguenza dell’affare Brent Spar fu che Shell sposò il principio dell’impegno, il che significava coinvolgere nelle proprie decisioni organizzazioni diverse ed esterne all’azienda. Tali organizzazioni esterne non hanno un’autorità ufficiale sulle decisioni che la Shell stabilisce di prendere ma esercitano una forte influenza, poiché la Shell ascolta attentamente le loro opinioni.
In un articolo scritto dieci anni dopo la vicenda di Brent Spar, il presidente della Shell UK Jame Smith affermò: «Imparammo che per quanto essenziali scienza e approvazione governativa non sono sufficienti. Dovemmo impegnarci con la società, capire e rispondere alle preoccupazioni e alle aspettative della gente. Dobbiamo consultarci con loro per tempo e senza remore, pronti ad ascoltare e a cambiare. Dobbiamo ammettere gli errori e dimostrare che tentiamo di risistemare le cose e al contempo di imparare».