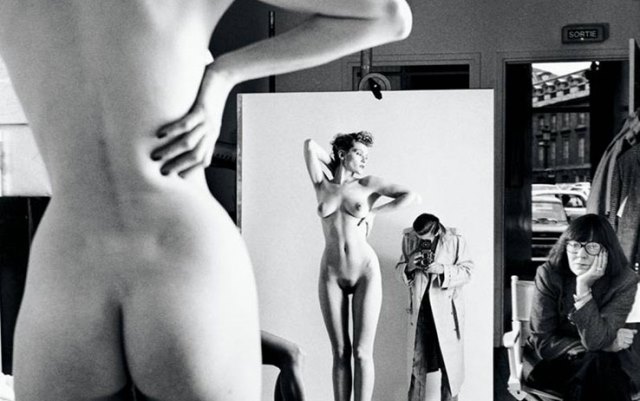Su ilLibraio.it un estratto da “La disputa felice. Dissentire (senza litigare) sui social network, sui media e in pubblico”, l’attualissima guida di Bruno Mastroianni
Bruno Mastroianni, filosofo e giornalista, è consulente per i social media de “La grande Storia” di Rai 3. Ricercatore e docente di Teoria generale della comunicazione, da sempre si occupa di comunicazione sui social network. Con l’aiuto dei migliori principi della retorica, del media training e della comunicazione di crisi, nel suo ultimo libro
La disputa felice. Dissentire (senza litigare) sui social network, sui media e in pubblico offre
una guida sintetica per imparare a sostenere il proprio punto di vista davanti all’altro che non è d’accordo: senza giungere allo scontro ma nemmeno arrendersi alla cortesia diplomatica, all’asettico “politically correct”. Ne proponiamo un brano, per gentile concessione della casa editrice Franco Cesati.

Nella discussione sui social, la maggior parte delle volte, il livello dell’incomprensione non è tanto nei contenuti in sé ma nelle differenze tra i modi di intendere la realtà degli interlocutori coinvolti.
L’ostilità, insomma, è un conflitto tra mondi che si riversa sulle persone: uno sente nelle affermazioni dell’altro la negazione di qualcosa in cui crede e che ha per lui valore intoccabile. Nelle discussioni accese accade qualcosa di simile a quello che succede nei confronti interreligiosi: quando si dialoga tra fedi, ciascun interlocutore sa bene che esiste una sfera – quella delle credenze della religione dell’altro – che non può essere messa in discussione, pena creare un effetto di mancanza di rispetto; occorre allora tenerla presente per discutere su altri aspetti, come le conseguenze sociali, morali, politiche, di quelle credenze. In tutti i casi di confronto tra visioni del mondo, la sfera delle certezze dell’altro è un punto di partenza da accettare, per trovare un terreno comune e divergere invece sulle scelte concrete.
[…]
Ci si fa capire quando si è se stessi. Ci si fraintende quando si impersona qualcosa: un ruolo, una posizione, una difesa di ufficio a nome di un gruppo, di una prospettiva culturale, politica o religiosa. Sembra una considerazione banale e invece è il centro del disputare con l’intento di farsi capire dall’altro. Anni fa uscì un testo dal titolo quanto mai efficace:
You Are the Message, ‘tu sei il messaggio’; ecco, oggi siamo ancora lì: essere se stessi davanti agli altri è l’unica via per poter stabilire una relazione autentica, unico modo perché si abbia una vera comunicazione. Comunicare, infatti, è possibile solo a partire da una interazione tra due o più soggetti che si riconoscono e si presentano per come sono veramente e quindi reciprocamente accessibili. Conoscersi è farsi riconoscere dall’altro e riconoscere l’altro.
Essere se stessi vuol dire affidarsi alle proprie risorse di comunicazione.
Vuol dire fuggire da proiezioni superbe della propria competenza, delle proprie capacità, della bontà dei propri argomenti. Quando uno entra nell’ottica di essere semplicemente se stesso, di solito riesce a essere interessante e comprensibile. Spesso quando interveniamo in dibattiti pubblici sentiamo crescere un senso di rivalsa e ci lasciamo andare all’aggressività, alla spocchia, alle prevaricazioni sull’altro, per avere ragione. Sui social tale effetto si accentua: il leone da tastiera che è dentro di noi si fa sentire perché scrivere guardando uno schermo può far dimenticare che dall’altro lato c’è un’altra persona che legge. Si crea quindi un effetto psicologico simile a quello dell’anonimato che, grazie alla distanza, accentua le reazioni e allenta i freni inibitori.
È un modo di procedere che compromette la comprensione. In quei momenti invece, presentarsi per quello che si è può dare fiato alla discussione. Al leone che crediamo di essere va opposto il gattino che siamo in realtà. Facendo così non si perde autorevolezza nel confronto ma si guadagna (tra l’altro i gattini sul web sono uno dei contenuti che vanno per la maggiore).
Non percepirsi infallibili, non pensare di avere sempre e solo argomenti incontrovertibili, riconoscere quando l’altro è più convincente (per lo meno farlo dentro di sé), rende più autorevoli e apprezzabili.
Il clima da conversazione costante dei social ci richiama ad avere la mentalità di chi sa “pubblicare in bozza”: parlare e proporre temi ammettendo che ci sarà sempre qualcuno che ne sa di più e che, con le sue idee, potrà contribuire ad arricchire il pensiero.
Si tratta di:
-muoversi anzitutto dal proprio perimetro, attenersi a ciò che riteniamo vero perché vagliato personalmente;
-parlare solo se abbiamo davvero qualcosa da aggiungere a ciò che stanno dicendo gli altri;
-separare ciò che viene dalle nostre personali impressioni da ciò che è nei dati, nei fatti e negli argomenti fondati;
-non ripetere cose di altri non messe alla prova fino in fondo.
È uno sforzo di umiltà: tracciare il proprio perimetro realistico di competenza per esporre le proprie possibilità in modo sincero, esplicitando i propri pensieri, le proprie aspirazioni, i propri bisogni, senza trucchi. Sostanzialmente significa esporsi all’altro.
Chi aggredisce è perché di solito non vuole esporsi, non accetta i suoi limiti e quindi, per difendersi, fa quello che farebbe qualsiasi essere vivente di fronte al pericolo: si nasconde. Ci sono molti modi di nascondersi in una conversazione:
-dietro ai principi: ad esempio quando usiamo espressioni come “su questo tema non si può discutere perché è sbagliato in sé”, “la verità va difesa”, ecc.;
-dietro a un ruolo: “io insegno questa materia da 10 anni”, “io sono un professionista”, “io sono riconosciuto come…”, ecc.;
-dietro a un’autorità riconosciuta: “lo dice la Costituzione”, “lo dice il Vangelo”, “lo dice l’Europa”;
-dietro alle proprie reazioni emotive: “non voglio discutere con te perché quello che dici mi offende”.
Tutte strategie per frapporre qualcosa tra noi e l’altro che ci metta in una posizione più sicura che, non riguardando il merito del discorso, solleva dal doversi confrontare pienamente. Lo sforzo di essere se stessi, invece, fa rimanere sul tema circoscrivendo il proprio peso e ammettendo i propri limiti. Tra l’altro, ciò mette nelle condizioni di accettare i limiti dell’interlocutore nell’interazione.
Se uno è disposto a riconoscere la propria aggressività, l’amor proprio, la tendenza a prevaricare, la troverà accettabile e non così strana quando gli si presenterà da parte dell’altro. Ciò favorirà un clima più sereno nel disinnescare eventuali ostilità perché ci farà considerare la vulnerabilità da cui tutti siamo affetti al momento di confrontarci.
Questo sforzo di circoscrivere, ridurre e personalizzare è alla portata di tutti: chiunque può parlare per lo meno dal suo punto di vista. Chiunque, per il solo fatto di aver vissuto qualcosa o averlo sperimentato, ha diritto a prendere parola in modo rilevante sul tema.
Gran parte dei conflitti infatti non nasce tra le persone ma tra le differenze dei mondi da cui provengono le persone: atei discutono con religiosi, progressisti con conservatori, complottisti con scienziati rigorosi. Personalizzare è cercare di mantenere il confronto tra la persona che sta parlando e quella che risponde, senza far interferire in modo sproporzionato gli elementi di categoria, per rimanere il più possibile su ciò che si ha in comune (essere umani), al di là delle appartenenze che dividono.
La retorica sottolinea che l’autorevolezza di un discorso dipende soprattutto dal contenuto e dalle argomentazioni che si devono reggere in sé, il che è vero, ma va considerato che la cultura mediatica prima televisiva e poi digitale, nella dinamica “conversazionale” dei social network, ha di fatto spostato il peso sulla dimensione personale degli interlocutori. Esplicitare ciò che si pensa in prima persona e ciò che proviene dalla propria singolare esperienza è un punto di forza che facilita l’ascolto. È un segnale della propria buona volontà a procedere confrontandosi ad armi pari, dove ciascuno porta ciò che è suo, senza sentirsi in posizione preminente.
Quando ci si confronta, perfino quando si parla di questioni tecniche e specifiche, ciascuno è sempre disposto a entrare in relazione con l’uomo che c’è dietro le argomentazioni, i ruoli, le posizioni. […]
In aggiunta ci vuole un ingrediente di fondo che non può mai mancare quando ci si confronta: il senso comune. Il lavoro di rielaborazione dovrà il più possibile fare riferimento solo a ciò che può essere riconosciuto universalmente.
Tutte le fonti autorevoli classiche (il diritto, la letteratura scientifica in generale, le tradizioni, il catechismo, i libri sacri e religiosi) non sono spendibili di per sé, giacché la loro autorevolezza presuppone un accordo previo da parte dell’interlocutore. Per alcuni sono completamente discutibili, per altri possono essere persino motivo di opposizione pregiudiziale per il solo fatto di essere nominate: ad esempio per un non credente il catechismo, per un anarchico la costituzione, per un complottista la scienza, e così via.
Lo sforzo che occorre fare è allora quello di usare sempre argomenti razionali e di uso quotidiano per presentare le proprie posizioni. Non si tratta di congedare la cultura, la scienza o altre discipline assodate, ma di accettare di ricominciare da capo per convincere chi parte da punti di vista di rifiuto.
Occorre accettare, in ogni momento,
di farsi carico dell’onere della prova davanti agli altri e non rifiutare nessuna delle obiezioni, anche quando si parla di cose assodate: ogni rilievo espresso in termini razionali è degno di risposta, ogni affermazione ha bisogno di essere comprovata da fatti, dati e ragionamenti. Quando ci si confronta pubblicamente, nessuno può sentirsi in una posizione di rendita dovuta al suo ruolo, alla sua popolarità o alla sua condizione sociale. La presenza di opposizione è il motore del discorso: deve far articolare più a fondo il ragionamento.
[…] Il criterio del senso comune presuppone insomma che si sia disponibili a riaprire le questioni ogni volta che sia necessario. Se ci sono nuovi elementi, vanno considerati nel rivedere il ragionamento. Se c’è bisogno di ripetere perché qualcuno è arrivato dopo o non ha seguito tutto il percorso, va fatto. Se un’incomprensione ha viziato la procedura, è necessario fare qualche passo indietro per ritornare ad affrontarla. Il criterio del senso comune si riallaccia poi anche alla presenza della maggioranza silenziosa di cui abbiamo parlato: se si è sui social o in un luogo aperto, se si è in una conferenza e si parla a più persone, così come quando si è intervistati dai media, occorre tenere presente quelli che ascoltano anche se non direttamente coinvolti. È uno sforzo simile a quello che fa chiunque scrive un testo: deve potersi immaginare chi leggerà e le sue reazioni per potersi esprimere al meglio. Questa moltitudine, che immette inevitabilmente un elemento di pluralità in ogni confronto, ha bisogno di essere tenuta in considerazione: lo sforzo per esprimere idee e argomenti semplici, che non danno nulla per scontato e comprensibili alle persone comuni, va in direzione di farsi capire dai molti che ascoltano e leggono in silenzio.
Infine occorre ripetere, ribadire, argomentare da capo, come fosse sempre la prima volta. Tutte dinamiche che sono ormai vita quotidiana sul web e sui social, giacché non tutti si prendono la briga di leggere i commenti di una discussione o lo storico di post precedenti prima di intervenire su un punto…
(continua in libreria…)