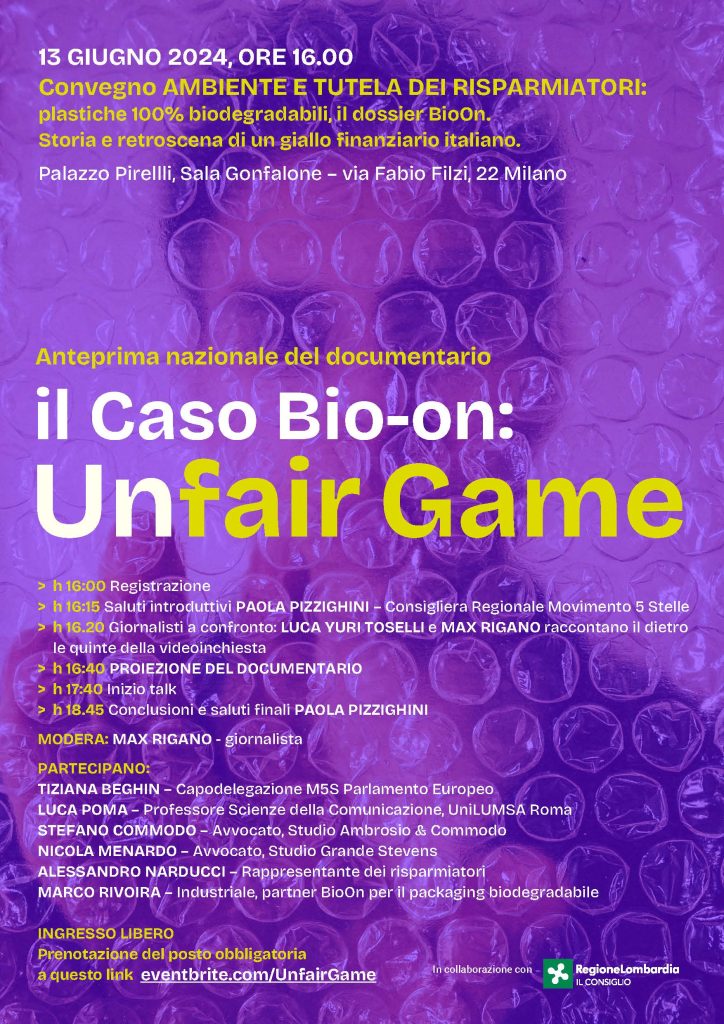A quasi sei mesi dalla multa dell’Antitrust e dalle indagini sul caso Pandoro-gate che hanno investito Chiara Ferragni e le sue società, Selvaggia Lucarelli pubblica Il Vaso di Pandoro, libro-inchiesta che ripercorre dagli esordi l’ascesa e la caduta della influencer e del suo mondo.
Il libro è un’esamina socio-culturale che evidenzia il grande ruolo dei media, non solo dei social media ma anche dell’informazione tutta, nella creazione del personaggio Ferragni quale imprenditrice di successo e simbolo di empowerment femminile dedito alle cause sociali e alla beneficenza. Nulla di più distante dalla realtà dei fatti che è emersa a partire solo dallo scorso dicembre, nonostante vi fossero dei prodromi da anni:
- 2016: annuncio progetto charity per terremoto nelle Marche, mai finalizzato;
- 2017: Soleterre per il diritto alla salute dei bambini, con lancio su account Depop per cui era pagata (#adv) e con ricavato poco più di 4.000 euro;
- 2019: bambola Trudi e ricavato in favore di Stomp Out Bullying, ad oggi oggetto di indagine da parte della Procura di Milano;
- 2020: beneficenza e advertising insieme per linea abbigliamento e biscotti Oreo;
- 2021: donazione per ospedale Buzzi attraverso vendita su Wallapop, da cui è pagata (#adv).
Questi sono stati ignorati a beneficio di uno storytelling compiacente e succube dell’enorme bolla di benevolenza mediatica che ha sempre circondato Ferragni.
Ed è questa bolla che ha permesso all’influencer di creare un impero valutato 75 milioni di euro (giugno 2023). Ma su quali basi si fondava, e come veniva gestito tanto successo? Fragilità manageriale, impreparazione e una certa dose di prepotenza mista a cinismo sembrano essere i canoni che hanno contraddistinto negli anni il “sistema Ferragni” e che sono emersi grazie alla crisi, alle indagini giornalistiche e alle testimonianze dei dipendenti.
Di questa vicenda è interessante analizzare alcuni aspetti e alcune anomalie, utili a comprendere delle dinamiche che possono investire qualsiasi brand o azienda.
Arretratezza digital
Il digital si trasforma e si evolve costantemente. Cambiano tendenze, modi e usi delle piattaforme, mentre ne nascono delle nuove dettate da regole comportamentali e di engagement sempre diverse. Come sottolineato da Serena Mazzini (esperta di social media manager intervistata da Lucarelli NdR), Ferragni è un brand che non si è saputo evolvere perché è rimasto ancorato alle logiche del primo Instagram e fatica a entrare in quelle di TikTok, dove vince il contentainment (funzionano i contenuti coinvolgenti per il pubblico, non le mere foto NdR). Mazzini continua spiegando che gli utenti non sono più interessati a modelli aspirazioni da seguire o all’ostentazione del lusso, ma si rivolgono ai social come a dei “piccoli schermi televisivi nei quali specchiarsi e nei quali cercare, spesso, compagnia o confronto diretto”.
Cosa significa questo per la strategia di comunicazione di un brand? Che deve essa stessa evolvere e adattarsi ai nuovi paradigmi di comunicazione social, pena la perdita di pubblico e l’incapacità di attrarne di nuovo.
Impreparazione al ruolo
Intesa come la capacità di svolgere un ruolo aziendale grazie alla competenza (derivante anche da appropriati studi) e all’esperienza, non solo per attitudine e istinto personali, che senza dubbio sono importanti, ma non possono essere tutto. Oggi, troppo spesso, si affidano ruoli legati alla comunicazione, o anche al management, a persone, non a professionisti.
Ne è un esempio l’ufficio stampa Balocco, che si scopre essere stato la fonte di Lucarelli nel scoperchiare il vaso di Pandoro. A dicembre 2022, la giornalista contattò l’ufficio stampa per chiedere lumi sulla vicenda e fu proprio lo stesso a spiegare che fra Balocco e Ferragni vi era una sinergia commerciale finalizzata alle vendite e che la beneficenza era cosa distinta derivante solo da una donazione dell’azienda dolciaria.
Quando Lucarelli evidenziò il fatto che il Corriere (e tutti i principali quotidiani nazionali) avesse scritto “Ferragni e Balocco sostengono insieme l’ospedale…” e che quindi la comunicazione era ingannevole, l’ufficio stampa rispose che “ciò esulava dalle sue competenze”. I rapporti con i media, e quindi anche la richiesta di rettifiche, è parte integrante del lavoro di ufficio stampa. Lo si impara il giorno 1 di stage (e su qualsiasi manuale di relazioni pubbliche).
Altro esempio è la gestione familiare, scanzonata e a volte spregiudicata delle aziende TBS Crew e Chiara Ferragni Collection da parte di Fabio Maria Damato. Il general manager vanta un background come fashion editor per Class Editori e il Corriere, nonché come autore di testi di moda per Amica. Alla Bocconi frequenta il “corso di studi in economia” ma la laurea non è mai confermata dallo stesso. Sotto la direzione di Damato le aziende di Ferragni spiccheranno il volo e arriveranno ai fatturati milionari da sogno che tutte le testate di economia hanno raccontato.
L’intuizione è quella di far diventare Chiara Ferragni testimonial per grandi brand, in modo da ottimizzare risorse e profitti. E i profitti saranno clamorosi se si pensa che un brand di yogurt arriva a pagare 500/600.000 euro per alcuni post e storie. Si può contestare la spregiudicatezza con cui si decide di chiudere contratti con qualsiasi tipo di brand, perdendo di vista il posizionamento alto su cui aveva lavorato Ferragni negli anni, ma il ROI parla chiaro.
Il problema è che mentre aumentava il ROI, diminuiva la solidità delle aziende, a causa di politiche di licenziamenti di dipendenti storici a fronte di assunzioni familiari. La situazione lavorativa dei dipendenti non era da meglio. Lavoravano per stage sottopagati e stipendi da fame, se paragonati al costo della vita di Milano, oppure come finte partite Iva e sotto costante pressione psicologica. Una situazione del genere, che non può reggere al nascere della prima crepa, peggiora con la crisi quando di fatto i dipendenti vengono lasciati da soli a gestire le perquisizioni della guardia di finanza e tutto ciò che ne deriva.
Come accennato nell’articolo di dicembre, quella del Pandoro-gate è una crisi manageriale, non di comunicazione. Le pratiche messe in atto per “camuffare” la beneficenza sono una scelta che nell’inchiesta di Lucarelli trova solide testimonianze. Probabilmente il tutto è frutto davvero della mancanza di guida e di consulenza da parte di professionisti, mancanza che oggi ancora si sente in tutta la gestione post crisi e in quella delle scelte editoriali di Ferragni (come spiegato sopra).
Trasparenza del ROI digitale
Tutti i social media funzionano con algoritmi e secondo metriche precise che determinano la riuscita, o meno, di ogni azione intrapresa. Quando si fa un investimento nel digitale è fondamentale monitorare la campagna e i risultati, perché non sempre il pubblico risponde come atteso, e in questo caso è possibile cambiare strategia o contenuto. Questa semplice regola non è mai valsa per Ferragni, che stipulava contratti senza obbligo di insight, dove il contenuto (scritto e preparato dal team, poi postato dalla influencer) veniva deciso unilateralmente da Ferragni.
Gestione di crisi
Come ben evidenziato da Alberto Mattia (esperto di crisis management intervistato da Lucarelli), Chiara Ferragni è un “single point of failure”, ovvero un unicum che se diventa indisponibile per qualsiasi motivo decreta il fallimento delle sue aziende. È lei stessa con la sua vita, le sue scelte, i suoi outfit, i suoi figli e via dicendo, il perno sul quale si muovono le sue società di servizi (advertising) e prodotti (linee di abbigliamento e accessori). L’impreparazione al ruolo del/i manager di Ferragni evidenziata sopra, fa sì che l’inchiesta di dicembre 2022 e l’avvio delle indagini del successivo giugno, prima in Balocco e poi in TBS Crew e Fenice, vengano prese sottogamba. Non si ritiene opportuno dire qualcosa in merito o preparare una strategia atta a rispondere alle (eventuali) accuse e a preservare la reputazione aziendale.
Dopo la gestione fallimentare nei primi giorni della crisi, vengono assunti dei consulenti di comunicazione, ma ancora ad oggi non vi è da parte di Ferragni reale consapevolezza dell’accaduto, presa di coscienza, pentimento, volontà di risanare i rapporti con tutti gli stakeholder coinvolti. Probabilmente la scelta dei consulenti da parte di Ferragni non è stata la migliore, sarebbe stato meglio coinvolgere un professionista esperto di comunicazione di crisi nello specifico, ma soprattutto sarebbe stato meglio seguire quello che i consulenti (sicuramente) avevano suggerito in termini di azioni, tono di voce, posizionamento.
Alla luce di quanto evidenziato, è imprescindibile per ogni azienda scegliere personale formato e aggiornato sulle dinamiche di comunicazione e di mercato, anche se questo richiede un investimento importante, perché non sarà mai così importante come quello che si può perdere se il brand e l’azienda vengono lasciati in mano all’incompetenza e all’improvvisazione.